Ridateci l'Iri
di Bruno Casati
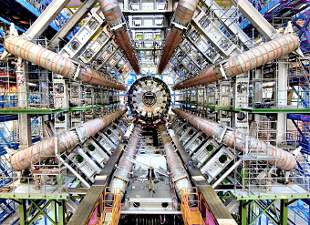 L’italia produttiva affonda. Per tenerla a galla non bastano più moda e turismo, ma nemmeno i “distrettini” del made in Italy che, senza una grande industria alle spalle, sono in sofferenza. Siamo alla desertificazione industriale: dal declino si è scivolati nel dissesto.
L’italia produttiva affonda. Per tenerla a galla non bastano più moda e turismo, ma nemmeno i “distrettini” del made in Italy che, senza una grande industria alle spalle, sono in sofferenza. Siamo alla desertificazione industriale: dal declino si è scivolati nel dissesto.
E nessuno si sogna di investire in Italia. I capitalisti italiani, da tempo, si sono eclissati. Quelli esteri, indifferenti rispetto al Jobs act, si guardano bene dal metterci i quattrini a rischio nel paese che, secondo l’autorevole classifica di Transparency international, è ormai il più corrotto d’Europa (e quella classifica non considerava gli scandali Expo, Mose e Mafia Capitale). Ora però è squadernato un ultimo caso di crisi industriale, quello dell’Ilva di Taranto o, se si vuole, dell’acciaio italiano, che, per la sua rilevanza materiale e simbolica, costringe anche gli indifferenti che ci governano a metterci la faccia.
Perché l’Ilva è diventata un mistero doloroso, visto che, pur passata di mano da un manager ottantenne come Bondi a uno più giovane come Gnudi, continua comunque ad affondare inesorabilmente e in un silenzio tombale. ora questo silenzio viene rotto, all’unisono, dal segretario generale della Fiom e dal Presidente del Consiglio. Pare dicano le stesse cose, ma non è così.
Sostiene Maurizio Landini: “Se non si vuole svendere o regalare la siderurgia agli stranieri è necessario che lo Stato faccia la sua parte… l’Ilva deve cambiare proprietà. Per far questo c’è bisogno dello Stato”. Affermazione assolutamente pertinente, questa di Landini, alla quale, per amore della verità, vorremmo aggiungere solo due commenti. il primo riguarda lo Stato “che deve fare la sua parte” e va bene, soprattutto la deve fare per rovesciare la parte che lo Stato fece quando, qualche decennio fa, regalò Italsider alla famiglia Riva (l’acciaieria era ridotta in condizioni pietose), che , non incalzata da nessun governo, l’ha sfruttata portandola sino a farla implodere un paio di anni fa.
Il secondo commento riguarda anche il Sindacato, che ha le sue di responsabilità sulla crisi dell’acciaio italiano, soprattutto quando, a Terni, non si oppose al trasferimento in Germania delle lavorazioni pregiate. Oggi, è vero, a Terni si è sottoscritto un accordo di sopravvivenza, ma il danno industriale è fatto. E la qualità è andata altrove. nessuno sull’acciaio (e altro) è esente da colpe, salvo i lavoratori che, ogni tanto, alzano la voce e si prendono le manganellate.
Ma, si diceva, che anche Matteo Renzi parla dell’Ilva, noi crediamo perché più preoccupato della perdita di consenso, che potrebbe registrare nel territorio (le elezioni in Puglia si avvicinano), che non del futuro dello stabilimento.
Coltivasse questa seconda preoccupazione dovrebbe guardare anche a Piombino dove, anche qui, c’è un accordo di programma, ma si è cancellato il Polo siderurgico, e quindi, le colate a caldo non ci saranno più. Continua la contrattazione dell’arretramento, ma oggi gli spazi per arretrare ancora non ci sono più. Ma torniamo a Renzi che, finalmente, parla di industria e, colpo di teatro, parla addirittura di nazionalizzazione dell’Ilva. Abbiamo sentito bene? ha detto proprio nazionalizzazione come quella, per capirci, che generò l’Enel nel lontano 1962, ai tempi quindi di Togliatti e di Fanfani e… del gettone telefonico?
Forse, noi così lo interpretiamo, lui, così glamour e innovativo da ignorare il passato “vintage”, forse voleva dire che se l’Ilva così com’è non se la fila nessuno (ed è vero), forse sarebbe bene che lo Stato ne assumesse la gestione diretta per risanarla, ridimensionarla, orientarla su produzioni competitive, per poi, snellita e ripulita con i soldi dei contribuenti, ri-offrirla sul mercato.
Ma questa non è una nazionalizzazione, ma solo la riproposizione di un vecchio mito secondo cui lo Stato serve solo per aggiustare, con soldi pubblici, le falle del sistema di mercato, insomma lo Stato come officina di riparazione dei guasti prodotti dai padroni.
In sintesi quella di Renzi sarebbe una socializzazione delle perdite per poi ripristinare la macchina della privatizzazione dei successivi guadagni. Considerando pure questa ipotesi di “statizzazione a tempo determinato” si aprirebbero (per il governo) una contraddizione e una questione di fattibilità relativa agli strumenti attuativi.
La contraddizione risiede nel fatto che simile operazione andrebbe in direzione opposta a quella imboccata, sulle privatizzazioni, un quarto di secolo fa. Strada praticata anni fa dal pragmatico Bersani delle lenzuolate e oggi ricalpestata da questo governo che si propone di mettere all’asta anche le Poste e le Ferrovie. Ed allora si vedrà, come del resto si è già visto con Enel ed Eni, che chi ha fatto un passo indietro riguardo agli investimenti industriali in Italia, ne farà due avanti per mettere mano su asset strategici come le reti appunto e l’energia.
“Meno stato più mercato”, pontificano i tromboni a libro paga di chissà chi, solo che esce lo Stato italiano ed entra, ad esempio all’enel, quello cinese, ma guarda un pò!
Oltretutto è una strada, questa, lastricata di errori, quelli consumati e quelli annunciati. È stato infatti un flop clamoroso già il collocamento Fincantieri, dovuto soprattutto all’indefinitezza strategica che non ha convinto i mercati. E si insiste, perché sarebbe un errore grave quello di voler sottrarre il valore aggiunto Ansaldo (così vuole Moretti) dall’asset strategico Finmeccanica. Così facendo ci si muove nel campo della riproduzione del danno fatto con Telecom, dove la prima conseguenza della privatizzazione è stato il taglio degli investimenti. La sintesi che si può trarre è brutalmente semplice: più si privatizza, più il paese dilapida il suo sapere e pregiudica il suo futuro. E non si dimentichi la fine dell’Alfa Romeo decisa dalla Fiat.
Landini lo sa, Renzi se ne frega. C’era poi la questione non irrilevante degli strumenti attuativi di cui oggi lo stato dispone. Che sono due: il Fondo Strategico Nazionale e la Banca Depositi e Prestiti (BdP) che, per la legislazione europea, non possono entrare nel capitale di aziende in perdita. Sono strumenti importanti, però usati impropriamente. La BdP ad esempio che, stando alla sua pubblicità che oggi inonda i quotidiani, ha investito 100 miliardi di euro in cinque anni (sono i risparmi degli italiani depositati alle Poste, avendone in cambio un servizio fatiscente), li ha indirizzati verso le strade, le infrastrutture e il sostegno alle imprese. BdP non è una Banca d’affari, ma sta funzionando come tale, funziona in pratica come un Bancomat per gli amici, al quale hanno attinto a piene mani Telecom e, appunto, l’Ilva dei Riva, con i risultati devastanti sotto gli occhi di tutti.
Avanti così: ma negli Usa simili operazioni a fondo perduto non sarebbero nemmeno pensabili. Gli Usa, che sono il paese in cui lo Stato ha un ruolo di orientamento, sostegno, controllo delle sue imprese superiore, si sappia, a quello in atto in Europa compresa la Germania, avrebbero forse dato un prestito a una loro Ilva ma, poi, avrebbero verificato se i dollari sono andati a buon fine in investimenti o invece, come succede qui, finiti nei dividendi per gli azionisti.
Insomma, questi strumenti funzionano solo se un Governo, assennato e autorevole, offre alle imprese una visione strategica in cui riversare un prestito, che poi controllano nei suoi stati d’avanzamento, e negli Usa non si scherza. Non funzionano altrimenti, come già non funzionava l’Iri, dagli anni ‘80 in poi che, si ricordi, aveva in portafoglio proprio la siderurgia e l’elettromeccanica, oltre all’Alfa, ma le ha portate a operare in una condizione di mercato protetto su standard economici e di qualità che poi non hanno retto all’apertura internazionale del mercati.
La Siderurgia pubblica è stata così regalata, mentre i dirigenti dell’elettromeccanica sono stati messi sotto accusa dalla magistratura per le tangenti devolute a Dc, Psi e anche Pci.
Acqua passata? non pare proprio. In questo contesto di dissesto senza reazione in controtendenza, assume un senso compiuto l’invocazione “ridateci l’Iri”, da intendersi come l’attualizzazione ai giorni nostri (i giorni dell’iPhone) dello spirito del tempo in cui l’uscita italiana dalla grande depressione fu guidata dalla geniale intuizione di Alberto Beneduce che, nel 1933, inventò l’Istituto per la Ricostruzione Industriale, l’Iri appunto, circondandosi di giovani intelligenti ed integri.
Le grandi idee che camminavano con le persone giuste e motivate. Già allora, in quei tempi grami, prendeva corpo l’idea dello Stato Imprenditore e dello “Stato Innovatore”, come recita oggi un bel libro di Mariana Mazzucato che, finalmente, torna a rimettere in circolazione termini abbandonati come programmazione, pianificazione, controllo.
Perché, crediamo, sia proprio il momento (in verità si è accumulato uno spaventoso ritardo inseguendo chimere) di recuperare, ripetiamo, attualizzando, la storia ricca dell’industria italiana che, dal 1880, ha retto sulla complementarietà tra il settore pubblico e quello privato, sfatando l’ideologia, una delle chimere, secondo cui è il privato che innova ed è lo stato che frena. Non è così.
E lo dimostra la storia stessa dell’industria italiana che attraversa, riconvertendosi, due grandi guerre fino ad approdare sotto l’egida dell’Iri, “all’economia mista” del secondo dopoguerra e ai “campioni industriali”, che campioni lo erano per davvero come l’Olivetti di Adriano, straordinaria fucina di scintillanti intelligenze – da Franco Fortini a Paolo Volponi sino a Luciano Gallino che distilla saggezza anche oggi - dove, primi nel mondo, si inventano i primi grandi calcolatori elettronici, i mainframe. Come la Montecatini, dove il nobel Giulio Natta inventa il propilene. Come il Cnen di Felice Ippolito o l’Eni, dove Enrico Mattei attorno all’idea pubblica di una autonomia in campo degli approvvigionamenti petroliferi (che gli costò la vita) seppe circondarsi di giovani, motivatissimi, quasi aggressivi.
Era lo spirito del tempo, quello che portò (mi permetto il ricordo personale) una generazione di ingegneri, tecnici e operai, nei primissimi anni sessanta a considerare un onore lavorare in un ente pubblico, come l’Enel, al servizio della comunità, piuttosto che non operare per il profitto di un padrone, anche se il padrone pagava di più. Nostalgia del ricordo? In Italia è così. Ma l’Italia è andata in fuori gioco.
Nel mondo industriale, quello che compete, le cose vanno in altra direzione e mentre i giovani laureati italiani vanno all’estero nella mitologia dell’Erasmus, i laureati migliori di altri paesi sono assunti nelle aziende statali, ripetiamo “statali”, che lavorano per fornire progetti industriali di eccellenza. Negli Usa vanno alla Darpa (tecnologie militari) e all’Arpa (scienze dell’energia), in Brasile alla Bndf, in Cina alla China Devolopement Bank.
E ci vanno con l’orgoglio, con l’onore (ricordate?) di lavorare in corpi d’elite, nelle industrie dell’avanguardia mondiale che sono dello Stato, perché negli Usa, si sappia, è lo Stato che investe nella Silicon Valley, c’è lo Stato dietro l’algoritmo di Google e la tecnologia del citatissimo iPhone.
Anche in Italia, se vogliamo, c’è un’isola non piccola di assoluta eccellenza pubblica (sono lo Itato italiano e quello francese che la sostengono, sempre meno in verità): ed è la creatura di Pasquale Pistorio, la ST Microelectronic, 10.000 supertecnici, collocati tra Vimercate e Catania.
Ma è, pur molto bella, un gioiello e un’eccezione, che però indica la via. Oggi, se si vuole girare pagina, bisogna “rifondare l’industria manifatturiera italiana” e la rifondazione, questa è la via , esige, esigeva ora come allora, la collaborazione tra Stato e impresa, con lo Stato che riassuma un ruolo guida, di coordinamento. Per essere più chiari bisogna avere il coraggio di rilevare come le forze del mercato, non essendo più in grado di assicurare magicamente lo sviluppo del capitalismo, rendano necessario l’intervento dello Stato, ma non “per curare il capitale malato” (come fa il Pd, Partito della Manutenzione del Capitalismo) ma per inserire primi elementi di un’altra economia, di altri consumi, di piena occupazione.
Lo Stato architetto-ingegnere di progetto, i privati gli attuatori. La storia ci insegna che quando era saldo questo rapporto di coppia Stato-impresa, l’Italia è sempre stata in condizione di agganciare le grandi innovazioni: dalle macchine a vapore, al motore a scoppio, dall’elettricità alla petrolchimica. Scollata la coppia, andata in crisi l’Iri (il garante della coppia) per la voracità della politica di un craxismo dirompente, si sono allineati solo mancati rendez-vous, falliti agganci con le innovazioni che via via si presentavano, dalla microelettronica alle telecomunicazioni.
Gli effetti oggi sono ben più gravi di quel che poteva misurarsi solo dieci anni fa, dovuti alla velocità impressionante che ha assunto la corsa delle tecnologia e a chi è uscito dalla corsa, come l’Italia, non è consentito rientrarvi.
Cosa si può fare allora, se c’è ancora qualcosa da fare, per almeno provarci a sfuggire alla condizione di colonia al traino di chi, invece, è ancora in corsa e, come la Germania, fa sgocciolare verso l’Italia qualche commessa per la quale è sufficiente il lavoro, dequalificato e intermittente degli italiani, e dove il Jobs act sigilla la condizione di colonia.
Forse si può cominciare a muoverci, ma subito, in tre direzioni. La prima è quella di identificare i settori che possono contribuire allo sviluppo del paese (chi sostiene, all’opposto, la decrescita ci vuole proprio colonia di de-spe-cializzati). La seconda, derivata dalla prima: è quella di lavorare sul futuro investendo sugli enti – dai politecnici agli istituti di tecnologia - che possono, oggi, sviluppare le tecnologie del domani. Terzo, imporre l’integrazione delle medie-imprese, la loro capitalizzazione, l’uso della leva fiscale, il sostegno di BdP (a questo deve servire), perché è solo con la dimensione, e la qualità, che si può tornare ad essere strumenti attivi di una rifondata politica industriale. Ritagliarci uno spazio.
In realtà ci sarebbe un quarto punto: quello, diciamolo una buona volta, di abbandonare l’inutile enfasi sull’Europa, perché l’Europa industriale è dominata dai grandi gruppi di ogni Paese, sostenuti ognuno dal proprio Governo, che sono Governi che non hanno sciolto le loro Iri. In nessuno di questi paesi sarebbe stato consentito, ad esempio, che un Marchionne sfasciasse l’industria dell’auto o altro per portare competenze e marchio negli Usa. L’Italia lo ha consentito.
Pertanto, difendiamo e qualifichiamo quel che ci resta, perché parlare di Politica Industriale Europea, così ci ammoniva quindici anni fa Marcello De Cecco, è una colossale ipocrisia: non esiste una Politica Industriale Europea, questa è la verità. Avviamoci una buona volta in quelle tre direzioni. Tutto il resto sono solo “chiacchere e distintivo”.
































Add comment