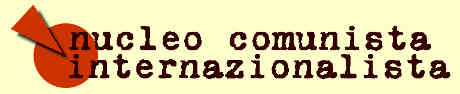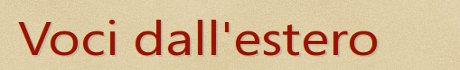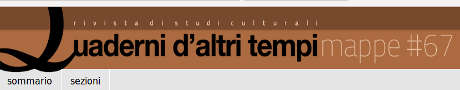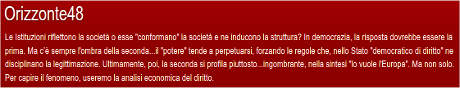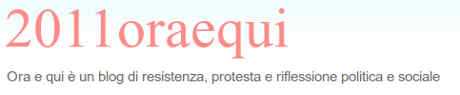Fai una donazione
Questo sito è autofinanziato. L'aumento dei costi ci costringe a chiedere un piccolo aiuto ai lettori. CHI NON HA O NON VUOLE USARE UNA CARTA DI CREDITO può comunque cliccare su "donate" e nella pagina successiva è presente (in alto) l'IBAN per un bonifico diretto________________________________
- Details
- Hits: 2297
“Fascismo”: il nome e la cosa
di Paolo Favilli
 1) L’uso del termine «fascismo» per indicare aspetti tutt’altro che marginali dell’attuale governo a trazione Salvini è al centro di un dibattito fortemente controversistico sul rapporto tra il «nome» e la «cosa». Una discussione che si svolge a diversi livelli: quello degli studiosi di professione, quello degli ex studiosi (personaggi che non fanno più ricerca reale da qualche decennio), quello dei giornalisti «colti» (si sono a suo tempo laureati in storia, ma non hanno mai praticato davvero il mestiere e ignorano del tutto le logiche dell’indagine analitico-epistemologica) e giornalisti-propagandisti tout court. Inevitabilmente questi diversi livelli finiscono per incrociarsi nelle necessità di scelta inerenti all’odierna temperie politica.
1) L’uso del termine «fascismo» per indicare aspetti tutt’altro che marginali dell’attuale governo a trazione Salvini è al centro di un dibattito fortemente controversistico sul rapporto tra il «nome» e la «cosa». Una discussione che si svolge a diversi livelli: quello degli studiosi di professione, quello degli ex studiosi (personaggi che non fanno più ricerca reale da qualche decennio), quello dei giornalisti «colti» (si sono a suo tempo laureati in storia, ma non hanno mai praticato davvero il mestiere e ignorano del tutto le logiche dell’indagine analitico-epistemologica) e giornalisti-propagandisti tout court. Inevitabilmente questi diversi livelli finiscono per incrociarsi nelle necessità di scelta inerenti all’odierna temperie politica.
Uno dei filoni di questo intreccio, nel negare le possibilità di un’analogia tra il fascismo storico ed elementi caratterizzanti il momento attuale definiti tramite il termine «fascismo», appare interessato, soprattutto, alla banalizzazione di tali fenomeni. E la banalizzazione è un modo particolarmente efficace per immetterci in una «notte in cui tutte le vacche sono nere» e le parole perdono il senso profondo del loro significato, nella storia e soprattutto nella memoria. È ora di sconfiggere «l’egemonia delle parole (il corsivo è mio) della sinistra»[1], ebbe a dire Gianfranco Fini nel momento in cui il «neofascismo», parola certo più adeguata nel contesto di esaurimento del «fascismo storico», cominciava la sua, finora, irresistibile ascesa. Un’ascesa che lo avrebbe portato da una presenza ai margini del sistema politico italiano al centro delle istituzioni, in particolare al centro dell’esecutivo, ed a diventare un aspetto rilevantissimo di tanta parte del «senso comune» degli italiani.
Il nostro presente italiano deve confrontarsi con fantasmi che non si sono dissolti nella dissoluzione del Novecento, ma che anzi, nei modi di quella dissoluzione hanno trovato nuove forme di apparizione, nuove forme di corposa presenza.
- Details
- Hits: 2198
Il “mancato approdo” del confronto tra operaie/i e capitale
Nuove e impervie sfide per il mondo del lavoro
di Sergio Bologna
Presentiamo l’ultima versione dell’intervento di Sergio Bologna al convegno di presentazione del numero speciale di «Primo maggio» a Torino, 1 dicembre 2018. Riteniamo le questioni poste di grande rilevanza e per questo sarebbe interessante e utile che su questi temi si potesse sviluppare un dibattito fruttuoso. Una versione precedente del testo è stata pubblicata sul sito di Commonware
 Quando inizia la letteratura sul “declino” in Italia?
Quando inizia la letteratura sul “declino” in Italia?
Sarebbe interessante fare una ricerca ad hoc, perché – se non ricordo male – non è stata una qualche corrente “riformista” ad iniziare questo percorso, sono stati ambienti culturali contigui a Confindustria. Un percorso che poi si è incamminato su un terreno dove il tema del “declino” è diventato quasi mainstream al punto da condizionare lo sguardo all’indietro (come dimostra l’Annale Feltrinelli dello scorso anno intitolato l’Approdo mancato). Senza riuscire a temperare tuttavia lo slancio cieco dell’onda mediatica che esaltava le magnifiche sorti e progressive del modello neoliberale e pretendeva piena, incondizionata fiducia in esse.
La classe capitalistica, la cui inettitudine viene continuamente messa in luce dalla letteratura sul “declino”, persevera nella sua autoreferenziale esaltazione della propria missione di classe dirigente, scaricando tutte la responsabilità del “declino” sulla politica.
Ma né gli uni né gli altri, né gli storici o gli analisti del “declino” né il padronato nel suo complesso s’interrogano se sia o meno il caso di rivedere il giudizio dato sui comportamenti antagonistici di classe degli Anni 70, anni di emancipazione e di produzione d’intelligenza operaia. Su quel ciclo di lotte continua invece a pendere il giudizio di condanna come un momento di follìa collettiva, d’insensatezza. Io credo che la lettura di quegli anni dovrebbe rivalutare come chiave interpretativa quella battuta di Mario Tronti, che tanto fece sorridere allora quando fu pronunciata, e cioé che “la lotta operaia impone lo sviluppo capitalistico”. La vicenda Fiat dal 1980 al 2002 è la controprova della giustezza di quella affermazione: là dove la lotta operaia tace, là dove il suo silenzio si fa prolungato, il capitalismo s’infogna in una crisi mortale. Sconfitti gli operai nell’ottobre 1980 e dopo ventidue anni di pace sociale, la Fiat e con essa l’industria italiana dell’auto, erano a terra.
- Details
- Hits: 2795
La pericolosa illusione della moneta fiscale (e complementare)
di Mario Giambelli
 Da qualche tempo alcuni economisti e/o professionisti che si qualificano esperti in economia, finanza, fiscalità, sovranità e moneta propongono, per correggere le disfunzioni dell’Eurosistema, l’introduzione, in forma gratuita ed aggiuntiva, della c.d. “moneta fiscale” [qualunque titolo che lo Stato si impegna ad accettare per l’adempimento di obbligazioni fiscali (tasse, imposte, contributi ai sistemi sanitari e pensionistici pubblici, eccetera), cioè di titoli finanziari che diano diritto a conseguire, dopo un certo numero di anni dalla loro introduzione, sconti fiscali].
Da qualche tempo alcuni economisti e/o professionisti che si qualificano esperti in economia, finanza, fiscalità, sovranità e moneta propongono, per correggere le disfunzioni dell’Eurosistema, l’introduzione, in forma gratuita ed aggiuntiva, della c.d. “moneta fiscale” [qualunque titolo che lo Stato si impegna ad accettare per l’adempimento di obbligazioni fiscali (tasse, imposte, contributi ai sistemi sanitari e pensionistici pubblici, eccetera), cioè di titoli finanziari che diano diritto a conseguire, dopo un certo numero di anni dalla loro introduzione, sconti fiscali].
Un diritto di riduzione degli importi dovuti a titolo di imposte (quindi un diritto a beneficiare di uno sconto fiscale) metterebbe in atto un’azione di stimolo della domanda aggregata, intervenendo sulle sue varie componenti e rilanciando contemporaneamente consumi privati, spesa sociale e investimenti. Tanto più la manovra venisse indirizzata verso soggetti con alta propensione e necessità di spesa, tanto più elevato sarebbe l’impatto sulla domanda aggregata.
Chi ricevesse Moneta Fiscale beneficerebbe di un immediato incremento della sua capacità di spesa, la rivolgerebbe all’acquisto di beni e servizi, e riavvierebbe produzione e occupazione. L’introduzione della Moneta Fiscale restituirebbe alle economie nazionali le leve d’azione perse con il passaggio alla moneta unica, senza peraltro compromettere (anzi, consentendo di raggiungere) l’obiettivo di stabilizzare in valore le passività statali da rimborsare in euro, e di ridurle costantemente rispetto al PIL.
La Moneta Fiscale sarebbe quindi la soluzione per dare stabilità ed efficienza all’Eurosistema e per risolvere il problema degli altissimi, inaccettabili, livelli di disoccupazione nell’Europa mediterranea. E tutto questo senza chiedere agli stati dell’ex area marco (Germania ma anche Austria e Olanda) neanche un centesimo di trasferimenti fiscali (soluzione alternativa che costerebbe a questi ultimi paesi il 5% del PIL indefinitamente).
- Details
- Hits: 1529
Gilet gialli di Francia
Una prima sommaria cronaca politica
di nucleo comunista internazionalista
La nostra gente ne ha piene le balle. Via il governo Macron, via il "governo dei ricchi"
 Nel movimento di autentica rivolta popolare che come goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato innescato dall’imposizione della tassa “ecologica” sul diesel (ennesima tassa: “per il governo siamo come delle vacche da mungere” si dice fra chi fatica ad arrivare a fine mese e ne ha davvero piene le scatole e dunque, vivaddio, si ribella all’insopportabile stato delle cose) c’è, per il momento, una prima data “spartiacque” che marchiamo nella nostra cronaca politica: il 17 di novembre 2018.
Nel movimento di autentica rivolta popolare che come goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato innescato dall’imposizione della tassa “ecologica” sul diesel (ennesima tassa: “per il governo siamo come delle vacche da mungere” si dice fra chi fatica ad arrivare a fine mese e ne ha davvero piene le scatole e dunque, vivaddio, si ribella all’insopportabile stato delle cose) c’è, per il momento, una prima data “spartiacque” che marchiamo nella nostra cronaca politica: il 17 di novembre 2018.
Prima di tale data, il movimento partito dall’iniziativa di alcune donne (fra cui una di colore, capirete subito più oltre il senso della puntualizzazione) che si sono messe a spulciare fra la gragnola di bollette e di relativi aumenti constatando e denunciando che “c’è qualcosa che non va” nell’andazzo delle cose “governato dai ricchi” e personificato dall’odiosa figura del presidente Macron che si tratta di cacciare via, prima di tale data dicevamo, il movimento è stato osservato e marchiato con un misto di supponenza e disprezzo dalla borghesia (dai maitre-à-penser al suo servizio). Un movimento che non è, e non può essere altro, dice la borghesia “illuminata” e “progressista”, che brodo di coltura di massa per la demagogia social-nazionale della Le Pen e delle altre correnti dell’estrema destra. Come il signorotto sapiente, civile, lungimirante che dall’alto guarda in basso lo spregevole e puzzolente popolaccio, rozzo e ignorante al punto di fregarsene dei destini ecologici del mondo ma di badare solo, volgarmente, ai destini delle sue tasche sempre più vuote e ai bassi istinti dettati dal suo stomaco.
(L’iniziativa-innesco primordiale della protesta di queste donne, in qualche modo ci richiama alla mente il ruolo della famosa “cuoca di Lenin”. Cioè la donna di casa che con il suo scrupolo, con il suo semplice criterio razionale è chiamata a far quadrare i conti della famiglia proletaria e che nella nostra prospettiva deve potere verificare, controllare e governare i conti dello Stato!
- Details
- Hits: 2586
Quattro crisi politiche
di Guido Mazzoni
[Una prima versione di questo intervento è stata presentata al Politecnico di Milano il 17 giugno 2017, nell’ambito di un ciclo di conferenze intitolate Zona Disagio. Progetti di resistenza nella condizione contemporanea organizzata da Florencia Andreola per la rivista di architettura «Gizmo»]
 C’è stato un tempo, fra la fine degli anni Ottanta e gli anni Novanta del Novecento, nel quale l’impulso alla metamorfosi, alla storicità, che è consustanziale all’epoca moderna sembrava essersi attenuato o spento. Due formule filosofiche davano forma a questa percezione. Perfettamente coeve, comparivano nei titoli di due libri usciti nel 1992. La più famosa era stata fatta circolare da un politologo americano, Francis Fukuyama, in un libro semplificatorio e tempestivo. Derivava dalle lezioni e dai saggi di Kojève su Hegel e suonava affascinante e lapidaria: la fine della storia[1]. L’altra apparteneva allo scrittore argentino Macedonio Fernandez ed era stata ripresa da Baudrillard: lo sciopero degli eventi[2]. Per tutti gli anni Novanta si è discusso seriamente di fine della storia e di sciopero degli eventi. Oggi può sembrare strano, ma le due categorie, spogliate dalla loro aura paradossale, descrivevano uno stato di cose che venticinque anni fa pareva tangibile: tutto ciò che accadeva, dalla Guerra del Golfo alle guerre etniche nella ex-Jugoslavia, dalla dissoluzione degli Stati africani alla crisi in Giappone, in Sudamerica o nei paesi dell’Europa dell’Est, sembrava incapace di trasformare il modello sociale che dal 1989 in poi aveva conquistato l’egemonia sul pianeta. Uno degli aspetti fondamentali del mondo moderno – l’ingegneria politica, l’idea che sia possibile costruire forme di vita differenti, tutto quello che si lasciava compendiare nella parola Rivoluzione – sembrava non esistere più, o esistere solo in versione privata e pulviscolare. Se nel corso del Novecento il fascismo, il comunismo e la Western way of life si erano contesi il dominio sulle enormi masse umane prodotte dall’esplosione demografica moderna proponendo modelli sociali alternativi e reciprocamente ostili, il secolo si chiudeva con una vittoria netta, simbolica prima ancora che pratica: la forma di vita occidentale fondata sull’economia di mercato, sulla democrazia liberale e sull’individualismo era l’unica legittima e la sola realistica; l’idea che un altro mondo fosse possibile era difesa solo da minoranze velleitarie.
C’è stato un tempo, fra la fine degli anni Ottanta e gli anni Novanta del Novecento, nel quale l’impulso alla metamorfosi, alla storicità, che è consustanziale all’epoca moderna sembrava essersi attenuato o spento. Due formule filosofiche davano forma a questa percezione. Perfettamente coeve, comparivano nei titoli di due libri usciti nel 1992. La più famosa era stata fatta circolare da un politologo americano, Francis Fukuyama, in un libro semplificatorio e tempestivo. Derivava dalle lezioni e dai saggi di Kojève su Hegel e suonava affascinante e lapidaria: la fine della storia[1]. L’altra apparteneva allo scrittore argentino Macedonio Fernandez ed era stata ripresa da Baudrillard: lo sciopero degli eventi[2]. Per tutti gli anni Novanta si è discusso seriamente di fine della storia e di sciopero degli eventi. Oggi può sembrare strano, ma le due categorie, spogliate dalla loro aura paradossale, descrivevano uno stato di cose che venticinque anni fa pareva tangibile: tutto ciò che accadeva, dalla Guerra del Golfo alle guerre etniche nella ex-Jugoslavia, dalla dissoluzione degli Stati africani alla crisi in Giappone, in Sudamerica o nei paesi dell’Europa dell’Est, sembrava incapace di trasformare il modello sociale che dal 1989 in poi aveva conquistato l’egemonia sul pianeta. Uno degli aspetti fondamentali del mondo moderno – l’ingegneria politica, l’idea che sia possibile costruire forme di vita differenti, tutto quello che si lasciava compendiare nella parola Rivoluzione – sembrava non esistere più, o esistere solo in versione privata e pulviscolare. Se nel corso del Novecento il fascismo, il comunismo e la Western way of life si erano contesi il dominio sulle enormi masse umane prodotte dall’esplosione demografica moderna proponendo modelli sociali alternativi e reciprocamente ostili, il secolo si chiudeva con una vittoria netta, simbolica prima ancora che pratica: la forma di vita occidentale fondata sull’economia di mercato, sulla democrazia liberale e sull’individualismo era l’unica legittima e la sola realistica; l’idea che un altro mondo fosse possibile era difesa solo da minoranze velleitarie.
- Details
- Hits: 2153
Dubito dunque sono
di Fulvio Grimaldi
Travaglio, il trotzkista, il fotografo, i gilet gialli, il terrorista, i serbi ed io
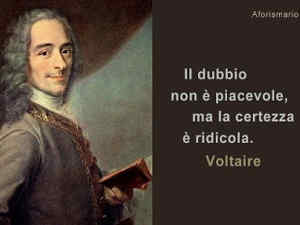 "He who takes a stand is often wrong, but he who fails to take a stand is always wrong.– “Chi si schiera, spesso si sbaglia, ma chi non si schiera si sbaglia sempre” (Anonimo)
"He who takes a stand is often wrong, but he who fails to take a stand is always wrong.– “Chi si schiera, spesso si sbaglia, ma chi non si schiera si sbaglia sempre” (Anonimo)
Il fustigatore fustigato
Nella sua risposta a Giorgio Bianchi, il giornalista fotografo e documentarista che, in modi garbati, seppure puntuti, gli aveva rimproverato, e documentato, la pessima qualità delle pagine di politica internazionale del Fatto Quotidiano (FQ) e lo stupefacente contrasto tra quel trattamento falso, fazioso, preconcetto degli Esteri e la spesso corretta, coraggiosa parte riguardante i fatti, personaggi e colleghi di casa nostra, Marco Travaglio, direttore del giornale, ha fatto la figura per la quale di solito sbeffeggia gran parte dell’importante stampa e Tv italiane. Preda evidente di un livore che mal si concilia con l’elegante sicumera che esibisce nelle sue epifanie televisive, una delle migliori penne satiriche del paese si è lasciata trascinare a insulti, in risposta a presunti ma inesistenti insulti di Bianchi,, disprezzo per le argomentazioni oppostegli, arroganza e pregiudizi talmente clamorosi da parere quelli di un Sallusti qualunque (direttore del foglio berlusconide sedicente“Il Giornale”).
Copertosi dietro a collaboratori “antimericani” come Massimo Fini e Pierangelo Buttafuoco, ha ribadito le sue sentenze inoppugnabili e definitive su “Putin detestabile autocrate”, “Assad criminale di guerra e di pace (si fa per dire)” e sul “regime degli Ayatollah che fa dell’Iran un paese dove nessuna persona di mente normale e amante della libertà vorrebbe mai vivere”. Manca la controprova di quanto un cittadino iraniano si troverebbe bene nei paesi delle armi per tutti, stragi nelle scuole, Barbare d’Urso, assassini mirati, stampa in mano ai tycoon, video giochi a chi ammazza di più.
- Details
- Hits: 2042
La questione sino-americana o della lunga transizione multipolare
di Pierluigi Fagan
 Mettendo su una retta le traiettorie di potenza della Cina e degli Stati Uniti d’America, come possiamo aspettarci continuerà la storia? Abbiamo tre possibili esiti principali. Il primo è che in onore alla regola data dalla “trappola di Tucidide”, le traiettorie portino al conflitto aperto, la terza guerra mondiale. Il secondo è che uno dei due contendenti imploda come implose l’URSS terminando il bipolarismo della guerra fredda e lasciando campo libero all’altro contendente. Il terzo è che la retta continui il processo per il quale la Cina si affiancherà a gli USA come potenza principale del mondo per poi diventare un polo di tale magnitudo da condizionare l’intero mondo dove “condizionare” non è “dominare”. Diamoci un quadro di contesto ed analizziamo meglio le tre possibilità.
Mettendo su una retta le traiettorie di potenza della Cina e degli Stati Uniti d’America, come possiamo aspettarci continuerà la storia? Abbiamo tre possibili esiti principali. Il primo è che in onore alla regola data dalla “trappola di Tucidide”, le traiettorie portino al conflitto aperto, la terza guerra mondiale. Il secondo è che uno dei due contendenti imploda come implose l’URSS terminando il bipolarismo della guerra fredda e lasciando campo libero all’altro contendente. Il terzo è che la retta continui il processo per il quale la Cina si affiancherà a gli USA come potenza principale del mondo per poi diventare un polo di tale magnitudo da condizionare l’intero mondo dove “condizionare” non è “dominare”. Diamoci un quadro di contesto ed analizziamo meglio le tre possibilità.
La nuova era complessa
Si stima che all’anno convenzionale zero, nel mondo ci fossero 250 milioni di persone. Diventiamo 1.250 negli ultimi decenni del XIX secolo, quasi due millenni per quadruplicarci. Poi, dal 1880 al 1950 raddoppiamo diventando 2.500 milioni. Poi ci triplichiamo nei successivi settanta anni arrivando a gli attuali 7.500 milioni. In questa seconda ondata di crescita, ci siamo quadruplicati non più in quasi due millenni, ma in soli centoventi anni. Negli ultimi settanta anni, si sono anche quadruplicati gli stati, passati in breve tempo da 50 a 200. Negli ultimi quaranta anni, tutti gli stati hanno preso a convergere verso un modello sociale simile basato sullo sviluppo di una economia potenziata da tecno-scienza e capitali e lievitata da scambi internazionali. L’aumento così importante ed in tempi davvero brevi delle varietà ed interrelazioni di un sistema, il sistema-mondo, configura una vera e propria inflazione di complessità, tanto da spingerci a definire la nostra era come nuova ed appunto, complessa.
- Details
- Hits: 2159
Per la critica del capitalismo globale: un progetto “marxiano”?
di Sandro Mezzadra
Intervento al convegno internazionale “200 Marx. Il futuro di Karl”, Roma, 14 dicembre 2018
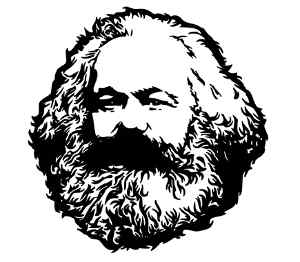 Intervenire a un convegno su Marx (o meglio sul suo “futuro”) in una sessione intitolata “Per la critica del capitalismo globale” comporta qualche esitazione. Di che cosa siamo chiamati a parlare? Della critica del nostro presente facendo tesoro della lezione di Karl? O piuttosto della critica che quest’ultimo ha articolato nel corso della sua vita, in un tempo ormai lontano, di un modo di produzione capitalistico fin dalla sua origine “globale”? Non è per me una domanda retorica. Trascorsa l’epoca della damnatio memoriae, quando la semplice menzione di Marx (in particolare in Italia) determinava commiserazione o alzate di ciglia, è bene resistere alla tentazione di applicare linearmente all’analisi del presente le categorie da lui elaborate. Profondamente “intempestivo”, secondo l’azzeccata definizione di Daniel Bensaïd, Marx ha intrattenuto un rapporto complesso – di adesione e di scarto, di appropriazione e di sottrazione – con il proprio tempo. Il suo pensiero ne è fortemente segnato: leggere (o rileggere) oggi le sue opere significa esporsi a questa intempestività.
Intervenire a un convegno su Marx (o meglio sul suo “futuro”) in una sessione intitolata “Per la critica del capitalismo globale” comporta qualche esitazione. Di che cosa siamo chiamati a parlare? Della critica del nostro presente facendo tesoro della lezione di Karl? O piuttosto della critica che quest’ultimo ha articolato nel corso della sua vita, in un tempo ormai lontano, di un modo di produzione capitalistico fin dalla sua origine “globale”? Non è per me una domanda retorica. Trascorsa l’epoca della damnatio memoriae, quando la semplice menzione di Marx (in particolare in Italia) determinava commiserazione o alzate di ciglia, è bene resistere alla tentazione di applicare linearmente all’analisi del presente le categorie da lui elaborate. Profondamente “intempestivo”, secondo l’azzeccata definizione di Daniel Bensaïd, Marx ha intrattenuto un rapporto complesso – di adesione e di scarto, di appropriazione e di sottrazione – con il proprio tempo. Il suo pensiero ne è fortemente segnato: leggere (o rileggere) oggi le sue opere significa esporsi a questa intempestività.
Certo, alla fine del secondo decennio del XXI secolo così come negli anni Sessanta del Novecento vale la grande lezione dell’operaismo italiano: la nostra ricerca “deve mettere Marx a confronto non con il suo tempo, ma con il nostro tempo. Il Capitale deve essere giudicato sulla base del capitalismo di oggi”1. Ma sarà opportuno aggiungere una postilla: affinché questo sia possibile, è essenziale comprendere e apprezzare la storicità specifica delle categorie marxiane, non tanto per liberarle dalle incrostazioni di un’epoca ormai trascorsa quanto per riattivare quell’urto contro i limiti del suo tempo (e del suo stesso pensiero) che le costituisce. C’è qui per me un principio di metodo: l’“attualità di Marx” non coincide necessariamente con l’attualità del suo sistema; risiede nei vuoti oltre che nei pieni del suo pensiero, nei suoi scacchi così come nei suoi trionfi “scientifici” – nei problemi che ci aiuta a pensare e non soltanto nelle soluzioni che ci propone. La nostra interpretazione di Marx, in altri termini, deve essere da un lato filologicamente rigorosa, dall’altro “trasformativa”, come ha scritto di recente Étienne Balibar.
- Details
- Hits: 3244
Farsi male da soli
Disciplina esterna, domanda aggregata e il declino economico italiano
di Sergio Cesaratto* e Gennaro Zezza**
Abstract. In questo saggio ripercorriamo la storia dell’economia italiana a partire dagli anni del miracolo economico, mostrando il ruolo della politica economica nelle sue diverse declinazioni (fiscale, monetaria, valutaria) nella determinazione della crescita, e poi del declino. Argomentiamo come i periodi della crescita siano caratterizzati dal tentativo di perseguire il pieno impiego, mentre il successivo periodo del declino è dipeso anche dal tentativo di risolvere i conflitti distributivi interni tramite vincoli esteri sempre più stringenti
 Introduzione*
Introduzione*
Il saggio mira a fornire una spiegazione dei problemi di lungo periodo dell’economia italiana che noi ritroviamo nella mancata opportunità di completare il miracolo economico degli anni cinquanta e sessanta con un compromesso sociale riguardante la distribuzione del reddito e con il necessario progresso tecnico e manageriale nel sistema delle imprese. La tesi sostenuta è che la ricerca della disciplina esterna come surrogato di opportune istituzioni interne ha probabilmente condotto, col sostegno di teorie economiche volte a trascurare il ruolo della domanda aggregata nella crescita, a esiti peggiori del male che si intendeva curare. Attualmente l’ancora vivace spirito imprenditoriale di parte del paese è intrappolato fra le carenti istituzioni socio-politiche interne, e il contesto istituzionale europeo ispirato dall’ordoliberismo tedesco, incompatibile con un’unione monetaria sostenibile (ma non con gli interessi del capitalismo di quel Paese).
Dalla crescita al declino
Guardando all’esperienza dell’economia italiana del secondo dopoguerra possiamo
provare a distinguere distinguere i periodi seguenti:
- 1951-1963 il miracolo economico italiano
- 1964-1968 interludio: le mancate riforme
- 1969-1978 gli anni dell’elevato conflitto sociale
- 1979-1992 Il “nuovo regime”: gli anni del Sistema Monetario Europeo (di cui 1987-92 gli anni
dello SME “nuovo” o “duro”)
- 1992- 1995 interludio: il grande riallineamento della lira
- 1996-2007 l’attuazione della moneta unica (di cui 1996-1998 gli anni preparatori)
- Details
- Hits: 2249
“Una formula di moda per edulcorare il nazionalismo”
Su Marco Bascetta
di Alessandro Visalli
 Marco Bascetta è impegnato in una crociata, il cui effetto principale non può che essere di far restare la sinistra cui appartiene fuori della fase. Lenin ebbe a dire una volta che “la frase rivoluzionaria sulla guerra rivoluzionaria può causare la rovina della rivoluzione”[1], e che ci sono momenti in cui bisogna chiamare le cose con il loro nome.
Marco Bascetta è impegnato in una crociata, il cui effetto principale non può che essere di far restare la sinistra cui appartiene fuori della fase. Lenin ebbe a dire una volta che “la frase rivoluzionaria sulla guerra rivoluzionaria può causare la rovina della rivoluzione”[1], e che ci sono momenti in cui bisogna chiamare le cose con il loro nome.
Cosa è la “frase rivoluzionaria”? Semplicemente è la ripetizione di parole d’ordine senza tenere conto delle circostanze obiettive. La definizione è perfetta: “parole d’ordine magnifiche, attraenti, inebrianti, che non hanno nessun fondamento sotto di sé”. Le parole d’ordine sono ‘magnifiche’ perché contengono solo “sentimenti, desideri, collera, indignazione”, ma niente di altro. Quando si pronunciano ‘frasi rivoluzionarie’, continuo a leggere, “si ha paura di analizzare la realtà oggettiva”. E, ancora, poco dopo, “se non sai adattarti, se non sei disposto a strisciare sul ventre, nel fango, non sei un rivoluzionario, ma un chiacchierone”, ciò non significa che piaccia, ma che “non c’è altra via”[2] che tenere conto della realtà; la “rivoluzione mondiale”, che prevedrebbe di abbandonare la costruzione del socialismo intanto dove concretamente si può tentare, per Lenin arriverà pure, ma, scrivendo nel 1918, “per ora è solo una magnifica favola, una bellissima favola”[3]; dunque crederci nell’immediato significa che “solo nel vostro pensiero, nei vostri desideri superate le difficoltà che la storia ha fatto sorgere”.
Ciò che va fatto è del tutto diverso, dice il vecchio rivoluzionario russo: bisogna “porre alla base della propria tattica, anzitutto e soprattutto, l’analisi precisa della situazione obiettiva”[4].
- Details
- Hits: 1792
Il punto sulla crisi
Intervista a Tony Norfield, Michael Roberts e Paula Bach
 Pubblichiamo la traduzione di un’intervista (già apparsa su LeftVoice e LaIzquierdaDiario) a tre importanti economisti marxisti che fanno il punto sulla più recente congiuntura economica. In realtà si tratta di studiosi non molto noti in Italia, se non in circoli ristretti. Questo nella misura in cui il dibattito teorico nella sinistra italiana è pressoché assente, da cui lo scarso interesse a rendere disponibile nella nostra lingua i lavori e gli articoli di chi invece è impegnato in serrate discussioni a livello internazionale, e in particolare in America Latina e nel mondo anglofono. Paula Bach è un’economista marxista argentina che si occupa di economia internazionale; è inoltre militante del Partido Socialistas de los Trabajadores e collaboratrice de La IzquierdaDiario e di Ideas de Izquierda. Micheael Roberts, invece, è un economista marxista britannico (con un passato “nel ventre della bestia” come analista finanziario); ha scritto alcuni importanti libri come “The Great Recession” e con Guglielmo Carchedi il recentissimo “World in Crisis”. Micheal tiene inoltre un’aggiornatissimo blog, purtroppo solo in lingua inglese, ma dal quale – prendiamo qui l’impegno – vedremo di attingere più frequentemente per delle traduzioni. Anche Tony Norfield è un economista marxista britannico “forte” di un passato nella City di Londra, del quale ha potuto giovare per scrivere un libro sul ruolo centrale che ancora svolge l’imperialismo britannico nell’architettura geo-economica e geo-politica mondiale. Il libro si chiama “The City”. Abbiamo già tradotto un’intervista a Tony QUI. Anche Tony Norfield tiene un blog molto interessante che si concentra sull’economia e sull’imperialismo.
Pubblichiamo la traduzione di un’intervista (già apparsa su LeftVoice e LaIzquierdaDiario) a tre importanti economisti marxisti che fanno il punto sulla più recente congiuntura economica. In realtà si tratta di studiosi non molto noti in Italia, se non in circoli ristretti. Questo nella misura in cui il dibattito teorico nella sinistra italiana è pressoché assente, da cui lo scarso interesse a rendere disponibile nella nostra lingua i lavori e gli articoli di chi invece è impegnato in serrate discussioni a livello internazionale, e in particolare in America Latina e nel mondo anglofono. Paula Bach è un’economista marxista argentina che si occupa di economia internazionale; è inoltre militante del Partido Socialistas de los Trabajadores e collaboratrice de La IzquierdaDiario e di Ideas de Izquierda. Micheael Roberts, invece, è un economista marxista britannico (con un passato “nel ventre della bestia” come analista finanziario); ha scritto alcuni importanti libri come “The Great Recession” e con Guglielmo Carchedi il recentissimo “World in Crisis”. Micheal tiene inoltre un’aggiornatissimo blog, purtroppo solo in lingua inglese, ma dal quale – prendiamo qui l’impegno – vedremo di attingere più frequentemente per delle traduzioni. Anche Tony Norfield è un economista marxista britannico “forte” di un passato nella City di Londra, del quale ha potuto giovare per scrivere un libro sul ruolo centrale che ancora svolge l’imperialismo britannico nell’architettura geo-economica e geo-politica mondiale. Il libro si chiama “The City”. Abbiamo già tradotto un’intervista a Tony QUI. Anche Tony Norfield tiene un blog molto interessante che si concentra sull’economia e sull’imperialismo.
* * * *
È difficile prevedere precisamente quando avrà luogo una recessione, ma è possibile individuare alcuni segnali, come ad esempio la tendenza all’appiattimento della curva dei rendimenti*, la quale indica che potremmo essere vicini a una nuova decelerazione.
- Details
- Hits: 2796
La Cina e la questione dell'egemonia
di Michele Nobile
L'articolo di Michele Nobile inizia una serie sulla politica estera della Repubblica popolare cinese, centrata sull’analisi della situazione nel Mar cinese meridionale. Di Nobile si veda anche «Sul “socialismo con caratteristiche cinesi“, ovvero del capitalismo realmente esistente in Cina», 10 settembre 2018
 1. Il problema dell’egemonia come combinazione di forza e consenso
1. Il problema dell’egemonia come combinazione di forza e consenso
Gli Stati Uniti come potenza un tempo egemone ma ora condannata al declino? E la Repubblica popolare cinese (Rpc o semplicemente Cina) come potenza in ascesa e nuovo Stato egemone, se non sul piano planetario almeno in Asia, nel quadro di un sistema internazionale multipolare?
Se l’egemonia è correttamenteintesa come combinazione di forza dell’egemone e di consenso al suo ruolo internazionale da parte delle classi dominanti degli altri Paesi e, almeno passivamente, anche di una parte consistente dei loro popoli, è nel Mar cinese che si mettono alla prova le rispettive capacità degli Stati Uniti e della Cina di mantenere l’egemonia o di costruirne una alternativa.
Più precisamente, è tra i Paesi litoranei della porzionemeridionaledel Mar cinese che meglio si può verificare la tesi di una transizione dell’egemonia dagli Stati Uniti alla Cina. È lì che si confrontano direttamente la «nuova via della seta» marittima di Xi Jinping e il pivotverso l’Asia, nelle forme molto diverse assunte durante le amministrazioni di Obama e di Trump; e anche oltre il problema di Taiwan, è in quell’area che con maggiore probabilità possono verificarsi incidenti o scontri diretti tra unità militari della Rpc e degli Stati Uniti.
Se ben messa a fuoco, la generica idea di un’eventuale transizione del potere suscita numerosi interrogativi circa i modi e la forma che essa potrebbe assumere. Ad esempio: gli Stati Uniti accetteranno di riscrivere le regole dell’ordine internazionale insieme alla Cina? O è possibile che rinuncino alla posizione di egemone per riformare l’ordine liberale mondiale insieme agli altri Paesi a capitalismo avanzato? Oppure, l’egemone in declino tenterà di riprendersi il primato con ultimo colpo di coda? È che genere di grande potenza è la Rpc: è da prendere sul serio la posizione ufficiale del «pacifico sviluppo»? O si tratta di una potenza revisionista? E se sì, allora mira a costruire una sua sfera d’influenza regionale o anche a modificare le regole del sistema globale? Il futuro prospetta una grande guerra costituente tra Stati Uniti e Cina, forse una nuova guerra mondiale? O l’alternativa è un sistema bipolare tra potenze antagonistiche, caratterizzato da una condizione che non è né di pace né di guerra, del genere della guerra fredda?1
- Details
- Hits: 2498
La crisi europea, lo scontro sociale che cresce
di Dante Barontini
 Quando i dati – economici e politici – confermano un’analisi sgradita, i cretini (e quelli che ci guadagnano) voltanto la testa dall’altra parte, cominciando a farneticare di “valori”. Il massimo dello sciacallaggio poi avviene su ragazzi uccisi, come il giovane giornalista italiano a Strasburgo, le cui convinzioni e/o fraintendimenti vengono ora spacciati per verità rivelate che nessuno deve osare mettere in discussione. Un po’ come fanno i generali in guerra, quando vanno in difficoltà, che esaltano il sacrificio dei ragazzi che loro stessi hanno mandato a uccidere e morire.
Quando i dati – economici e politici – confermano un’analisi sgradita, i cretini (e quelli che ci guadagnano) voltanto la testa dall’altra parte, cominciando a farneticare di “valori”. Il massimo dello sciacallaggio poi avviene su ragazzi uccisi, come il giovane giornalista italiano a Strasburgo, le cui convinzioni e/o fraintendimenti vengono ora spacciati per verità rivelate che nessuno deve osare mettere in discussione. Un po’ come fanno i generali in guerra, quando vanno in difficoltà, che esaltano il sacrificio dei ragazzi che loro stessi hanno mandato a uccidere e morire.
Il tutto mentre un “governo del cambiamento”, che doveva fare una “manovra del popolo”, sfidare l’Unione Europea e rivoltare la Ue come un calzino, si appresta a varare una legge di stabilità riscritta fino all’ultimo rigo sotto la supervisione della Commissione Europea, che intanto preparava – ad ogni buon conto – la “procedura di infrazione” per debito eccessivo.
Due cose possiamo rivendicare d’aver detto e scritto molto prima che anche nei giornali mainstream se ne accorgessero. La prima, seria e strategica, addirittura a metà maggio, è che Salvini e Di Maio erano i due nuovi Tsipras, sebbene uno fasciorazzista e l’altro neo-doroteo. La seconda, scherzosa ma altrettanto vera, è che a forza di ridurre la platea dei beneficiari di “quota 100” per le pensioni e del reddito di cittadinanza, pur di rientrare nei limiti dettati dalla Ue, alla fine daranno la “quota” all’autista di Salvini e e il reddito a un vicino di casa di Di Maio…
Per i dati, e quel comportano in termini di insorgenza sociale e fratture tra establisment e popoli, ci soccorre – ormai spesso – un editoriale di Guido Salerno Aletta, pubblicato su Milano Finanza (non sull’organo dei soviet!).
Il quale spiega con grande sintesi, dunque con la massima efficacia, come l’ordoliberismo economico sottostante a tutti i meccanismi di regolazione Ue abbiano nel corso degli ultimi venti anni prima logorato e poi distrutto le leadership politiche dell’Europa intera (ricordiamo sempre che l’Europa è il continente in cui viviamo, la Ue una schifosa forma di governo di questo territorio; confonderle è un’infamian o un suicidio).
- Details
- Hits: 1412
Leggendo«Elogio sì, ma di quale democrazia?» di Giancarlo Paciello
di Fernanda Mazzoli
 Leggendo l’ultimo libro di Giancarlo Paciello, Elogio sì, ma di quale democrazia? La rivolta o forse la rivincita del demos, non ho potuto fare a meno di pensare ad una considerazione di Antonio Gramsci sul contesto in cui era andata maturando la crisi moderna che aveva trasformato i ceti dirigenti in ceti semplicemente dominanti. Le sbarre del carcere non gli impedivano di affacciarsi curioso sulla realtà contemporanea e di osservare che «il vecchio muore e il nuovo non nasce»,[1] ad indicare la possibilità di sviluppi incerti, contraddittori e anche morbosi nella vita sociale e a suggerire il rischio di una impasse. Posto che non intendo stabilire alcun parallelismo fra gli anni vissuti da Gramsci e i nostri, mi preme cogliere di tale osservazione la capacità di fotografare in modo incisivo un momento storico che le consolidate categorie interpretative faticano a cogliere, perché dalle macerie di un certo sistema di rappresentanza politica stenta a crescere e ad imporsi un cambiamento sostanziale, capace di andare oltre la manifestazione di un netto rifiuto dell’Ancien Régime.
Leggendo l’ultimo libro di Giancarlo Paciello, Elogio sì, ma di quale democrazia? La rivolta o forse la rivincita del demos, non ho potuto fare a meno di pensare ad una considerazione di Antonio Gramsci sul contesto in cui era andata maturando la crisi moderna che aveva trasformato i ceti dirigenti in ceti semplicemente dominanti. Le sbarre del carcere non gli impedivano di affacciarsi curioso sulla realtà contemporanea e di osservare che «il vecchio muore e il nuovo non nasce»,[1] ad indicare la possibilità di sviluppi incerti, contraddittori e anche morbosi nella vita sociale e a suggerire il rischio di una impasse. Posto che non intendo stabilire alcun parallelismo fra gli anni vissuti da Gramsci e i nostri, mi preme cogliere di tale osservazione la capacità di fotografare in modo incisivo un momento storico che le consolidate categorie interpretative faticano a cogliere, perché dalle macerie di un certo sistema di rappresentanza politica stenta a crescere e ad imporsi un cambiamento sostanziale, capace di andare oltre la manifestazione di un netto rifiuto dell’Ancien Régime.
È quanto l’autore sottolinea già a partire dalla premessa, mettendo in guardia da troppo facili entusiasmi per il voto del 4 marzo che, se ha segnato il «redde rationem di una classe politica improvvida»,[2] non rappresenta certamente la fine dell’oligarchia che ci governa da troppo tempo, ma, sicuramente, è da leggersi come un segnale importante, l’espressione di un desiderio autentico, anche quando soggetto a pulsioni contraddittorie, di farla finita con una classe politica corrotta che ha saccheggiato il Paese, finendo, poi, per consegnarlo nelle mani di organismi sovranazionali dominati dalla finanza.
Il libro si sviluppa su due binari: da un lato, la focalizzazione sull’attualità che si sostanzia nell’analisi precisa dei sistemi elettorali dal dopoguerra ad oggi e del voto degli ultimi anni, dall’altro una ricerca intorno al significato della democrazia che si avvale del contributo fornito da eminenti studiosi, quali Vernant, Preve, Canfora, Giacché. Il percorso si snoda dalla nascita della polis, decisivo punto di partenza per una nuova modalità di vita associata, e dalle considerazioni di Aristotele sulla differenza fra oligarchia e democrazia, nonché sulla natura dell’uomo come animale politico, fino al moderno concetto di democrazia.
- Details
- Hits: 1239
Prove tecniche di convergenza gialla
di Alessandro Ferrari
Dopo l’articolo di Maurizio Gribaudi e i contributi “francesi” di Edwy Plenel e del Comitato Adama, continuano le riflessioni Effimere sui cosiddetti “gilet gialli” con Alessandro Ferrari
 Una domanda provocatoria
Una domanda provocatoria
La mobilitazione dei gilets jaunes si é ormai da alcune settimane imposta al centro del dibattito politico in Francia per la sua crescita ed ampiezza e nonostante gli appelli e gli auspici del governo il movimento non accenna a sgonfiarsi e l’atto III di questa mobilitazione che ha messo a ferro e fuoco Parigi sta qui a dimostrarlo; in questo testo non ci limiteremo né ad una semplice descrizione dei fatti e sintesi della mobilitazione né ad un’analisi esterna che tiri le somme cercando di costruire esternamente una posizione politica di fronte alla variabile rappresentata dai gilets gialli quanto piuttosto un tentativo di articolare il reale con una sua sovrainterpretazione che cerca di leggere gli aspetti tendenziali del movimento dei gilets jaunes non per provare a sovradeterminarlo politicamente quanto per azzardare una bozza di una delle sue possibili evoluzioni e del ruolo da giocare in questa evoluzione. Faremo questo attraverso una sintesi degli avvenimenti che hanno caratterizzato la mobilitazione dei gilets gialli ed insieme una radiografia progressiva delle sue evoluzioni ed obbiettivi per provare in seguito a vedere nella giornata del primo dicembre a Lyon più che a Parigi un’esemplificazione della nostra lettura tendenziale, una scelta che deriva da un lato della participazione e dalla conoscenza diretta e dall’altro lato come primo esempio di quell’azzardo interpretativo appena descritto che lega i fatti alla torsione politica della tendenza. Una lettura che piuttosto che localizzare gli ennesimi nuovi e definitivi soggetti rivoluzionari o predeterminare il progetto politico di una mobilitazione in divenire pone una semplice domanda al dibattito collettivo, non tanto una domanda voyeuristica delle lotte altrui quanto un sasso lanciato nello stagno del conflitto e del nostro lavoro politico, una domanda che sopravanza provocatoriamente e paurosamente la durezza dei fatti chiedendosi se l’esigenza smaniosa e il seme di una convergence des luttes che aleggiava nei cortei e nelle piazze attraversate dalle lotte degli cheminots e degli studenti stia finalmente vedendo la luce nella mobilitazione dei gilets gialli.
- Details
- Hits: 2352
Crescita e moneta unica: il paradosso della politica fiscale
Allegato alla “Politeia” di Savona
di J. A. Kregel
 Una esauriente e approfondita scheda esplicativa sullo studio intitolato “Crescita e moneta unica: il paradosso della politica fiscale” elaborato dall’economista J. A. Kregel e allegato al documento “Una politeia per un’Europa diversa, più forte e più equa” che il Ministro Paolo Savona ha proposto come base di discussione al Consiglio europeo al fine di verificare la reale rispondenza della architettura europea agli obiettivi di crescita di piena occupazione e di stabilità che sarebbero alla base dei trattati. Il documento di Kregel, estremamente significativo, dimostra su base scientifica la natura paradossale dell’impianto della moneta unica, che con le sue regole di rigore fiscale nel lungo periodo non può che portare o a condizioni di stagnazione permanente o ad un’intrinseca fragilità finanziaria tipica di uno schema Ponzi, che si scaricherebbe sul resto del mondo. Una follia economica.
Una esauriente e approfondita scheda esplicativa sullo studio intitolato “Crescita e moneta unica: il paradosso della politica fiscale” elaborato dall’economista J. A. Kregel e allegato al documento “Una politeia per un’Europa diversa, più forte e più equa” che il Ministro Paolo Savona ha proposto come base di discussione al Consiglio europeo al fine di verificare la reale rispondenza della architettura europea agli obiettivi di crescita di piena occupazione e di stabilità che sarebbero alla base dei trattati. Il documento di Kregel, estremamente significativo, dimostra su base scientifica la natura paradossale dell’impianto della moneta unica, che con le sue regole di rigore fiscale nel lungo periodo non può che portare o a condizioni di stagnazione permanente o ad un’intrinseca fragilità finanziaria tipica di uno schema Ponzi, che si scaricherebbe sul resto del mondo. Una follia economica.
Ringraziamo il curatore della scheda Beppe Vandai, che ha spesso collaborato con Vocidallestero traducendo articoli di particolare rilevanza. Beppe, di formazione filosofica, vive da 32 anni in Germania e ha fondato ad Heidelberg il circolo di discussione politico-culturale Volta la Carta!! e a Treviso il circolo Risorse, sui temi dell’economia.
Scheda a cura di Beppe Vandai sul documento di Jan A. Kregel* “Crescita e moneta unica: il paradosso della politica fiscale”
*Jan A. Kregel è un importante economista post-Keynesiano, direttore del programma «Politica monetaria» presso il Levy Economic Institute of Bard College e professore di Development Finance presso la Tallinn University of Technology. Ex professore di Economia Politica presso l’Università degli Studi di Bologna ed ex professore di Economia Internazionale presso il Johns Hopkins University’s Paul Nitze School of Advanced International Studies, dove è stato anche direttore associato del Bologna Center dal 1987 al 1990.
- Details
- Hits: 2293
Il discorso di Macron, la risposta di Mélenchon, il futuro del movimento
di Giacomo Marchetti
 Alle otto di lunedì sera, Emmanuel Macron ha pronunciato il suo atteso discorso alla nazione; dopo poco Jean-Luc Mélenchon, deputato e leader della France Insoumise, ha “risposto” per punti alle affermazioni del messaggio del Presidente.
Alle otto di lunedì sera, Emmanuel Macron ha pronunciato il suo atteso discorso alla nazione; dopo poco Jean-Luc Mélenchon, deputato e leader della France Insoumise, ha “risposto” per punti alle affermazioni del messaggio del Presidente.
Dopo avere considerato il “botta e risposta” tra il Macron e Mélenchon, dobbiamo approfondire l’analisi su questo movimento per comprendere come i pochi palliativi macroniani non avranno probabilmente gli esiti sperati.
L’aumento del salario minimo intercategoriale di 100 euro (in realtà 64 in più rispetto all’aumento automatico previsto in conseguenza all’indicizzazione), la defiscalizzazione per il lavoratore e per l’impresa delle ore straordinarie, un premio delle imprese ai lavoratori per la fine dell’anno – comunque facoltativo e comunque defiscalizzato – e per ultimo l’innalzamento della CSG per le pensioni inferiori a 2.000 euro, sono le uniche misure concrete di cui ha parlato Macron nel suo discorso, e si inseriscono nel solco della sua filosofia di governo, tesa a sposare la tesi dello “sgocciolamento” e a legittimare il rapporto plebiscitario che esacerba i tratti più autoritari della Quinta Repubblica in un rapporto Presidente – o meglio monarca repubblicano – e cittadini, riportati a sudditi, al di là di un generico ascolto di facciata dei corpi democratici.
La risposta a Macron del leader della France Insoumise, in un intervento di poco più di cinque minuti, si articola in 5 punti.
Come premessa viene fatto rilevare che nel discorso del presidente non compare alcuna scusa per le violenze delle forze dell’ordine, mentre è netta la condanna delle violenze dei manifestanti.
Macron si illude che “la distribuzione di soldi possa calmare l’insurrezione dei cittadini che è scoppiata”, afferma Mélenchon, che comunque lascia che sulle parole del Presidente si esprimano direttamente i GJ.
- Details
- Hits: 1617
Comunismi paralleli e altri viaggi nell’utopia
di Giovanni De Matteo
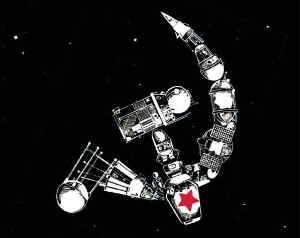 Siamo nel 1927 e in tutta l’Unione Sovietica fervono i preparativi per i festeggiamenti del decennale della Rivoluzione d’Ottobre. Denni è una ragazza dal passato misterioso che arriva a Mosca dalle sperdute regioni del sud. Sta seguendo le tracce di un padre scomparso e, quando si presenta alla porta dell’Istituto Trasfusionale, per il direttore Aleksandr Bogdanov (figura storica realmente esistita), che già si sta misurando con gli esiti frustranti della rivoluzione, comincia la sfida più incredibile della sua carriera che lo porterà a fare i conti sia con il suo ruolo personale nella Storia che con un caso medico che da subito rivela caratteri straordinari.
Siamo nel 1927 e in tutta l’Unione Sovietica fervono i preparativi per i festeggiamenti del decennale della Rivoluzione d’Ottobre. Denni è una ragazza dal passato misterioso che arriva a Mosca dalle sperdute regioni del sud. Sta seguendo le tracce di un padre scomparso e, quando si presenta alla porta dell’Istituto Trasfusionale, per il direttore Aleksandr Bogdanov (figura storica realmente esistita), che già si sta misurando con gli esiti frustranti della rivoluzione, comincia la sfida più incredibile della sua carriera che lo porterà a fare i conti sia con il suo ruolo personale nella Storia che con un caso medico che da subito rivela caratteri straordinari.
Il personaggio immaginario di Leonid Voloch, il padre che Denni non ha mai conosciuto, è stato delegato al soviet di San Pietroburgo, militante irriducibile e compagno di lotta di Bogdanov: scomparso nel 1907 dopo una rapina a Tbilisi a cui prendeva parte lo stesso Stalin, sarebbe riapparso solo a distanza di diversi mesi, sottoposto a giudizio dai compagni in esilio a Capri per sospetto tradimento e graziato da Bogdanov, che aveva riconosciuto nel suo comportamento i segni di un disturbo post-traumatico riconducibile alla conclusione violenta proprio di quella rapina. La ragazza versa in condizioni di salute precarie e, dagli accertamenti condotti all’istituto, risulta portatrice di un batterio apparentemente legato a una forma sconosciuta di tubercolosi. Trovare Voloch diventa così una corsa contro il tempo, non solo per permetterle di ricongiungersi con quello che resta della sua famiglia, ma anche per salvarle la vita.
“Bogdanov resta in silenzio. Quella sfida lo affascina. Un elemento sconosciuto è giunto a turbare le loro certezze. Ora li attende un periodo eccitante, fatto di disordini e divergenze, di contraddizioni e aggiustamenti, finché il sistema non troverà una nuova stabilità. Crisi, differenziazione, equilibrio. La dialettica in versione tectologica, che muove ogni progresso”
(Wu Ming, 2018).
- Details
- Hits: 1602
Sul concetto di valore
di Emanuela Fornari
 Prendiamo le mosse da una premessa autoevidente del linguaggio comune. «Valore» è un termine polisemico in duplice senso. La sua polisemia è manifesta in ragione del diverso significato che il concetto di valore assume nei due ambiti in cui indiscutibilmente regna: l’ambito dell’economia e quello della morale. Si tratta di due ambiti distinti, ma per altro verso interconnessi: Adam Smith, il fondatore dell’economia politica moderna – la nuova scienza fondata sulla saldatura di due dimensioni che la cultura classica aveva tenuto ben distinte (l’oikos e la polis, lo spazio della produzione-riproduzione di beni di sussistenza e quello della praxis intesa come attività di governo della Città) per porre come fine e fonte di legittimazione di uno Stato non più la «vita buona» ma il benessere e the wealth of nations – teneva insieme i due insegnamenti della Political Economy e della Moral Philosophy. Ma la polisemia, in secondo luogo, è presente anche all’interno dello stesso ambito economico propriamente inteso: dove il concetto di valore assume significati diversi nella macroeconomia (o politica economica), nella microeconomia (o economia aziendale) e nella finanza.
Prendiamo le mosse da una premessa autoevidente del linguaggio comune. «Valore» è un termine polisemico in duplice senso. La sua polisemia è manifesta in ragione del diverso significato che il concetto di valore assume nei due ambiti in cui indiscutibilmente regna: l’ambito dell’economia e quello della morale. Si tratta di due ambiti distinti, ma per altro verso interconnessi: Adam Smith, il fondatore dell’economia politica moderna – la nuova scienza fondata sulla saldatura di due dimensioni che la cultura classica aveva tenuto ben distinte (l’oikos e la polis, lo spazio della produzione-riproduzione di beni di sussistenza e quello della praxis intesa come attività di governo della Città) per porre come fine e fonte di legittimazione di uno Stato non più la «vita buona» ma il benessere e the wealth of nations – teneva insieme i due insegnamenti della Political Economy e della Moral Philosophy. Ma la polisemia, in secondo luogo, è presente anche all’interno dello stesso ambito economico propriamente inteso: dove il concetto di valore assume significati diversi nella macroeconomia (o politica economica), nella microeconomia (o economia aziendale) e nella finanza.
Una volta fissati questi presupposti di partenza, occorre però adesso porre la questione della genealogia. In che modo, attraverso quali passaggi complessi, si è giunti a definire tramite il ricorso al concetto di valore quello che nel mondo classico era invece rappresentato, in autori quali Platone e Aristotele, dall’idea di arché: di un principio inteso al contempo come criterio-guida e «principato», come principio ordinatore oggettivo, indiscutibilmente superiore e universalmente riconosciuto? La tesi che intendo prospettare in questa rapida sintesi è che il passaggio dalla logica del Principio a quella del Valore ha innescato, a partire dall’età moderna, un’irreversibile tendenza dissolutiva e deoggettivante, rappresentata da una dinamica di progressiva soggettivazione della logica del valore. Vediamo allora di procedere con ordine, prendendo avvio dall’etimologia del termine.
- Details
- Hits: 2053
Global Compact for safe, orderly and regular Migration
La grande pianificazione e il diritto internazionale privatizzato
di Francesco Maimone
 “Dobbiamo consentire ai migranti di diventare membri a pieno titolo delle nostre società evidenziando il loro contributo positivo”
“Dobbiamo consentire ai migranti di diventare membri a pieno titolo delle nostre società evidenziando il loro contributo positivo”
(Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration)
1 In questi giorni sta tenendo banco sui Social e nei media il tema riguardante l’approvazione del Global Compact for Safe, Orderly and Regular migration (per brevità, GCSORM), ovvero l’accordo promosso in sede ONU e che sarebbe finalizzato a dare una risposta globale al fenomeno della migrazione. Tra le voci che si sovrappongono a favore e contro detto accordo, sembra soprattutto passare inosservato il fatto che il GCSORM non è una misura estemporanea partorita improvvisamente dal nulla, ma costituisce un documento inserito in una logica e ben congegnata “sequenza procedimentale” per dare specifica attuazione ad un disegno molto più vasto che l’Ordine sopranazionale dei M€rcati ha tracciato già da tempo.
2 In questa sequenza, ed evitando di risalire troppo nel tempo (per esempio, alla International Conference on Population and Development tenutasi nel lontano 1994 al Cairo), bisogna innanzi tutto prendere le mosse dalla distopica volontà di “trasformare il nostro mondo” contenuto in quel capolavoro cosmetico chiamato “Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile” adottata all’unanimità (quindi anche con il contributo del rappresentante italiano pro tempore) dall’Assemblea Generale dell’ONU con Risoluzione del 25 settembre 2015, entrata in vigore il 1° gennaio 2016 e che ha il compito di orientare i successivi sviluppi per i prossimi 15 anni. Come risulta da documenti parlamentari, l’Agenda “ha sostituito i precedenti Obiettivi di Sviluppo del Millennio (Millennium Development Goals) che avevano orientato l’azione internazionale di supporto nel periodo 2000-2015”. La nuova Agenda globale si propone, in particolare, di raggiungere i seguenti 17 obiettivi pubblicizzati alla stregua di un nuovo e meraviglioso paese di Bengodi, obiettivi ai quali sono associati “169 traguardi … che sono interconnessi e indivisibili” (così al punto 18, pag. 6, dell’Agenda):
- Details
- Hits: 2338
Perché dopo la crisi del 2008 l’agenda neoliberale è ancora dominante?
di Massimo De Minicis
La crisi del 2008 ha dimostrato che le politiche economiche mainstream sono dannose e fallimentari, ma la “retorica” neoliberale riesce ancora dominare il dibattito e le istituzioni e ad imporre pericolosamente la sua agenda
 Dalla metà degli anni ’90, nel sistema a capitalismo avanzato, una crescente interdipendenza e accresciuta competizione tra le nazioni, identificata nel concetto teorico della globalizzazione ha determinato le basi concettuali per identificare nello stato sociale del periodo post-bellico europeo un lusso non più sostenibile: “nel dibattito svedese, è normale ritenere che l’egualitarismo degli anni ’70 non sia sostenibile e che l’uguaglianza debba, in una certa misura, essere sacrificata sull’altare dell’efficienza” (Crouch, Streek 1996).
Dalla metà degli anni ’90, nel sistema a capitalismo avanzato, una crescente interdipendenza e accresciuta competizione tra le nazioni, identificata nel concetto teorico della globalizzazione ha determinato le basi concettuali per identificare nello stato sociale del periodo post-bellico europeo un lusso non più sostenibile: “nel dibattito svedese, è normale ritenere che l’egualitarismo degli anni ’70 non sia sostenibile e che l’uguaglianza debba, in una certa misura, essere sacrificata sull’altare dell’efficienza” (Crouch, Streek 1996).
Negli stessi anni gli ambienti politici dell’Unione europea hanno rappresentato un costante discorso teorico secondo cui la globalizzazione esponeva i paesi comunitari ad una serie di sfide di fronte alle quali dovevano essere riorganizzate le modalità di governance del welfare e del sistema delle relazioni industriali. Ciò sembra aver determinato una serie di vincoli esterni per le forme istituzionali prodotti attraverso un processo di persistente normalizzazione di tali presupposti teorici. Si è andata, così, consolidando una sorta di traiettoria neoliberale (Baccaro, Howell, 2011) che ha percorso anche i processi di integrazione europea per rispondere in maniera efficace agli imperativi dell’economia globale. Procedendo a rideterminare il peculiare “modello sociale europeo” emerso e consolidatosi nel primo dopoguerra (Hay, 2003). Una serie di posizioni ideali, che prefiguravano nella variante neoliberale di integrazione comunitaria la forma migliore per rispondere ai nuovi imperativi economici, hanno assunto effetti costrittivi e vincolanti per le società europee in assenza di manifeste conferme empiriche: “gli effetti reali dei discorsi economici sulla globalizzazione sono qualcosa di indipendente dalla veridicità delle analisi” (Hay, 2001).
- Details
- Hits: 1291
I gilets jaunes e la soggettività al tempo della crisi
di Franco Romanò
 Il documento presentato dai Gilet jaunes alla stampa merita una grande attenzione perché è la prima volta che un movimento di tale ampiezza e consenso sociale arriva alla formulazione di un’agenda politica di rivendicazioni che vanno molto aldilà della causa efficiente che ha dato vita al movimento e cioè le accise sui carburanti le tasse cosiddette ecologiche. L’interesse sta proprio in questa relazione fra una lotta e una piazza reali e non immaginarie, virtuali o di pura opinione e un’agenda politica ampia che nasce nel contesto di quella lotta. Nel merito dei 41 punti presentati due giorni fa in conferenza stampa e che pubblico alla fine di questa riflessione, ognuno potrà farsi una propria idea. Credo sia utile, invece, discutere una questione preliminare e cioè quale tipo di soggetto s’è affacciato improvvisamente nel cuore dell’Europa, con un’azione politica di massa, diffusa e dirompente e circondata dal consenso da parte di un popolo forse meno afflitto di altri da cretinismo legalitario, per ragioni storiche. La questione è prioritaria perché di lotte ne esistono un po’ ovunque in Europa e nel mondo e anche in Italia: dalla nuova ondata mondiale dei movimenti femministi, alle lotte territoriali, dalle fabbriche recuperate e occupate agli scioperi nel settore della logistica e dei riders o a forme più tradizionali di conflitto operaio piuttosto che le mobilitazioni di studenti e insegnanti. In che cosa consiste la diversità del soggetto dei gilet jaunes e anche del tipo di soggettività che si è espresso in Francia in queste quattro settimane? Senz’altro la difficoltà di ricondurlo a categorie certe o almeno note, il che ha messo in crisi un po’ tutti. Lasciamo perdere chi me parla come di un movimento delle classi medie impoverite o addirittura della piccola borghesia e crede con questo di avere chiuso il problema: sono gli stessi che hanno preteso per decenni di sostenere che la lotta di classe era un residuo del passato e poi si scoprono a dare risposte sociologiche classiste del tutto fuorvianti e ridicolmente superficiali.
Il documento presentato dai Gilet jaunes alla stampa merita una grande attenzione perché è la prima volta che un movimento di tale ampiezza e consenso sociale arriva alla formulazione di un’agenda politica di rivendicazioni che vanno molto aldilà della causa efficiente che ha dato vita al movimento e cioè le accise sui carburanti le tasse cosiddette ecologiche. L’interesse sta proprio in questa relazione fra una lotta e una piazza reali e non immaginarie, virtuali o di pura opinione e un’agenda politica ampia che nasce nel contesto di quella lotta. Nel merito dei 41 punti presentati due giorni fa in conferenza stampa e che pubblico alla fine di questa riflessione, ognuno potrà farsi una propria idea. Credo sia utile, invece, discutere una questione preliminare e cioè quale tipo di soggetto s’è affacciato improvvisamente nel cuore dell’Europa, con un’azione politica di massa, diffusa e dirompente e circondata dal consenso da parte di un popolo forse meno afflitto di altri da cretinismo legalitario, per ragioni storiche. La questione è prioritaria perché di lotte ne esistono un po’ ovunque in Europa e nel mondo e anche in Italia: dalla nuova ondata mondiale dei movimenti femministi, alle lotte territoriali, dalle fabbriche recuperate e occupate agli scioperi nel settore della logistica e dei riders o a forme più tradizionali di conflitto operaio piuttosto che le mobilitazioni di studenti e insegnanti. In che cosa consiste la diversità del soggetto dei gilet jaunes e anche del tipo di soggettività che si è espresso in Francia in queste quattro settimane? Senz’altro la difficoltà di ricondurlo a categorie certe o almeno note, il che ha messo in crisi un po’ tutti. Lasciamo perdere chi me parla come di un movimento delle classi medie impoverite o addirittura della piccola borghesia e crede con questo di avere chiuso il problema: sono gli stessi che hanno preteso per decenni di sostenere che la lotta di classe era un residuo del passato e poi si scoprono a dare risposte sociologiche classiste del tutto fuorvianti e ridicolmente superficiali.
- Details
- Hits: 2188
La frammentazione del lavoro
di Francesco Ciafaloni
 Nel corso della sua esistenza terrena, un’idea, sempre e dovunque, opera contro il suo significato originario e perciò si distrugge.
Nel corso della sua esistenza terrena, un’idea, sempre e dovunque, opera contro il suo significato originario e perciò si distrugge.
Marianne Weber, Max Weber: A Biography
1. La situazione presente
La frammentazione del lavoro, la sua rarefazione, è sotto gli occhi di tutti. Non è svanita solo la fabbrica tayloristica; sono sparite le aziende come enti giuridici che tengono insieme progettazione, produzione, vendita, gestione del personale, contabilità, come era normale qualche decennio fa. Non solo le piccole aziende fanno gestire la contabilità all’esterno, ma ciò che resta delle aziende grandi è tenuto insieme solo dal marchio e dal controllo finanziario. I singoli stabilimenti possono essere entità autonome, con contratti diversi. Sotto lo stesso tetto, a contatto di gomito, ci sono lavoratori impegnati nella stessa attività produttiva che dipendono da aziende diverse, mentre lo stesso gruppo o conglomerato, lo stesso ente finanziario, può svolgere le attività più disparate.
Molti lavori non sono scomparsi, si sono solo spostati dove il lavoro viene pagato poco o nulla. Anche lavori in cui la lingua è fondamentale, come i call center, vengono trasferiti dove ci sono abbastanza lavoratori in grado di parlare la lingua del paese destinatario. Vale anche per lingue non veicolari, come l’italiano. Lo sappiamo dai giornali, per le vertenze, come quelle di Almaviva, e ce ne rendiamo conto dalle telefonate promozionali non richieste, con un forte accento, che riceviamo.
Si può dire che è il mercato, bellezza! Che è la globalizzazione. Che così va il mondo e a questo dobbiamo abituarci; che così le merci e i servizi vengono prodotti in modo più efficiente, che costano di meno; che se molti posti di lavoro si distruggono con l’automazione e l’informatica, molti altri, più qualificati, se ne creano. È il capitalismo, la distruzione creatrice!
- Details
- Hits: 2632
Il paradosso del doppio legame UE
di Nicoletta Forcheri
 Funziona così, l’ingiunzione paradossale. Amami, detto con voce di odio. Abbracciami, detto con le braccia incrociate. Oppure: Aumenta il PIL! Detto con l’ordine di ridurre il deficit/pil e la spesa pubblica netta!
Funziona così, l’ingiunzione paradossale. Amami, detto con voce di odio. Abbracciami, detto con le braccia incrociate. Oppure: Aumenta il PIL! Detto con l’ordine di ridurre il deficit/pil e la spesa pubblica netta!
L’Italia si trova sotto ingiunzione paradossale, in quello che gli psicologi chiamano il doppio legame. Io lo chiamerei doppio cappio. Doppiamente illegittimo: anticostituzionale e anti trattati UE. Per uscirne basta evidenziarne il paradosso e la contraddizione di chi, dall’UE, ingiunge ordini cinici e schizofrenici.
Premesso che dai Trattati firmati, come Maastricht in primis e MES, che prevedono un rapporto debito/PIL 60% e un deficit/PIL di massimo il 3%, niente si evince della legittimità dell’obbligo di rimanere sotto il 2% del rapporto deficit/PIL.
Non contenti, i nostri politicanti hanno firmato il Fiscal Compact nel 2012, in Italia con un governo NON eletto, Monti dopo il golpe a Berlusconi, anzi illegittimo e dichiarato tale dalla Corte costituzionale. Il Fiscal Compact, è un trattato aggiuntivo NON inserito nel corpo dei trattati UE e TFUE e a cui, ad esempio, la Repubblica ceca e la Gran Bretagna non hanno aderito. Così come è stato sottoscritto, può senza problemi essere rescisso, a differenza dei trattati UE, la cui revoca è più complessa, non per questo non auspicabile né impossibile, almeno da Maastricht in poi.
Noi abbiamo aderito in situazione di scacco, ricatto e golpe politico: il governo Monti che, ripeto, era illegittimo. Sempre con questo governo imposto dall’alto, è stato adottato dal Parlamento, lo sfregio alla Costituzione nell’articolo 81 con l’obbligo di pareggio di bilancio nei conti pubblici. Sempre il Fiscal Compact (1), introduceva l’obbligo, più severo ancora rispetto ai criteri di Maastricht e al Trattato di Stabilità che istituiva il MES nel 1997, di ridurre di 1/20 l’anno il rapporto debito/PIL.
- Details
- Hits: 2337
Gilet gialli, rossi e Negri
di Militant
 Dopo un mese di mobilitazione, è ormai luogo comune entusiasmarsi per le vicende francesi. Se invece del sostegno politico ci spostassimo sulla riflessione cosciente, la cosa meno improbabile è stata scritta da Toni Negri (L’insurrezione francese). Dal punto di vista politico, però, occorre sgomberare il terreno dalle parodie deliro-marxistiche che, come quasi sempre, corrono in soccorso del potere costituito: “non è una rivolta di classe”, ammoniscono solerti difensori di ogni status quo. Come se nelle rivolte di classe fosse mai apparsa, in qualche angolo della storia, quella purezza alla quale tali pensatori rimandano: «si comincia, poi si vede», diceva Lenin riprendendo Napoleone. Ed è dentro questo spirito che tutte le forze rivoluzionarie si sono sempre mosse: nell’occasione, che non è né predeterminata né socialmente definita. Fatta dunque la premessa che in una rivolta politico-sociale ci si sta fino a che la finestra di possibilità rimane aperta, anche fosse un solo spiraglio, se al contrario volessimo tentarne un’analisi occorrerebbe frenare i facili entusiasmi che circolano ormai in tutte le gradazioni della politica, da Forza Italia all’estrema sinistra (esclusa, come detto, la parodia gendarme celata dietro prose marxiste).
Dopo un mese di mobilitazione, è ormai luogo comune entusiasmarsi per le vicende francesi. Se invece del sostegno politico ci spostassimo sulla riflessione cosciente, la cosa meno improbabile è stata scritta da Toni Negri (L’insurrezione francese). Dal punto di vista politico, però, occorre sgomberare il terreno dalle parodie deliro-marxistiche che, come quasi sempre, corrono in soccorso del potere costituito: “non è una rivolta di classe”, ammoniscono solerti difensori di ogni status quo. Come se nelle rivolte di classe fosse mai apparsa, in qualche angolo della storia, quella purezza alla quale tali pensatori rimandano: «si comincia, poi si vede», diceva Lenin riprendendo Napoleone. Ed è dentro questo spirito che tutte le forze rivoluzionarie si sono sempre mosse: nell’occasione, che non è né predeterminata né socialmente definita. Fatta dunque la premessa che in una rivolta politico-sociale ci si sta fino a che la finestra di possibilità rimane aperta, anche fosse un solo spiraglio, se al contrario volessimo tentarne un’analisi occorrerebbe frenare i facili entusiasmi che circolano ormai in tutte le gradazioni della politica, da Forza Italia all’estrema sinistra (esclusa, come detto, la parodia gendarme celata dietro prose marxiste).
E qui Toni Negri coglie nel segno. Negri non ha l’entusiasmo del neofita, che si impressiona di ogni simulacro di rivolta sociale. Riconosce che lo spazio «dell’insurrezione», come lui la definisce, va lasciato aperto, va allargato e organizzato, più che richiuderlo attraverso scomuniche libresche. Eppure ci sono fattori particolari alla base di una rivolta simile che vanno tenuti in considerazione. Questa è una rivolta che ha ragioni generali, legate al processo di straordinario impoverimento determinato dalla fase neoliberale, ma ha anche ragioni specifiche, «francesi», che la rendono difficilmente replicabile altrove. Partiamo dalle ragioni generali.
Page 293 of 610