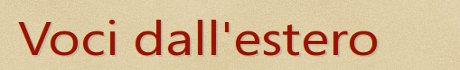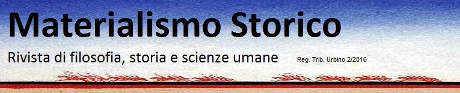Fai una donazione
Questo sito è autofinanziato. L'aumento dei costi ci costringe a chiedere un piccolo aiuto ai lettori. CHI NON HA O NON VUOLE USARE UNA CARTA DI CREDITO può comunque cliccare su "donate" e nella pagina successiva è presente (in alto) l'IBAN per un bonifico diretto________________________________
- Details
- Hits: 2834
L’euro, un’idea insensata
di Ashoka Mody
Intervistato da Tim Black di “Spiked”, Ashoka Mody – professore di economia a Princeton e già dirigente presso il Fondo monetario internazionale – conferma quello che gli economisti sanno, ma la stampa spesso nega: l’euro è stata fin dall’inizio una pessima idea sia economica sia politica. La rigidità intrinseca dei tassi di cambio, le folli regole fiscali, il dominio delle nazioni forti che impongono regole riservate a quelle deboli, creano i presupposti per la divergenza economica e l’inimicizia politica tra le nazioni, anziché promuovere prosperità e pace come propagandano i sostenitori del progetto europeo. Non sono quindi i populisti a essere euroscettici: sono gli euristi che vivono in una bolla di irrealtà, ignorando i più elementari ragionamenti economici e politici
 “Si è trattato di uno sforzo un po’ solitario”, dice Ashoka Mody – professore di economia presso l’Università di Princeton, e già vicedirettore del dipartimento europeo del Fondo monetario internazionale (Fmi) – parlando di ”Eurotragedia: un dramma in nove atti”, la sua brillante, magistrale storia della Ue e dello sviluppo dell’eurozona. “La gran parte dell’establishment europeo” continua Mody “o ha tentato di ignorare o ha contestato quelli che mi sembrano principi e dati economici assolutamente basilari”.
“Si è trattato di uno sforzo un po’ solitario”, dice Ashoka Mody – professore di economia presso l’Università di Princeton, e già vicedirettore del dipartimento europeo del Fondo monetario internazionale (Fmi) – parlando di ”Eurotragedia: un dramma in nove atti”, la sua brillante, magistrale storia della Ue e dello sviluppo dell’eurozona. “La gran parte dell’establishment europeo” continua Mody “o ha tentato di ignorare o ha contestato quelli che mi sembrano principi e dati economici assolutamente basilari”.
È facile capire perché l’establishment europeo potrebbe essere stato incoraggiato a farlo. Eurotragedia è un atto d’accusa all’intero progetto europeo postbellico, una dissezione meticolosa e abrasiva di tutto quello che è caro all’establishment europeo. Ed è anche un attacco allo stesso establishment, al pensiero di gruppo dei suoi membri, ai loro deliri, alla loro arroganza tecnocratica. Inoltre, tutto questo viene dal principale rappresentante del Fmi in Irlanda durante il suo salvataggio dopo le crisi bancaria post-2008 – una persona cioè che ha visto dall’interno i meccanismi fiscali della Ue.
Spiked ha intervistato Mody per capire meglio la sua analisi critica del progetto europeo, i difetti fatali dell’eurozona e perché l’integrazione europea sta dividendo i popoli.
* * * *
Spiked: Lei pensa che il suo lavoro su Eurotragedia sia stato solitario perché, dopo la Brexit e altri movimenti populisti, l’establishment Ue è al momento molto arroccato sulla difensiva?
Ashoka Mody: Sono sicuro che in parte la ragione è questa. Ma penso che la natura dell’intero progetto sia molto difensiva. Pensate alla dichiarazione di Robert Schuman del 9 maggio 1950, che mise le basi per la Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio due anni dopo – disse che una fonte comune di sviluppo economico doveva diventare il fondamento della federazione europea.
- Details
- Hits: 2506
Protezionismo e delocalizzazioni: perché la politica di Trump è sbagliata
di Fabrizio Antenucci
I dazi introdotti da Trump non contrastano le delocalizzazioni perché non colpiscono le imprese con residenza fiscale negli USA. Sarebbe meglio agire su un altro aspetto: controlli dei movimenti di capitale
 Da quando Trump si è insediato alla Casa Bianca, il protezionismo è tornato ad essere un argomento di estrema attualità. Fin dall’inizio della sua campagna elettorale, il nuovo presidente degli Stati Uniti si è rivolto ai lavoratori della manifattura promettendo di recuperare posti di lavoro nel territorio nazionale, affermando che ogni decisione riguardante commercio, tasse, immigrazione, e affari esteri sarebbe stata “presa a vantaggio dei lavoratori americani e delle famiglie americane”. Stando alle sue intenzioni, le misure protezionistiche avrebbero dovuto da un lato disincentivare le aziende a delocalizzare la produzione, e dall’altro ad imporre barriere al commercio internazionale. Cosa è successo dall’inizio del suo mandato?
Da quando Trump si è insediato alla Casa Bianca, il protezionismo è tornato ad essere un argomento di estrema attualità. Fin dall’inizio della sua campagna elettorale, il nuovo presidente degli Stati Uniti si è rivolto ai lavoratori della manifattura promettendo di recuperare posti di lavoro nel territorio nazionale, affermando che ogni decisione riguardante commercio, tasse, immigrazione, e affari esteri sarebbe stata “presa a vantaggio dei lavoratori americani e delle famiglie americane”. Stando alle sue intenzioni, le misure protezionistiche avrebbero dovuto da un lato disincentivare le aziende a delocalizzare la produzione, e dall’altro ad imporre barriere al commercio internazionale. Cosa è successo dall’inizio del suo mandato?
Le misure commerciali prese dalla nuova amministrazione vedono coinvolte soltanto indirettamente la Cina e l’Unione Europea: si tratta di dazi imposti su alcune categorie di beni, senza alcun riferimento a specifici paesi. Tali misure, che rivelano preoccupazione per una eccessiva sofferenza dell’economia statunitense nella competizione internazionale, non sono affatto una novità. D’altronde, il saldo delle partite correnti risulta perennemente in negativo dall’amministrazione Reagan. È opinione diffusa, a tal riguardo, che un saldo commerciale negativo rifletta un peggioramento dello stato di salute delle imprese, contribuendo inoltre alla perdita di posti di lavoro. In effetti, a partire dalla fine degli anni ’70, il settore manifatturiero statunitense ha registrato una forte contrazione occupazionale, coinciso di fatto con il peggioramento del saldo delle partite correnti (Borjas et al., 1992). Si tratta di fenomeni entrambi verificati in concomitanza di un progressivo processo di apertura al commercio estero avviato con la ratifica di diversi accordi internazionali tra cui il GATT (Tokyo Round 1973-79, Uruguay Round 1986-1994) e il NAFTA (1994), fino alla costituzione della World Trade Organization (WTO) nel 1995.
- Details
- Hits: 2197
L’euro non è un errore di calcolo
di coniarerivolta
 Lo scorso 1° gennaio l’euro ha compiuto i suoi primi venti anni di vita. Dovremmo ormai aver maturato la giusta consapevolezza su come giudicare l’attuale progetto di integrazione europea, culminato nell’unione monetaria del 1999: oltre alle venti candeline, l’Unione Europea ha spento qualsiasi possibilità di attuazione di politiche emancipatorie per le classi meno abbienti e ha contribuito in maniera decisiva alla depoliticizzazione delle decisioni di politica economica, ormai dipinte quasi esclusivamente come scelte tecniche. Una cosa, tuttavia, non è riuscita ancora a spegnere a distanza di due decenni: anche in sedi apparentemente più illustri del bar sotto casa, qualcuno si chiede ancora perché la parità dell’euro sia stata fissata a 1936.27 lire, asserendo contestualmente che la situazione di arretratezza economica e sociale in cui versano da anni i paesi periferici, Italia in primis, sia stata in gran parte generata da un cambio ‘sbagliato’.
Lo scorso 1° gennaio l’euro ha compiuto i suoi primi venti anni di vita. Dovremmo ormai aver maturato la giusta consapevolezza su come giudicare l’attuale progetto di integrazione europea, culminato nell’unione monetaria del 1999: oltre alle venti candeline, l’Unione Europea ha spento qualsiasi possibilità di attuazione di politiche emancipatorie per le classi meno abbienti e ha contribuito in maniera decisiva alla depoliticizzazione delle decisioni di politica economica, ormai dipinte quasi esclusivamente come scelte tecniche. Una cosa, tuttavia, non è riuscita ancora a spegnere a distanza di due decenni: anche in sedi apparentemente più illustri del bar sotto casa, qualcuno si chiede ancora perché la parità dell’euro sia stata fissata a 1936.27 lire, asserendo contestualmente che la situazione di arretratezza economica e sociale in cui versano da anni i paesi periferici, Italia in primis, sia stata in gran parte generata da un cambio ‘sbagliato’.
Semplificando, il tasso di cambio ci indica quante unità della nostra moneta occorrono per acquistare una unità della moneta di un altro Paese. Perché ci occorre acquistare valuta estera? Ad esempio, se avessimo intenzione di acquistare un telefonino da un produttore americano, questo vorrà essere pagato in dollari statunitensi (che potrà ad esempio usare per andare a cena in un ristorante di New York, dove difficilmente saranno accettati euro), e pertanto avremo la necessità di ‘cambiare’ i nostri euro in dollari: di fatto, staremmo cedendo euro in cambio di dollari ad un dato tasso di cambio. Nell’ipotesi che un telefonino sia venduto a 800 dollari, dovremmo pertanto disporre dell’equivalente in euro di quegli 800 dollari, cambiarli da un intermediario (ad esempio, una banca) al tasso di cambio corrente, e una volta ottenuti i dollari (anche se questo passaggio non lo vediamo materialmente, avviene nei terminali degli intermediari) effettuare l’acquisto del telefonino.
- Details
- Hits: 2758
Dove sbaglia la “sinistra sovranista”
di Fabrizio Marchi
 Ho letto questo articolo di Carlo Formenti https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/14088-carlo-formenti-l-ideologia-antistatalista-e-l-autodistruzione-delle-sinistre.html che è in buona parte condivisibile.
Ho letto questo articolo di Carlo Formenti https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/14088-carlo-formenti-l-ideologia-antistatalista-e-l-autodistruzione-delle-sinistre.html che è in buona parte condivisibile.
Tuttavia mi pare che nella sua posizione così come in quelle dei vari esponenti della neonata “sinistra sovranista” ci sia un eccesso di enfasi nei confronti dei concetti di nazione e di patria. Non è un caso che l’autore concluda l’articolo con una citazione del subcomandante Marcos che difende lo stato nazionale contro il tentativo di distruggerlo da parte del grande capitalismo transnazionale.
Ma è soltanto l’ultima in ordine di apparizione. Fino ad ora il più gettonato negli ambienti della suddetta sinistra sovranista è stato sicuramente Palmiro Togliatti, storico leader del PCI che – pur essendo “cosa” completamente altra rispetto a Marcos per cultura, formazione politica e contesto storico-politico – sosteneva la necessità di difendere e rafforzare lo stato nazionale che in Italia – è bene ricordarlo – scaturiva dalla guerra di liberazione contro il nazifascismo ed era il risultato di una gigantesca mediazione tra forze politiche nazionali e internazionali assai diverse che portò al “varo” della Costituzione Italiana.
Ora, la funzione delle citazioni è quella di individuare quei precedenti storici (autorevoli…) con i quali rafforzare e “giustificare” le proprie posizioni, specie quando queste sono tacciate dagli avversari di essere pericolose, ambigue o addirittura reazionarie. A mio parere è un atteggiamento di debolezza e non di forza, perché se si è veramente convinti delle proprie opinioni non c’è necessità di ricorrere ai suddetti “precedenti”, anche perché la storia e la politica non funzionano come la giurisprudenza e ciò che poteva essere valido per il passato potrebbe non esserlo più per l’oggi. Ma non è questo il punto che volevo ora trattare (e mi interessa anche poco).
- Details
- Hits: 3134
Rivoluzione in occidente e vincolo europeo
Riflessioni a margine di Sovranità o barbarie di Fazi e Mitchell
di Domenico Moro
 Recentemente è uscito in libreria Sovranità o barbarie di Thomas Fazi e William Mitchell (Meltemi editore, euro 20, pp. 315). Si tratta di un testo che raccomandiamo a chi sia interessato non solo ai temi dell’Europa, ma anche alla ricostruzione di una sinistra adeguata alla realtà attuale. A differenza della maggioranza dei testi sull’euro e sulla Ue, Sovranità o barbarie non parla solo di economia o soltanto di diritto e istituzioni europei. La riflessione che vi viene svolta è interdisciplinare, offrendo una articolata sintesi delle implicazioni dell’integrazione europea, oltre che per l’economia, per lo Stato e le sue istituzioni, per i concetti di nazione e identità nazionale e soprattutto per la democrazia. Di semplice lettura, grazie a una prosa scorrevole e molto chiara, è un testo, però, mai banale, che guida il lettore attraverso un intreccio di questioni complesse e controverse, che riguardano il “che fare”. Per questo, Sovranità o barbarie è soprattutto un libro politico, nel senso più ampio del termine, e va letto a più livelli, che, anche se a volte implicitamente, investono tre questioni principali:
Recentemente è uscito in libreria Sovranità o barbarie di Thomas Fazi e William Mitchell (Meltemi editore, euro 20, pp. 315). Si tratta di un testo che raccomandiamo a chi sia interessato non solo ai temi dell’Europa, ma anche alla ricostruzione di una sinistra adeguata alla realtà attuale. A differenza della maggioranza dei testi sull’euro e sulla Ue, Sovranità o barbarie non parla solo di economia o soltanto di diritto e istituzioni europei. La riflessione che vi viene svolta è interdisciplinare, offrendo una articolata sintesi delle implicazioni dell’integrazione europea, oltre che per l’economia, per lo Stato e le sue istituzioni, per i concetti di nazione e identità nazionale e soprattutto per la democrazia. Di semplice lettura, grazie a una prosa scorrevole e molto chiara, è un testo, però, mai banale, che guida il lettore attraverso un intreccio di questioni complesse e controverse, che riguardano il “che fare”. Per questo, Sovranità o barbarie è soprattutto un libro politico, nel senso più ampio del termine, e va letto a più livelli, che, anche se a volte implicitamente, investono tre questioni principali:
-
La descrizione dei meccanismi e le implicazioni su economia e politica dell’integrazione europea, coniugate alla critica al sovra-nazionalismo legato alla mondializzazione;
-
La critica dell’atteggiamento della sinistra europea degli ultimi trenta o quaranta anni rispetto alla mondializzazione e all’integrazione europea;
-
La questione della definizione di una politica di sinistra efficace nei Paesi avanzati, ossia le specificità di quella che Gramsci chiamava la “Rivoluzione in Occidente”.
Oggettivamente, “Sovranità o barbarie”, partendo dalla questione europea, va a investire la questione più complessiva di quale sia, in Europa, la politica da adottare da parte delle classi subalterne e del lavoro salariato su un piano strategico, a fronte a una delle maggiori sconfitte storiche della sinistra.
- Details
- Hits: 2473
La scoperta del plusvalore relativo
di Maria Turchetto*
Abstract: We analyze the Chapter 10 of Capital’s Volume I «The Concept of Relative Surplus-value» highlighting come important concepts: 1) the industrial and mass character of production as consequences of the relative surplus-value; 2) extra-profits and dissemination of innovations; 3) the combined operation of absolute and relative surplus-value
 1. Tra la terza e la quarta sezione
1. Tra la terza e la quarta sezione
Il cap. 10 del Libro I del Capitale definisce il concetto di «plusvalore relativo», ponendosi tra la terza sezione, dedicata a La produzione del plusvalore assoluto (capp. 5-9) e la quarta sezione, dedicata appunto a La produzione del plusvalore relativo (capp. 10-13). Queste sezioni rappresentano il cuore del Libro I, il nucleo essenziale della rivoluzione scientifica prodotta da Marx.
La terza sezione ci ha condotti «nel segreto laboratorio della produzione sulla cui soglia sta scritto No admittance except on business» (Marx 1975, 212), dove finalmente si svela l’arcano della produzione di plusvalore, rimasto inaccessibile all’analisi degli economisti classici. Com’è noto, la distinzione cruciale introdotta da Marx è quella tra forza-lavoro, oggetto di acquisto nella sfera della circolazione al suo valore di scambio, e lavoro, ossia uso della forza-lavoro nel «processo di produzione immediato». Il processo di produzione immediato, indagato cioè «allo stato puro […] facendo astrazione da tutti i fenomeni che nascondono il giuoco interno del suo meccanismo» e in particolare dal «movimento mediatore della circolazione» (Marx 1975, 694), oggetto dell’intero Libro I (cfr. Marx 1975, 7), rappresenta, come scrive Louis Althusser (2006, 21), l’«enorme svista» degli economisti classici, la zona d’ombra che impedisce loro di riconoscere lo sfruttamento capitalistico. Non si tratta, ovviamente, come Althusser (2006, 21) sottolinea con grande efficacia, di non cogliere un dato, qualcosa che «tuttavia era sotto gli occhi, […] a portata di mano». Si tratta di un più delicato problema di costruzione dell’oggetto scientifico o del campo di indagine.
- Details
- Hits: 1815
Con i gilet gialli: contro la rappresentanza, per la democrazia
di Pierre Dardot e Christian Laval
Abbiamo tradotto un contributo sui gilet gialli scritto dal filosofo Pierre Dardot e dal sociologo Christian Laval per il portale d’informazione indipendente francese Mediapart. Lo scritto è del 12 dicembre scorso, ma rimane di indubbia attualità politica proprio alla luce della continuità di eventi insurrezionali e dell’evoluzione organizzativa dei gilet gialli avutasi nell’ultimo mese
 Raramente nella storia un Presidente della Repubblica è stato così odiato come lo è oggi Emmanuel Macron. Il suo solenne discorso televisivo del 10 dicembre e le briciole che distribuisce con "compassione" ai più poveri, senza invertire in alcun modo le misure ingiuste che aveva incoraggiato o deciso - prima come consigliere di Hollande, poi come ministro dell'Economia e infine come presidente - non cambieranno questo dato di fatto.
Raramente nella storia un Presidente della Repubblica è stato così odiato come lo è oggi Emmanuel Macron. Il suo solenne discorso televisivo del 10 dicembre e le briciole che distribuisce con "compassione" ai più poveri, senza invertire in alcun modo le misure ingiuste che aveva incoraggiato o deciso - prima come consigliere di Hollande, poi come ministro dell'Economia e infine come presidente - non cambieranno questo dato di fatto.
La spiegazione di questo rifiuto massiccio è ben nota: il disprezzo di classe che ha dimostrato, sia nelle azioni che nelle parole, gli viene restituito con violenza, con tutta la forza di una popolazione arrabbiata, e non c'è nulla di più meritato. Con la sollevazione sociale dei gilet gialli, il velo si è strappato, almeno per un po'. Il "nuovo mondo" è quello vecchio in peggio: questo è il messaggio principale inviato da chi dallo scorso novembre indossa il gilet giallo.
Nel 2017, Macron e il suo partito-azienda «En marche» hanno sfruttato il profondo odio della classe operaia e della classe media nei confronti dei governanti che fino ad allora avevano solo peggiorato la loro situazione lavorativa e di vita per imporsi contro ogni aspettativa nella corsa alla presidenza. In questa scalata istituzionale, Macron non ha esitato a utilizzare cinicamente il registro populista del dégagisme e di una finta “verginità” politica per vincere, lui che non è mai stato nient’altro che il «candidato dell'oligarchia», in particolare di quella corporazione élitaria che fa capo all'ispettorato finanziario[1].
L’operazione è stata grezza, ma ha funzionato per difetto. Ha vinto, con idee minoritarie, con un doppio voto di rifiuto, al primo turno dei partiti neoliberali-autoritari (i partiti gemelli Socialista e dei Repubblicani) e al secondo turno della candidata del partito neofascista francese.
- Details
- Hits: 3894
Nei Quaderni filosofici di Lenin: lo studio della Logica e la lettura del proprio tempo
di Emiliano Alessandroni
Abstract. In the 50s and 60s of the twentieth century, Lucio Colletti developed a requisition against Hegel and against those elements of his philosophy that had penetrated into Marxism. The main thesis is simple and clear: the more Marxism is contaminated with Hegelism the more it loses scientific consistency. This thesis ends up investing the judgment on the work of Lenin too. The essay in question will show the opposite: the concepts that the Russian revolutionary will find in Hegel’s Logic provide him the tools usefull to avoid the ideological deviations of his time and to identify the theoretical errors committed by Trotsky and the exponents of the Second International, both prisoners of the abstract intellect and of mechanistic ways of thinking. This judgment also belonged to Gramsci, who was not by chance a reader and a profound admirer of Hegel. Both Gramsci and Lenin often accuse Trotsky and the Second Internationalists of not having been able to internalize the dialectical logic, with very serious and dangerous political repercussions
 Nel corso degli anni ‘50 e ‘60 del Novecento, collocandosi lungo la scia tracciata da Galvano Della Volpe, Lucio Colletti sviluppa in Italia una requisitoria contro Hegel e segnatamente contro quegli elementi della filosofia hegeliana che, in modo più o meno volontario, erano penetrati all’interno del marxismo, inficiandone, a suo avviso, la consistenza scientifica. Tre i vizi speculativi tramandati, secondo lo studioso italiano, dalla Scienza della logica e dalla Fenomenologia dello Spirito: 1) l’assorbimento del quadro storico nel quadro ontologico, vale a dire il complessivo disinteresse verso la «molteplicità del reale», portata a vanificarsi entro «una genericità o un’idea che non rimanda né si riferisce a questo o a quell’aspetto del reale, ma si presenta al contrario essa stessa come la sola e intera realtà»1; 2) lo «scambio», per usare la terminologia aristotelica, «del genere con la specie»2; 3) la tendenza a cedere reiteratamente alle lusinghe delle «ipostasi», categorie incapaci «di servire come ipotesi e criteri per l’esperienza» in quanto non desunte da scrupolose osservazioni dell’Oggetto, ma apparse come «un’introduzione surrettizia di contenuti immediati, non controllati»3.
Nel corso degli anni ‘50 e ‘60 del Novecento, collocandosi lungo la scia tracciata da Galvano Della Volpe, Lucio Colletti sviluppa in Italia una requisitoria contro Hegel e segnatamente contro quegli elementi della filosofia hegeliana che, in modo più o meno volontario, erano penetrati all’interno del marxismo, inficiandone, a suo avviso, la consistenza scientifica. Tre i vizi speculativi tramandati, secondo lo studioso italiano, dalla Scienza della logica e dalla Fenomenologia dello Spirito: 1) l’assorbimento del quadro storico nel quadro ontologico, vale a dire il complessivo disinteresse verso la «molteplicità del reale», portata a vanificarsi entro «una genericità o un’idea che non rimanda né si riferisce a questo o a quell’aspetto del reale, ma si presenta al contrario essa stessa come la sola e intera realtà»1; 2) lo «scambio», per usare la terminologia aristotelica, «del genere con la specie»2; 3) la tendenza a cedere reiteratamente alle lusinghe delle «ipostasi», categorie incapaci «di servire come ipotesi e criteri per l’esperienza» in quanto non desunte da scrupolose osservazioni dell’Oggetto, ma apparse come «un’introduzione surrettizia di contenuti immediati, non controllati»3.
- Details
- Hits: 2699
Cosa sta succedendo
di Guido Ortona
I sostenitori di politiche sbagliate non sono quasi mai in mala fede. Prima di proporle riescono quasi sempre a convincere sé stessi che sono giuste (U.D.)
 1. In breve. Che la terra sia sferica è ovvio per chiunque la guardi dallo spazio, ma non lo è per chi si trova al livello del suolo. Analogamente, quello che sta capitando oggi in Italia sembra molto confuso se si segue la cronaca politica mentre diventa più chiaro se si usa una prospettiva storica. Se adottiamo questa ottica scopriamo che ciò che sta capitando è un fenomeno non nuovo, e non nuove sono alcune caratteristiche che ne conseguono.
1. In breve. Che la terra sia sferica è ovvio per chiunque la guardi dallo spazio, ma non lo è per chi si trova al livello del suolo. Analogamente, quello che sta capitando oggi in Italia sembra molto confuso se si segue la cronaca politica mentre diventa più chiaro se si usa una prospettiva storica. Se adottiamo questa ottica scopriamo che ciò che sta capitando è un fenomeno non nuovo, e non nuove sono alcune caratteristiche che ne conseguono.
In breve: l’Italia è al centro di un processo di annessione a uno stato più forte, la nascente Europa a egemonia tedesca, come area debole destinata a essere colonizzata. E’ possibile che la nascente Europa dei padroni esploda nella culla per eccesso di ingordigia, come la rana della favola. Ma è meglio non farci troppo affidamento. Se ciò non avviene, il destino dell’Italia sarà analogo a quello dell’Italia meridionale nei confronti di quella settentrionale o degli Stati Confederati americani a seguito della guerra civile, vale a dire la condanna al sottosviluppo (rispetto alle aree forti), a seguito della subordinazione a leggi e istituzioni proprie degli stati vincitori e non solo inadatte a quelli subordinati, ma tali in molti casi da propiziare il loro sfruttamento. Con tutto ciò che ne è conseguito; in particolare la cooptazione delle classi dominanti delle aree subordinate nel sistema di potere di quelle vincitrici, e la subornazione culturale delle aree subordinate. Forse siamo ancora in grado di impedire tutto ciò. Vediamo più in dettaglio.
2. Leggi e istituzioni inapplicabili. Le norme europee prevedono che l’Italia sottragga ogni anno circa 50-70 miliardi alla sua economia per pagare interessi sul debito, somme che vengono investite quasi interamente in altri paesi, data la libera circolazione dei capitali. La libera circolazione di capitali è presentata come una norma sensata, progressiva e tale da massimizzare l’efficienza dell’economia mondiale.
- Details
- Hits: 1750
Dal Niger al Sudan, l’Africa nella morsa dell’ipocrisia clericosinistra
di Fulvio Grimaldi
 Due settimane davanti a Malta. Sarebbero bastate per sbarcare a Calais, Dover o Amburgo
Due settimane davanti a Malta. Sarebbero bastate per sbarcare a Calais, Dover o Amburgo
Grande dibattito e grande esplosione di hate speech, discorsi dell’odio, rancore, invidia sociale (quelli che venivano attribuiti agli italiani che hanno votato questo governo) da parte dell’unanimismo politico-mediatico globalista e antisovranità, sul decreto sicurezza. Hate speech ulteriormente animati dalle due navi di Ong tedesche che girano per il Mediterraneo meridionale. Ong tedesche, vale a dire di quel paese e appoggiate da quel governo (oltreché da George Soros) che, dopo aver raso al suolo la culla della nostra civiltà (nuovamente barbari, alla faccia di Goethe, Bach, Duerer e Schopenhauer), si sono fatti giustizieri, insieme ai francesi e ai burattini di Bruxelles, del timido tentativo italiano di invertire il flusso della ricchezza perennemente dal basso verso l’alto.
Navi tedesche, mi viene da riflettere, che nel corso dei 18 giorni in cui andavano lacrimando su mari in tempesta e migranti, secondo l’immaginifico manifesto “in condizioni disperate” (benché rifornite da Malta di tutto il necessario…), tra Malta e Lampedusa, avrebbero potuto raggiungere, che so, New York, o magari Amburgo, visto che così tante città tedesche si erano dichiarate disposte ad ospitare i profughi. O Rotterdam, visto che è olandese la bandiera della Sea Eye. Non vi pare?
Posto che l’unica cosa buona fatta dal socio neoliberista e ultradestro della maggioranza di governo è stato mettere l’opinione pubblica di fronte al ricatto dell’Europa nei confronti dei paesi rivieraschi del Sud – o mangiate la minestra della destabilizzazione sociale ed economica di un’immigrazione incontrollata, o vi buttiamo dalla finestra -, posto che strumento di questo ricatto è la società anonima creata dal colonialismo tra multinazionali predatrici, trafficanti, Ong, santi peroratori dell’accoglienza senza se e senza ma, per sottrarsi a tale ricatto ritengo il decreto sicurezza del, per altri versi detestabile, fiduciario dei padroni, il minimo indispensabile per salvare una serie di paesi destinati al macero.
- Details
- Hits: 1949
La chimera del capitalismo di pieno impiego
di Roberto Lampa*
Non saranno le “cassette degli attrezzi” di questo o quell’economista a risolvere il problema della disoccupazione perché non si tratta di un problema tecnico ma di una questione meramente politica

Come è stato possibile continuare per anni a imporre politiche economiche di flessibilizzazione e precarizzazione lavorativa, cioè misure incoerenti sul piano teorico e non corroborate da risultati pratici?
Per quanto riguarda la teoria economica, spesso tirata in ballo per giustificare la fondatezza e l’ineluttabilità delle famigerate “riforme” o “jobs act”, Davide Villani ha richiamato efficacemente, su queste pagine, la controversia sul capitale e la cristallina dimostrazione della fallacia del principio di sostituzione fattoriale tra capitale e lavoro, pietra angolare della quasi-totalità delle pubblicazioni mainstream in materia. Teresa Battista ha poi aggiunto un importante tassello a questa premessa, ricordandoci come anche l’evidenza empirica smentisca categoricamente l’esistenza di una qualsivoglia correlazione tra processi di flessibilizzazione del mercato del lavoro e livello di occupazione, trattandosi invece dell’istituzionalizzazione dei rapporti di forza tra capitale e lavoro.
Alla luce di questi contributi, quella posta all’inizio appare quindi come una domanda cruciale, a cui però il sapere tecnico non è in grado di fornire una risposta. Curioso paradosso, in un’epoca nella quale gli economisti si ergono a depositari della verità assoluta, tanto da arrivare a tacciare di negazionismo economico chiunque osi sfidare le rigide implicazioni di politica economica che discendono dalla teoria economica.
Per poter delineare una risposta è dunque indispensabile uscire dagli schemi abituali e partire da un’importante constatazione. La teoria economica attuale – sia nella sua versione dominante che in quella “eterodossa” – assume come dato esogeno un elemento di cruciale importanza: l’esistenza di un sistema capitalista.
In un certo senso, si può perfino affermare che mai come oggi sia accettato acriticamente (e trasversalmente alle scuole economiche) il famoso aforisma di Milton Friedman secondo cui «non esistono l’economia ortodossa e quella eterodossa, ma solo l’economia buona e quella cattiva».
- Details
- Hits: 4035
La lezione dimenticata di Federico Caffè
di Michelangelo Morelli
 Definire Federico Caffè un semplice economista significa banalizzare molti aspetti che contribuiscono a renderlo uno dei personaggi più interessanti del Novecento repubblicano del nostro Paese. Alfiere del pensiero keynesiano e del welfare state, antifascista e attento osservatore della società italiana, Caffè è stato un intellettuale poliedrico ed enciclopedico, capace di ragionar d’economia cogliendo le implicazioni umane, sociali e culturali essenziali per la costruzione di una società fondata sul benessere degli individui.
Definire Federico Caffè un semplice economista significa banalizzare molti aspetti che contribuiscono a renderlo uno dei personaggi più interessanti del Novecento repubblicano del nostro Paese. Alfiere del pensiero keynesiano e del welfare state, antifascista e attento osservatore della società italiana, Caffè è stato un intellettuale poliedrico ed enciclopedico, capace di ragionar d’economia cogliendo le implicazioni umane, sociali e culturali essenziali per la costruzione di una società fondata sul benessere degli individui.
Federico Caffè nacque il 6 gennaio 1914 a Castellammare Adriatico (Pescara), secondogenito di una famiglia economicamente modesta: il padre Vincenzo era un ferroviere, mentre la madre Erminia integrava il magro bilancio famigliare dirigendo un piccolo laboratorio di ricamo. Caffè rimase sempre molto legato alla madre, ereditando da essa la passione per la cultura letteraria, musicale ed estetica che caratterizzò l’eclettica personalità dell’economista per tutta la vita.
Diplomatosi a pieni voti presso l’Istituto Tecnico Tito Acerbo a Castellammare (riunificata con Pescara nel 1926), Caffè si trasferì a Roma da una cugina per frequentare gli studi universitari presso la facoltà di Economia e Commercio della Sapienza. La frequentazione dell’ateneo romano fu possibile grazie alla madre Erminia, che per raccogliere il denaro necessario vendette un piccolo podere di cui era proprietaria, riacquistato in seguito dallo stesso Caffè.
Caffè si laureò cum laude nell’ateneo romano il 17 novembre 1936 con una tesi intitolata L’azione dello Stato considerata nei suoi strumenti finanziari nell’ordinamento autarchico dell’economia italiana, discussa col Professor Guglielmo Masci, suo maestro assieme a Gustavo Del Vecchio. Il tema della tesi è emblematico di quell’attenzione per il ruolo dell’amministrazione centrale nella vita economica che caratterizzò il percorso intellettuale e professionale dell’economista pescarese.
- Details
- Hits: 2259
La Tirannia del Tempo: la critica immanente di Moishe Postone
di Avery Minnelli
 Sono dell'opinione che non esista una cosa che possa assomigliare ad una lettura "neutrale" o "obiettiva" di un testo o di un pensatore politico [*1]. Se una lettura si presenta in tal modo, è molto probabile che dietro ad essa si nasconde quello che è un appello all'autorità (per esempio: «Bene, su questo Lenin è ovviamente d'accordo con me, e Lenin aveva ragione, perciò, ipso facto, io ho ragione»). È stato con la consapevolezza che le interpretazioni sono necessariamente selettive ed intenzionali, che mi sono accostata con la mente aperta al libro di Moishe Postone, "Time, Labor, and Social Domination: A Reinterpretation of Marx’s Critical Theory" (1993) [Il libro, in lingua inglese, può essere liberamente scaricato/e letto cliccando qui] - che da qui in avanti chiamerò TLSD. È per me di primario interesse il fatto che mi possa essere utile il punto di vista dell'interpretazione di Postone in quanto tale, piuttosto che sapere quanto essa possa riflettere da vicino il punto di vista di Marx.
Sono dell'opinione che non esista una cosa che possa assomigliare ad una lettura "neutrale" o "obiettiva" di un testo o di un pensatore politico [*1]. Se una lettura si presenta in tal modo, è molto probabile che dietro ad essa si nasconde quello che è un appello all'autorità (per esempio: «Bene, su questo Lenin è ovviamente d'accordo con me, e Lenin aveva ragione, perciò, ipso facto, io ho ragione»). È stato con la consapevolezza che le interpretazioni sono necessariamente selettive ed intenzionali, che mi sono accostata con la mente aperta al libro di Moishe Postone, "Time, Labor, and Social Domination: A Reinterpretation of Marx’s Critical Theory" (1993) [Il libro, in lingua inglese, può essere liberamente scaricato/e letto cliccando qui] - che da qui in avanti chiamerò TLSD. È per me di primario interesse il fatto che mi possa essere utile il punto di vista dell'interpretazione di Postone in quanto tale, piuttosto che sapere quanto essa possa riflettere da vicino il punto di vista di Marx.
Moishe Postone (1942-2018), è stato spinto a scrivere TLSD dopo aver svolto un approfondito studio dei Grundrisse di Marx. Postone riteneva che la struttura libera di quel testo potesse fornire uno sguardo che avrebbe permesso di visionare il pensiero di Marx, che nei tre volumi del Capitale era stato più dissimulato. Gli argomenti di Postone si basano principalmente sia sui Grundrisse che su Il Capitale; fa ben pochi riferimenti alle opere politiche di Marx, e nel testo Engels è quasi del tutto assente [*2]. In TLSD, Postone imposta il suo progetto come una reinterpretazione di Marx, ponendola in contraddizione con quella che Postone stesso ha definito «Marxismo tradizionale», che egli riteneva non fosse in grado di spiegare quelli che erano stati gli sviluppi avvenuti nel capitalismo post-liberale nel XX secolo.
- Details
- Hits: 2177
Marxismo e questione nazionale
di Sabato Danzilli
La disputa tra comunisti e nazionalisti nella Germania anni Venti nel nuovo libro di Stefano Azzarà
 Il panorama politico degli ultimi tempi sembra essere dominato dallo scontro tra i sostenitori acritici dell’integrazione europea e i “sovranisti” euroscettici. Si tratta di una contrapposizione che si rivela fittizia e del tutto interna a fazioni della classe dominante. Essa tuttavia ha coinvolto anche la cosiddetta sinistra di classe, che si dimostra incapace nel suo elemento maggioritario di sfuggire dal fare codismo all’una o all’altra posizione. Il fronte di chi invoca una supposta maggiore sovranità e democrazia, possibile solo sul terreno dello Stato-nazione, si allarga infatti sempre di più, e aumenta il numero di chi propone un’alleanza che vada oltre la destra e la sinistra, in nome di un comune interesse nazionale, contro il neoliberismo e il capitalismo finanziario dell’alta borghesia cosmopolita.
Il panorama politico degli ultimi tempi sembra essere dominato dallo scontro tra i sostenitori acritici dell’integrazione europea e i “sovranisti” euroscettici. Si tratta di una contrapposizione che si rivela fittizia e del tutto interna a fazioni della classe dominante. Essa tuttavia ha coinvolto anche la cosiddetta sinistra di classe, che si dimostra incapace nel suo elemento maggioritario di sfuggire dal fare codismo all’una o all’altra posizione. Il fronte di chi invoca una supposta maggiore sovranità e democrazia, possibile solo sul terreno dello Stato-nazione, si allarga infatti sempre di più, e aumenta il numero di chi propone un’alleanza che vada oltre la destra e la sinistra, in nome di un comune interesse nazionale, contro il neoliberismo e il capitalismo finanziario dell’alta borghesia cosmopolita.
Il libro di Stefano G. Azzarà, Comunisti, fascisti e questione nazionale. Germania 1923: fronte rossobruno o guerra d’egemonia?[1], uscito di recente per i tipi Mimesis, giunge a fare chiarezza sui rapporti tra marxismo e questione nazionale in un momento in cui il dibattito su questi temi è particolarmente vivace. Azzarà affronta il problema da un punto di vista storico, confrontandosi con una situazione che presenta forti parallelismi con l’attualità e che, più di altre, può dunque fornire chiavi di lettura per un’analisi più consapevole della fase storica presente. Come esplicitato dal sottotitolo, il momento storico considerato è quello della Germania dei primi anni Venti. L’occupazione francese della Ruhr in rappresaglia ai ritardi nei pagamenti delle riparazioni di guerra da parte tedesca e la debole “resistenza passiva” del governo guidato da Cuno rendeva urgente la riflessione sulla reale indipendenza del paese. Nella prima parte del volume l’Autore esamina nel dettaglio la polemica del 1923 tra i comunisti e i gruppi neonazionalisti. Essa era seguita a un ricordo di Leo Schlageter, un militante nazionalista tedesco ucciso dai soldati francesi, che Karl Radek aveva fatto in un discorso pronunciato a una seduta dell’esecutivo dell’Internazionale Comunista.
- Details
- Hits: 2490
Liberalismo, Democrazia, Sovranità
Moreno Pasquinelli intervista Alessandro Somma
Alétheia si confronta con il noto professore di Diritto Comparato autore di “Sovranismi”
 Alessandro Somma è stimato professore ordinario di Diritto comparato all’Università di Ferrara. Per DeriveApprodi ha appena pubblicato il saggio Sovranismi. Stato, popolo e conflitto sociale. Si tratta di un testo ad alta densità teorica che, dopo aver ricostruito il dibattito filosofico e politico sul concetto di sovranità, giunge sino alla nascita degli Stati costituzionali di diritto, quindi all’oggi. Somma considera che la Costituzione della Repubblica italiana rappresenta uno dei momenti più alti del costituzionalismo moderno, poiché i suoi capisaldi sono la democrazia economica e l’eguaglianza sostanziale. Proprio per questo, essa è fatta oggetto di un’aggressiva decostruzione da parte delle forze neoliberiste. Va dunque difesa, non per un mero ritorno al già stato, ma poiché sulle sue basi è di nuovo possibile immaginare un’alternativa all’ordine sociale e politico esistente.
Alessandro Somma è stimato professore ordinario di Diritto comparato all’Università di Ferrara. Per DeriveApprodi ha appena pubblicato il saggio Sovranismi. Stato, popolo e conflitto sociale. Si tratta di un testo ad alta densità teorica che, dopo aver ricostruito il dibattito filosofico e politico sul concetto di sovranità, giunge sino alla nascita degli Stati costituzionali di diritto, quindi all’oggi. Somma considera che la Costituzione della Repubblica italiana rappresenta uno dei momenti più alti del costituzionalismo moderno, poiché i suoi capisaldi sono la democrazia economica e l’eguaglianza sostanziale. Proprio per questo, essa è fatta oggetto di un’aggressiva decostruzione da parte delle forze neoliberiste. Va dunque difesa, non per un mero ritorno al già stato, ma poiché sulle sue basi è di nuovo possibile immaginare un’alternativa all’ordine sociale e politico esistente.
Alétheia ha intervistato Somma, intanto per rendere esplicito ciò che sembra implicito in Sovranismi, poi per comprendere quale sia il suo giudizio sul delicato momento politico che attraversa il nostro Paese.
* * * *
La Costituzione del ’48 è in assoluto la protagonista del tuo libro. Sembra di capire che tu ritenga che contiene il punto geometrico di equilibrio tra democrazia e capitalismo, altrimenti destinati a confliggere. Davvero possono coabitare capitalismo e democrazia?
Penso che la Costituzione individui un punto di equilibrio ottimale tra capitalismo e democrazia, ma penso anche che si tratti di un equilibrio assolutamente instabile: destinato a essere messo in crisi e a produrre il superamento del capitalismo o quello della democrazia. Sul finire dei ’30 gloriosi si sono intrapresi passi significativi nella prima direzione, tanto che poi si è subito imposta la seconda, significativamente descritta in termini di ritorno alla normalità capitalistica.
Restiamo alla Costituzione. Tu ritieni che la Carta sia un risultato avanzato di quello che definisci “Stato (costituzionale) di diritto” dal momento che respinge l’idea liberista del “mercato autoregolato” e contiene invece impliciti i concetti di “democrazia economica” e di “democrazia sostanziale”. Cosa intendi per “democrazia economica” e “democrazia sostanziale”?
- Details
- Hits: 1776
Guinzaglio al Web
L’Europa e il copyright
di Giovanna Baer
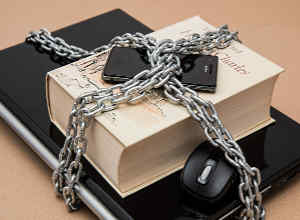 Il 12 settembre è stata approvata la “Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sul diritto d’autore nel mercato unico digitale” (1), una proposta di legge pressoché sconosciuta al grande pubblico, ma che ha visto spaccarsi in due il fronte politico e gli attori della digital economy. Il testo, che era stato respinto il 5 luglio scorso, è stato riproposto con una serie di emendamenti dal relatore Axel Voss (eurodeputato tedesco cristiano-democratico), ed è passato con 438 voti a favore, 226 contrari e 39 astensioni. Hanno votato a favore la maggioranza dei Popolari (Ppe) e dei Socialisti e Democratici (S&D), mentre gli eurodeputati della Lega e del M5s hanno votato contro, insieme alla maggioranza dei Verdi. Il gruppo dei liberali (Alde) si è spaccato, così come il gruppo delle destre (Enf). Ora l’iter legislativo prevede che vengano avviati i negoziati con il Consiglio e la Commissione Ue per arrivare alla definizione del testo finale e, in seguito, il voto del Parlamento europeo sulla versione definitiva.
Il 12 settembre è stata approvata la “Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sul diritto d’autore nel mercato unico digitale” (1), una proposta di legge pressoché sconosciuta al grande pubblico, ma che ha visto spaccarsi in due il fronte politico e gli attori della digital economy. Il testo, che era stato respinto il 5 luglio scorso, è stato riproposto con una serie di emendamenti dal relatore Axel Voss (eurodeputato tedesco cristiano-democratico), ed è passato con 438 voti a favore, 226 contrari e 39 astensioni. Hanno votato a favore la maggioranza dei Popolari (Ppe) e dei Socialisti e Democratici (S&D), mentre gli eurodeputati della Lega e del M5s hanno votato contro, insieme alla maggioranza dei Verdi. Il gruppo dei liberali (Alde) si è spaccato, così come il gruppo delle destre (Enf). Ora l’iter legislativo prevede che vengano avviati i negoziati con il Consiglio e la Commissione Ue per arrivare alla definizione del testo finale e, in seguito, il voto del Parlamento europeo sulla versione definitiva.
Il presidente dell’europarlamento ed ex giornalista Antonio Tajani (Forza Italia) l’ha definita una vittoria di tutti i cittadini che, a suo dire, difenderà “la cultura e la creatività europea e italiana, mettendo fine al far west digitale” (2). Anche il Pd ha aderito al fronte degli estimatori (insieme alla FNSI, Federazione Nazionale Stampa Italiana, e alla FIEG, Federazione Italiana Editori di Giornali) e Silvia Costa, deputata e membro della Commissione cultura al Parlamento europeo, l’ha messa addirittura sul mitico: “Ha vinto l’Europa della cultura e della creatività contro l’oligopolio dei giganti del web” (3). Di segno opposto l’opinione di Isabella Adinolfi, eurodeputata M5s, che ha definito l’approvazione della proposta “una pagina nera per la democrazia e la libertà dei cittadini.
- Details
- Hits: 4123
Euro: dopo vent’anni, riforma cercasi disperatamente
Intervista a Riccardo Bellofiore*
 Lo scorso primo gennaio sono trascorsi vent’anni dall’introduzione dell’euro come valuta: un anniversario che arriva in un anno cruciale per l’Unione europea, con le elezioni del prossimo maggio, e impone un bilancio complessivo di un processo di integrazione monetaria europea, delle sue contraddizioni e del suo futuro possibile. Punto di arrivo di un tortuoso processo di integrazione dei mercati nel Continente e, secondo i suoi fautori, primo passo di una sempre maggiore integrazione politica, la moneta unica dell’Europa dopo la crisi dei debiti sovrani si pone oggi come problema primario per la tenuta e legittimità dell’intero progetto europeo e degli stessi Stati membri. Le ferite ancora parte della crisi e l’erosione di una solidarietà europea sotto la scure dell’austerità e dei vincoli fiscali legano sempre di più il destino dell’euro a quello delle democrazie e dei diritti sociali, rendendo urgente e necessario interrogarsi sulle promesse tradite della moneta unica e su quelle irrealizzabili. Quali sono state le ragioni che hanno portato all’introduzione della moneta unica? Quali i suoi limiti e le prospettive di una riforma dell’eurozona? Ne abbiamo parlato con Riccardo Bellofiore, Professore di Economia Politica all’Università di Bergamo.
Lo scorso primo gennaio sono trascorsi vent’anni dall’introduzione dell’euro come valuta: un anniversario che arriva in un anno cruciale per l’Unione europea, con le elezioni del prossimo maggio, e impone un bilancio complessivo di un processo di integrazione monetaria europea, delle sue contraddizioni e del suo futuro possibile. Punto di arrivo di un tortuoso processo di integrazione dei mercati nel Continente e, secondo i suoi fautori, primo passo di una sempre maggiore integrazione politica, la moneta unica dell’Europa dopo la crisi dei debiti sovrani si pone oggi come problema primario per la tenuta e legittimità dell’intero progetto europeo e degli stessi Stati membri. Le ferite ancora parte della crisi e l’erosione di una solidarietà europea sotto la scure dell’austerità e dei vincoli fiscali legano sempre di più il destino dell’euro a quello delle democrazie e dei diritti sociali, rendendo urgente e necessario interrogarsi sulle promesse tradite della moneta unica e su quelle irrealizzabili. Quali sono state le ragioni che hanno portato all’introduzione della moneta unica? Quali i suoi limiti e le prospettive di una riforma dell’eurozona? Ne abbiamo parlato con Riccardo Bellofiore, Professore di Economia Politica all’Università di Bergamo.
* * * *
A vent’anni dall’adozione dell’euro come valuta, quale l’origine e le ragioni storiche dell’adozione dell’euro?
Innanzitutto credo che si debba capire che unificazione monetaria ed euro non sono essenzialmente la stessa cosa. Noi ormai siamo abituati a chiamare l’euro “moneta unica” in opposizione alle monete nazionali dei Paesi che poi hanno fatto parte dell’eurozona. In realtà questa è a mio avviso una falsa alternativa.
- Details
- Hits: 2615

L’eredità di Marx per un economista laico1
di Salvatore Biasco
 Premessa
Premessa
Marx è stato il mio imprinting giovanile e, più che Marx, la produzione di vari autori marxisti (e non marxisti, che comunque a lui si riferivano). Il bagaglio si era confusamente già definito, quando la mia formazione si è indirizzata verso l’economia, consolidandosi soprattutto a Cambridge (negli anni d’oro della Faculty of Economics) e, in Italia, nell’Istituto (si chiamavano così i Dipartimenti) diretto da Sylos Labini, quindi in un universo intellettualmente laico. Avere alle spalle quel piccolo bagaglio marxiano è stato importante poiché da subito ha contributo a farmi guardare l’economia da un punto di vista sociologico, nella consapevolezza che dietro le relazioni stilizzate vi è la struttura della società. Oggi - dopo tanti anni (nei quali c’è in mezzo il confronto continuo sul tema negli ’70 con Salvati, Vianello, Ginzburg, Lippi e tanti altri in quella fucina di idee che era allora l’Università di Modena) e dopo tutte le maturazioni (accettatemi il termine) che ha avuto la mia riflessione intellettuale - cosa rimane di Marx? Qual’è il consuntivo di insegnamenti che il confronto con la realtà e con la disciplina è andato distillando dentro di me e che mi sentirei di proporre come guida a un giovane che si avvicini oggi a lui? Quali considerazioni ci stimola anche nelle parti della sua produzione che ci appaiono più lontane dall’evoluzione del mondo corrente?
Ovviamente, in ciò che segue, il Marx che presento è come io l’ho sistemato nella mia mente ed è un Marx riferito al bagaglio analitico che ci ha trasmesso. Il Marx che si proietta in un finalismo storico non l’ho mai considerato rilevante e, sotto sotto, è anche una forzatura interpretativa. Il filosofo, lo storico, l’economista, il sociologo, l’umanista che in ciascun campo dà il “là a un modo originale di vedere le cose è, invece, di grande rilievo.
- Details
- Hits: 1346
Un abito giallo che fa comunità
di "Temps critiques"
 Il movimento dei Gilet Gialli sembra confermare una rottura del filo storico della lotta di classe. La cosa aveva già avuto inizio a livello mondiale durante le Primavere Arabe, poi con il movimento Occupy, e con i movimenti delle Piazze che erano tutti alla testa di quelle mobilitazioni che rivendicavano o domandavano libertà, uguaglianza, e condizioni di vita in generale; il posto di lavoro, piuttosto che le condizioni lavorative. È stato anche per questo motivo che questi movimenti si rivolgevano assai più allo Stato che ai Padroni, nella misura in cui il processo di globalizzazione/totalizzazione del capitale porta gli Stati a gestire la riproduzione dei rapporti sociali a livello territoriale, pur restando dipendente dalle esigenze della globalizzazione.
Il movimento dei Gilet Gialli sembra confermare una rottura del filo storico della lotta di classe. La cosa aveva già avuto inizio a livello mondiale durante le Primavere Arabe, poi con il movimento Occupy, e con i movimenti delle Piazze che erano tutti alla testa di quelle mobilitazioni che rivendicavano o domandavano libertà, uguaglianza, e condizioni di vita in generale; il posto di lavoro, piuttosto che le condizioni lavorative. È stato anche per questo motivo che questi movimenti si rivolgevano assai più allo Stato che ai Padroni, nella misura in cui il processo di globalizzazione/totalizzazione del capitale porta gli Stati a gestire la riproduzione dei rapporti sociali a livello territoriale, pur restando dipendente dalle esigenze della globalizzazione.
In Francia, la forza di resilienza del movimento operaio tradizionale aveva ancora mantenuto l'idea della lotta di classe del lavoro contro il capitale. Nella primavera del 2016, la lotta contro la riforma del diritto al lavoro aveva proseguito sulla strada della «classe operaia innanzitutto» senza ottenere dei risultati tangibili. Qualche anno prima, le mobilitazioni generate a partire dal movimento delle Piazze non avevano consentito un'effettiva ripresa, poiché avevano privilegiato il formalismo delle assemblee a scapito del contenuto della lotta. Una lotta che sembrava aver trovato un legame più promettente in seno al movimento spagnolo, che vedeva il movimento delle Piazze virare verso la solidarietà di quartiere, legandosi ai problemi dell'alloggio.
In tutte queste lotte, comprese quelle contro la loi-travail, la questione dello sciopero generale, o quella del blocco della produzione a partire dalle fabbriche, non è stata posta, così come non è stata posta in seno al movimento dei Gilet Gialli.
- Details
- Hits: 1916
A partire dal sottotitolo del Capitale: Critica e metodo della critica dell’economia politica
di Tommaso Redolfi Riva*
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Abstract: The aim of the paper is to explain the concept of «critique of political economy» (CPE) in Marx’s mature work. Starting from the different meanings CPE assumes, I will try to explain the peculiarities of such a critical project. In particular, I will focus the attention on CPE as a critique of capital as objective-subjective totality: on the one side, as a system of social production whose aim is the valorisation of capital, based on the appropriation of unpaid labour and generating a system of socialisation of production increasingly becoming autonomous from the social agents which establish it; on the other side, as the place of constitution of the categories of political economy, whose defect cannot only be brought back to the methodological lack of the economists because such categories, as a part of the capitalistic reality itself, are products of capitalistic social relationships. What emerges from this perspective is that CPE, as the presentation of the system of capitalistic relationships, is the critique of a specific science put forth by means of the critique of its own specific object
 «Il metodo della dialettica,
«Il metodo della dialettica,
che cerca di andare al di là della prospettiva specialistica
e circoscritta della logica e dell’epistemologia,
consisterebbe nel non accontentarsi della semplice individuazione
del punto che richiede di essere criticato e poi affermare:
‘Guarda, qui c’è un errore nel ragionamento, sei caduto in contraddizione –
quindi tutta la cosa non vale nulla’, bensì […]
nell’indicare perché, nella costellazione di questo pensiero,
certi errori e certe contraddizioni sono inevitabili,
che cosa li ha generati nel movimento di tale pensiero e
in che senso quindi essi si mostrano significativi,
nella loro falsità e contraddittorietà, nella totalità del pensiero».
(Adorno 2010, 222-3)
1. Introduzione
Le categorie dell’economia politica rappresentano per Marx il luogo di accesso privilegiato alla realtà del modo di produzione capitalistico, non soltanto in quanto momenti di una teoria che rappresenta «il tentativo di penetrare nell’intima fisiologia della società borghese», ma anche in quanto esse sono una prima «nomenclatura» dei fenomeni «economici» che sono così riprodotti nel «processo di pensiero» (Marx 1993b, 168-169). Se è vero che l’oggetto della teoria di Marx è il modo di produzione capitalistico, l’accesso a tale oggetto passa necessariamente attraverso la mediazione concettuale (cfr. Schmidt 2017 e Fineschi 2006, in particolare 131-136).
- Details
- Hits: 2018
Siria: élite mondialista e pacifisti sinistri contro Trump. Vaticano-Quirinale: Benedictio urbi et orbi atque PD
di Fulvio Grimaldi
(E’ lungo, forse prolisso, ma tratta due temi grossi, si può digerire in due puntate e, giuro, per un po’ non mi farò vedere. Per combinare il testo con le immagini andate su www.fulviogrimaldicontroblog.info. Almeno da lì nessuno può rimuovere)
 Palloncino bucato
Palloncino bucato
Una cosa si è confermata chiara e ha bucato il pallone gonfiato delle fake news dei grandi media e la loro forsennata passione per la globalizzazione di guerre, neoliberismo, totalitarismo. Una cosa ha definitivamente sancito la scomparsa, da noi, ma anche da molte altre parti, di quel settore della società politica che si definiva di sinistra e coltivava il paradosso di chiamare destra l’altro settore. Per la sedicente sinistra vale ormai al massimo il corrispettivo linguistico al maschile.
Questa cosa ha l’aspetto di Giano Bifronte: da un lato fulmina con occhiate di sdegno e riprovazione il trucidone della Casa Bianca che, sfidando una tradizione di guerre d’aggressione che risale alla fondazione del suo paese e ne costituisce l’essenza ontologica e, ahinoi, anche escatologica, annuncia il ritiro di truppe da Siria e Afghanistan (vedremo poi i perché e percome); dall’altro inneggia con passione smodata ai Supremi di casa nostra che, in occasione delle festività, ci hanno fatto volare sul capo aerostati gonfi di pace. Nella fattispecie aria calda.
Siamo il paese dei fessi che fanno i furbi, che tuffano il diavolo nell’acqua santa e se la cavano scegliendo la sudditanza a discapito della cittadinanza. Arlecchino servitore di due padroni. Don Abbondio, se di fronte c’è don Rodrigo, don Rodrigo, se si ha a che fare con don Abbondio. Dunque, don Abbondio prima con i tedeschi, poi con gli americani. Con tutti quelli che ci menano. E dunque con l’UE. Don Rodrigo con quelli che possiamo menare. Di solito noi stessi. E da questa caratteristica nazionale che nasce il prodigio di un paese, escluso il 32,7 % degli elettori che restano in stato d’attesa, che si diverte come un bambino sull’altalena nel parco giochi costruitogli dai potenti.
- Details
- Hits: 1865
Jeff Bezos mette le mani nella tua posta
di Marta Fana e Simone Fana
Amazon si rafforza nel nostro paese grazie all'accordo con Poste Italiane: un'intesa che non serve a lavoratori e consumatori. E che consolida due monopoli privati, uno globale l'altro nazionale
 Il servizio postale nazionale nasce insieme allo stato unitario, nel 1862, quando fu istituito il monopolio delle Regie poste seguito vent’anni più tardi, nel 1889, dal Ministero per le poste e i telegrafi. La storia è quella dell’espansione del servizio pubblico e universale di accesso alla corrispondenza, ma anche al diritto all’inviolabilità delle lettere, e della tariffa unica, con l’istituzione del francobollo. Obiettivi diametralmente opposti alle regole che vigono oggi nel sistema privatizzato in cui la velocità delle spedizioni e la garanzia del servizio universale sono subordinati al potere d’acquisto: al censo, si sarebbe detto in quel lontano inizio del ventesimo secolo. Dall’interesse di garantire il servizio di corrispondenza a tutti i cittadini mediante il controllo della rete e dei prezzi si è giunti a porre l’interesse degli azionisti e del capitale privato come prioritari; fino a rendersi servizio non dei cittadini ma del capitale stesso, come mette in luce l’ingresso di Amazon nei servizi postali e l’accordo siglato con Poste Italiane.
Il servizio postale nazionale nasce insieme allo stato unitario, nel 1862, quando fu istituito il monopolio delle Regie poste seguito vent’anni più tardi, nel 1889, dal Ministero per le poste e i telegrafi. La storia è quella dell’espansione del servizio pubblico e universale di accesso alla corrispondenza, ma anche al diritto all’inviolabilità delle lettere, e della tariffa unica, con l’istituzione del francobollo. Obiettivi diametralmente opposti alle regole che vigono oggi nel sistema privatizzato in cui la velocità delle spedizioni e la garanzia del servizio universale sono subordinati al potere d’acquisto: al censo, si sarebbe detto in quel lontano inizio del ventesimo secolo. Dall’interesse di garantire il servizio di corrispondenza a tutti i cittadini mediante il controllo della rete e dei prezzi si è giunti a porre l’interesse degli azionisti e del capitale privato come prioritari; fino a rendersi servizio non dei cittadini ma del capitale stesso, come mette in luce l’ingresso di Amazon nei servizi postali e l’accordo siglato con Poste Italiane.
Tra la fase del monopolio pubblico e la totale liberalizzazione, Poste Italiane ha vissuto da protagonista l’intera storia del capitalismo misto italiano, cadendo sotto i colpi del mantra della redditività e della libera concorrenza. A partire da fine anni Novanta le esigenze sovranazionali di completare la creazione del mercato unico investono il settore postale con quello dei trasporti e della logistica più in generale. In principio si provava a armonizzare il servizio postale e soprattutto a imporre i limiti ai diritti riservati ai fornitori del servizio universale. Come recita la pagina dedicata dell’Agcom Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, «il processo di liberalizzazione dei mercati dei servizi postali avviato dall’Unione europea con la direttiva 97/67/CE (da ultimo modificata con la direttiva 2008/6/CE) implica, per gli Stati membri, l’abolizione di qualsiasi forma di monopolio, di riserva e di diritti speciali nel settore». Il recepimento della direttiva del 2008, avvenne in Italia con il decreto legislativo n° 58 del 2011 che liberalizza il servizio postale e affida a Poste Italiane la copertura del servizio universale per un periodo di quindici anni, pro tempore e revocabile.
- Details
- Hits: 3226
Per una sovranità democratica e popolare. Cioè costituzionale
L’ultimo libro di Alessandro Somma: “Sovranismi”
di Vladimiro Giacché
Un'ottima recensione di Vladimiro Giacché all'ultimo libro di Alessandro Somma
 Poche parole hanno conosciuto un improvviso boom negli ultimi anni come i termini “sovranismo” e “sovranisti”. Di queste parole, ormai onnipresenti nel nostro dibattito politico, chi compulsasse i quotidiani anche solo di due-tre anni non troverebbe quasi traccia. E francamente di un’altra parola-contenitore di incerto significato, oltretutto in genere adoperata come etichetta denigratoria e dispregiativa, proprio non si sentiva la mancanza.
Poche parole hanno conosciuto un improvviso boom negli ultimi anni come i termini “sovranismo” e “sovranisti”. Di queste parole, ormai onnipresenti nel nostro dibattito politico, chi compulsasse i quotidiani anche solo di due-tre anni non troverebbe quasi traccia. E francamente di un’altra parola-contenitore di incerto significato, oltretutto in genere adoperata come etichetta denigratoria e dispregiativa, proprio non si sentiva la mancanza.
Un motivo in più per apprezzare l’ultimo libro di Alessandro Somma, “Sovranismi. Stato, popolo e conflitto sociale” (Roma, Derive/Approdi, 2018), dedicato precisamente al compito di risalire ai diversi significati che oggi assume il concetto di “sovranità”, al quale quello di “sovranismo” confusamente allude, e i limiti ai quali è sottoposto nel contesto dell’Unione Europea. Al termine di questa disamina, l’autore descrive nell’ultimo capitolo i compiti e gli obiettivi di un “sovranismo democratico” che voglia porsi all’altezza delle sfide del presente.
Prima di procedere a un esame sommario dei contenuti di questo testo, la cui facilità di lettura - un pregio ben noto ai lettori dei libri di Alessandro Somma - non deve trarre in inganno (i temi trattati infatti sono molti, importanti e molto ben approfonditi), devo premettere che mi occuperò qui della linea argomentativa che mi pare centrale, mentre per motivi di spazio dovrò lasciare ai lettori del libro il piacere di scoprire numerosi altri temi importanti.
Il testo parte da un assunto forte sulla fase che stiamo vivendo: “L’epoca attuale è indubbiamente caratterizzata dal rigetto del mercato autoregolato e del processo di denazionalizzazione che ha accompagnato la sua affermazione”. Un rigetto che non si verifica oggi per la prima volta: il rifiuto del mercato autoregolato quale fondamento della società si ebbe tra la prima e la seconda guerra mondiale, e diede luogo a esperienze sociali e politiche radicalmente diverse tra loro quali l’Unione Sovietica e i fascismi.
- Details
- Hits: 1726
Come rinasce un movimento di classe sotto i nostri occhi
di Dante Barontini

Molti si son fatti persuadere dal vade retro pronunciato dai disinformation maker di Repubblica, Corriere, e financo il manifesto, ormai maggioritariamente rivolto contro tutto ciò che odora di conflitto sociale, “disturbo della quiete pubblica”, esangue retorica umanitaria ben attenta a non intralciare il cammino del capitale globalizzato (che non lo è più tanto, ma è inutile dirglielo).
All’origine di questa operazione stanno le “fonti francesi”, quasi sempre ridotte all’ex entourage di François Hollande, da cui sono usciti sia l’orrido Emmanuel Macron, sia il neo-falangista Manuel Valls (ex primo ministro “socialista”, che si è ricordato delle sue lontane origini catalane solo per candidarsi a sindaco di Barcellona con l’appoggio della destra anti-indipendentista e anti-repubblicana; non va dimenticato che la Spagna conserva sia la monarchia che l’impianto della Costituzione franchista).
Ci si è insomma a tal punto dimenticati di come nascono i movimenti da non riconoscerli neppure quando nascono sotto i nostri occhi. La causa vera – quella che infetta la “cultura politica” e dunque le griglie di lettura del reale – è nella storia dei partiti di massa del secondo Novecento. Un lungo periodo durante il quale le contraddizioni tra le classi, in Europa, venivano gestite con la mediazione tra interessi sociali diversi e le politiche keynesiane. Il bastone del comando restava in mano al capitale, ci mancherebbe, ma gli interessi operai o in senso lato proletari e “popolari” venivano organizzati, incanalati, rappresentati e riconosciuti come legittimi fino a diventare proposte di legge, rivendicazioni di riforme (con qualche successo, dopo aspri conflitti, negli anni ‘70).
- Details
- Hits: 1533
Destra e Sinistra
di Alessandro Volpi
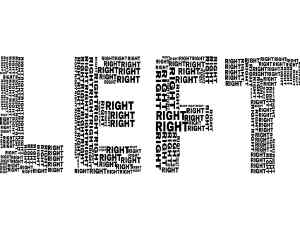 Marcello Gisondi ha dato avvio tempo fa, su questa rivista, alla riflessione sulle categorie di destra e sinistra, con un articolo dall’eloquente titolo: “A sinistra di cosa?” in cui si interrogava sulla validità di questa dicotomia nella lettura dell’attuale “momento populista”. Condivido l’impostazione del problema e nella sostanza anche la risposta, tuttavia credo ci siano alcuni punti che vale la pena approfondire; cercherò di portare un piccolo contributo alla discussione.
Marcello Gisondi ha dato avvio tempo fa, su questa rivista, alla riflessione sulle categorie di destra e sinistra, con un articolo dall’eloquente titolo: “A sinistra di cosa?” in cui si interrogava sulla validità di questa dicotomia nella lettura dell’attuale “momento populista”. Condivido l’impostazione del problema e nella sostanza anche la risposta, tuttavia credo ci siano alcuni punti che vale la pena approfondire; cercherò di portare un piccolo contributo alla discussione.
Già nel 1994, iniziando a scrivere l’ormai classico libro sul tema (Destra e sinistra, Roma: Donzelli, 1994), Norberto Bobbio notava che «non si è mai scritto tanto come oggi contro la tradizionale distinzione fra destra e sinistra […].» [BOBBIO, p. VII] Oggi è ormai senso comune l’idea che le categorie siano saltate, e in Italia questo è accentuato dal fatto che uno dei partiti di governo, il Movimento 5 Stelle, non si definisce né di destra né di sinistra, e rende oggettivamente difficile il lavoro di giornalisti e politologi che cerchino di farlo. Che la nostra percezione si accordi così con quella che aveva Bobbio nel ’94 risponde senza dubbio alla mancata riattivazione politica di queste categoria da parte di chicchessia; più precisamente, oggi, esattamente come allora, viviamo un momento di profonda crisi della fiducia nelle istituzioni e nei soggetti della rappresentanza politica. È stato infatti nel ’94, a due anni dallo scoppio di Mani Pulite, che Berlusconi chiuse la prima repubblica e diede i natali alla seconda, ed è con le elezioni del 4 marzo 2018 che il Movimento 5 Stelle ha aperto una nuova fase politica, appunto una terza repubblica.
Page 291 of 611