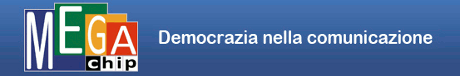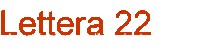Fai una donazione
Questo sito è autofinanziato. L'aumento dei costi ci costringe a chiedere un piccolo aiuto ai lettori. CHI NON HA O NON VUOLE USARE UNA CARTA DI CREDITO può comunque cliccare su "donate" e nella pagina successiva è presente (in alto) l'IBAN per un bonifico diretto________________________________
- Details
- Hits: 2779
Politica economica europea
Le riforme necessarie contro crisi finanziaria e recessione
di Ferdinando Targetti
Introduzione
In presenza di libertà di movimenti di capitali i problemi di stabilità finanziaria e di equilibrio macroeconomico mondiale, non possono essere risolti a livello nazionale. A fronte di mercati internazionalizzati il semplice coordinamento è insufficiente, bisogna passare ad un livello di governo sovranazionale.
Questo è oltremodo difficile da conseguire a livello mondo e attribuire ad un organismo mondiale un ruolo di regolatore con poteri amministrativi è irrealistico, così come è irrealistico pensare ad un Tesoro mondiale, anche se c’è molto da fare sul piano di riforma del Fmi e di rafforzamento delle sue capacità di sorveglianza sulla stabilità dei mercati finanziari e sul superamento degli squilibri macroeconomici globali. Tuttavia un passo avanti verso un più corretto processo di governance dell’economia globale può essere realizzato da noi europei.
Finora la politica economica dell’Europa si era limitata alla indipendenza della Bce, al Patto di stabilità e all’uso del bilancio pubblico prevalentemente per la politica agricola comune. Tutto questo è largamente insufficiente sia per finalità di crescita, sia per finalità anticrisi. La risposta europea alla globalizzazione dei mercati e alla crisi finanziaria deve articolarsi in una serie di riforme economiche che si affiancano a quelle politiche e che richiedono, entrambe, la disponibilità a consentire da parte degli Stati nazionali deleghe di sovranità indispensabili per tradurre in pratica obiettivi che appaiono condivisi.
- Details
- Hits: 2378

Prime note per la riflessione dell'Onda
di Franco Piperno
Un’altra università non vuol dire l’università del futuro
1. L’Onda sta mutando la sua fase
Con la massiccia concentrazione del 14 novembre su Roma, si compie un ciclo del movimento, il primo. Tutto era cominciato con un decreto romano, illiberale e statalista che, trattando la formazione come un costo piuttosto che un investimento, tagliava drasticamente la spesa pubblica per scuola e università. Il 14 novembre è così la risonanza sociale provocata da quel decreto.
Ma tanto la pluralità quanto i numeri coinvolti testimoniano, con tutta evidenza, che l’Onda ha già prodotto una eccedenza che è fuori misura rispetto al gesto che l’ha provocata.
In altri termini l’orizzonte parasindacale incentrato sulla questione dei tagli risulta ormai limitato, anzi asfittico; ed emergono forme di vita attiva che hanno compiuto l’esodo dalla temporalità moderna dove il futuro è vissuto nel modo dell’attesa (nuove riforme, nuovi governi, nuove scienze, nuove ricerche, nuovo mondo ecc.) e s’impegnano «a strappare la felicità al futuro» praticando qui e ora il terreno della critica alla divisione disciplinare del sapere: la prassi dell’autoformazione ovvero un’altra università, in grado di richiamarsi all’origine, all’autonomia e unità del sapere.
- Details
- Hits: 2480

La 133 viene ritirata? La vostra condizione non cambia
E’ questa condizione che dovete cambiare
di Sergio Bologna
Nello spirito del ’68 – senza nostalgie nè tormentoni (dopo un incontro all’Università di Siena, organizzato dal Centro ‘Franco Fortini’ nella Facoltà di Lettere occupata, il 6 novembre 2008)
State vivendo un’esperienza eccezionale, l’esperienza di una crisi economica che nemmeno i vostri genitori e forse nemmeno i vostri nonni hanno mai conosciuto. Un’esperienza dura, drammatica, dovete cercare di approfittarne, di cavarne insegnamenti che vi consentano di non restarvi schiacciati, travolti. Non avete chi ve ne può parlare con cognizione diretta, i vostri docenti stessi la crisi precedente, quella del 1929, l’hanno studiata sui libri, come si studia la storia della Rivoluzione Francese o della Prima Guerra Mondiale.
Ho letto che l’Ufficio di statistica del lavoro degli Stati Uniti prevede che nel 2009 un quarto dei lavoratori americani perderà il posto.
Qui da noi tira ancora un’aria da “tutto va ben, madama la marchesa”, si parla di recessione, sì, ma con un orizzonte temporale limitato, nel 2010 dovrebbe già andar meglio e la ripresa del prossimo ciclo iniziare. Spero che sia così, ma mi fido poco delle loro prognosi. (dopo un incontro all’Università di Siena, organizzato dal Centro ‘Franco Fortini’ nella Facoltà di Lettere occupata, il 6 novembre 2008).
- Details
- Hits: 2689
Il liberismo è una fantasia
di Riccardo Bellofiore
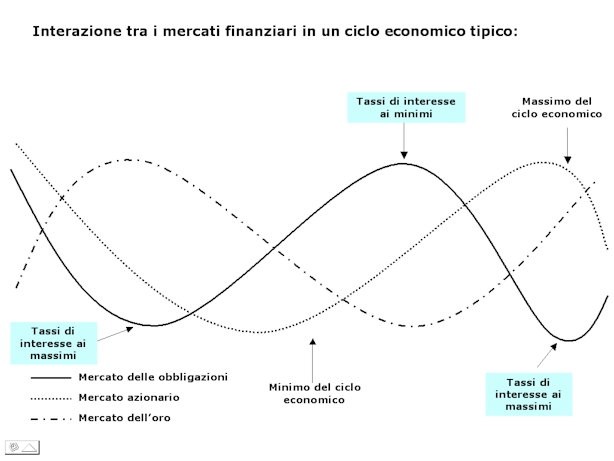 Dopo il fallimento di tutte le strategie messe in campo nell'ultimo decennio, oggi la sinistra, in specie in quella "comunista", ha bisogno di andare a fondo nell'analisi. Cosa non scontata né semplice, perché significa rimettere in discussione letture del capitalismo contemporaneo e dei rapporti di classe politicamente inefficaci, oltre che rozze e ripetitive in molti casi. E rimettersi in discussione fa paura, come evidenzia lo stato desolante della discussione politica dentro e fuori Rifondazione Comunista dopo le elezioni, in cui ci si divide sull'inessenziale e non si affrontano i nodi di fondo.
Dopo il fallimento di tutte le strategie messe in campo nell'ultimo decennio, oggi la sinistra, in specie in quella "comunista", ha bisogno di andare a fondo nell'analisi. Cosa non scontata né semplice, perché significa rimettere in discussione letture del capitalismo contemporaneo e dei rapporti di classe politicamente inefficaci, oltre che rozze e ripetitive in molti casi. E rimettersi in discussione fa paura, come evidenzia lo stato desolante della discussione politica dentro e fuori Rifondazione Comunista dopo le elezioni, in cui ci si divide sull'inessenziale e non si affrontano i nodi di fondo.
In un recente articolo (Liberazione, 29 ottobre 2008) Luigi Cavallaro utilizzando la visione del capitalismo di Hyman P. Minsky - un autore, scrive, "il cui nome si ode nuovamente in questi giorni" - ci mette in guardia da chi riduce la crisi recente a conseguenza di una euforia irrazionale e non della "furia liberalizzatrice" degli ultimi due decenni. Le citazioni di Minsky ormai sono una valanga. Dal marzo 2007 si è tornato a parlare dell'approssimarsi di un "momento Minsky", e poi del rischio di un "collasso Minsky" del capitalismo. Questo sorprendente interesse alla riflessione dell'economista statunitense è venuta da subito da opinionisti tanto neoliberisti quanto social-liberisti, e non solo da circoli eterodossi.
- Details
- Hits: 3097

La moneta di conto
Intervista a Massimo Amato e Luca Fantacci*
L’incredibile vicenda dei mutui subprime, alla cui origine c’è la rescissione di ogni rapporto tra debitore e creditore. Il paradosso di una finanza che non riesce a pensare il suo oggetto, la moneta. La proposta originale e “pacifista” di Keynes, rimasta inascoltata a Bretton Woods
La crisi che stiamo vivendo appare contemporaneamente molto profonda nei suoi effetti e poco chiara nelle sue origini, partiamo da qui?
Luca Fantacci. Questa crisi, che è nata in un settore circoscritto di un paese specifico e si è poi estesa anche ad altri settori e ad altri paesi, viene definita come “crisi di liquidità” o “crisi dei subprime”, dove il termine subprime si riferisce a strumenti finanziari nuovi, che miravano ad estendere l’accesso al credito a strati sempre più estesi, in particolare per consentire l’acquisto della prima casa. L’aspetto problematico della faccenda, quello che è poi esploso con la crisi, è stato il modo in cui questo credito è stato erogato. Possiamo, infatti, convenire che permettere di acquistare una casa a chi non l’ha e non se la può permettere sia un obiettivo sociale condivisibile, ma il problema è che questo accesso è stato consentito a credito anche a persone che non avevano nessuna possibilità di generare un reddito tale da ripagare quel credito. Le banche, infatti, erogavano un credito nella prospettiva che potesse essere remunerato e riscattato non a partire dal reddito del debitore, e quindi dal suo lavoro, ma dall’incremento del valore di mercato della casa.
- Details
- Hits: 3661

La psicologia degli uomini d'affari
Intervista a Giorgio Lunghini*
Una crisi, quella finanziaria, che parte da lontano, per poi arrivare alla new economy e alla fine, forse, ai mutui subprime. Una globalizzazione che doveva portare benefici per tutti e invece ha creato crescenti disuguaglianze. Una lezione, quella di Keynes, che è stata del tutto dimenticata.
Come si è arrivati a questa crisi?
E’ una storia abbastanza lunga. Molti pensano che si tratti di una bolla finanziaria esplosa con una crisi sui mercati azionari. In realtà credo che questa sia l’ultima, per il momento, fase di una crisi che aveva colpito gli Stati Uniti da molto tempo e che era stata rinviata grazie a provvedimenti sostanzialmente di Greenspan, allora governatore della Federal Reserve che era riuscito a spostare via via la crisi da un mercato all’altro.
Il contesto nel quale queste crisi nascono e hanno questo epilogo è naturalmente quello della globalizzazione. La globalizzazione era stata vista a lungo come un fenomeno positivo che avrebbe portato prevalentemente benefici e questi benefici avrebbero riguardato un po’ tutto il mondo. Così non è.
La cosa importante da mettere in luce è che la globalizzazione è stata a sua volta un tentativo di reagire e di contrastare crisi precedenti, come già era successo con la globalizzazione degli anni ’15-20, a cui seguì la crisi del ’29 e dei primi anni Trenta. La crisi alla quale questa globalizzazione ha cercato di reagire è la crisi del modello fordista, che a sua volta era stato una reazione -prima americana poi europea- alla crisi degli anni Trenta.
- Details
- Hits: 2810

L'operazione è riuscita, il paziente è morto
Ruggero Paladini
L'osservazione delle altre crisi mostra che non si riassorbono da sole, è indispensabile uno stimolo pubblico per l'economia, tornando per esempio alle indicazioni del piano Delors. Se l'Europa insisterà a perseguire il pareggio di bilancio la recessione si aggraverà
Il 14 ottobre i giornali portavano due notizie: il premio Nobel a Paul Krugman e la dichiarazione di Berlusconi: “Bush passerà alla Storia”. Curioso accostamento, perché mentre per il nostro (purtroppo!) premier la Storia dovrebbe considerarlo un grande presidente, per l’economista la valutazione è esattamente opposta; la scelta tra Krugman e Berlusconi in effetti non è difficile. Il Nobel è stato assegnato a Krugman per i suoi lavori sul commercio internazionale, ma l’economista è da anni un editorialista del New York Times, da dove spara ad alzo zero sull’amministrazione Bush, da posizioni tipicamente keynesiane. E’ possibile che la stessa attribuzione del Nobel sia stata favorita dallo scoppio della crisi finanziaria.
Il nome di Keynes è tornato sulle pagine dei giornali, così come il paragone tra il “ventinove” e la crisi attuale. Lo scoppio di una bolla è ovviamente un elemento in comune alle due crisi, ma la lezione principale che la grande depressione ci ha dato è che, una volta esauritasi la bolla, il mercato non è in grado di risollevarsi da solo. Anche dopo gli interventi europei volti a rianimare il mercato del credito interbancario, siamo ben lontani dal ripristino di condizioni normali, anche se i tassi euribor hanno incominciato a flettere; del resto Stefan Ingves, attuale governatore della banca centrale svedese, che organizzò il salvataggio delle banche degli anni novanta, ha affermato che ci sono voluti tre anni per tornare alla normalità (e quindici anni perché il Tesoro svedese recuperasse i tre punti di Pil impegnati nel salvataggio delle banche).
- Details
- Hits: 2352
Obama e il disincanto. Un profilo antropologico
di Mcsilvan
Agli inizi del secolo scorso, la celebre prognosi di Weber sulla demagicizzazione del mondo definiva la comprensione di un processo secolare di crescita del disincanto nelle società occidentali quanto delle serie incomprensioni del fenomeno. Weber fissava, con delle categorie legate alla comprensione dei lunghi processi storici, il processo dello sgretolamento della presa del potere del magico e del sacro di tipo religioso sulla significazione dei fenomeni, sull’interazione sociale e sulla concezione del futuro. L’analisi weberiana sul quel processo di secolarizzazione, che riguardava non solo lo stato ma le radici stesse della società, è rimasta in questo senso un classico ineludibile. Ma, proprio a partire dall’analisi weberiana si sono registrate significative incomprensioni dei fenomeni politici non solo del ‘900 ma anche dell’epoca che stiamo attraversando. Infatti la crisi, definita irreparabile, della trascendenza nelle società contemporanee non solo ha di fatto semplicemente spostato i confini del trascendentale (dall’aldilà religioso all’aldiquà storico) ma ha anche ridefinito i poteri del sacro e del magico ricollocati entro questo nuovo spazio trascendentale ristrutturando i riti attraverso i quali questi poteri si riproducono. La capacità di attrazione del sacro e del magico, che ridefiniscono i tratti di ciò che è straordinario in una società oggi a prescindere dall’esistenza del divino, non rinvia quindi la fonte del proprio potere all’aldilà ma la colloca come un’ombra appena sopra un aldiquà che nel ‘900 fino ai nostri giorni è stato spesso marcato dalla politica che ha prodotto così una nuova dimensione trascendentale.
- Details
- Hits: 2797

Stato e mercato, un rapporto da ripensare
Felice Roberto Pizzuti
Evitare anche fughe oniriche in altri mondi indefiniti, ma anche i complessi che hanno portato una parte della sinistra ad essere più “realista del re” in tema di liberismo. Nessuno sa ancora come si evolverà la crisi, ma questi problemi devono essere al centro del dibattito
Per le dimensioni qualitative e quantitative che la crisi finanziaria ed economica in corso ha già assunto finora (non sappiamo come andrà a finire) possiamo dire che questa è la terza grande crisi degli ultimi ottant’anni, dopo quella del ’29 e quella degli anni ’70 normalmente associata agli shock petroliferi. Non sarà la fine del capitalismo (anche perché non si vede da cosa e ad opera di chi oggi sarebbe sostituito), ma sicuramente sta crollando la forma che era andato assumendo negli ultimi tre-quattro decenni.
Così come si sta manifestando, la crisi attuale ha origine nella vorticosa moltiplicazione delle attività finanziarie avvenuta negli ultimi decenni, nel loro collegamento sempre più flebile con la base patrimoniale su cui si regge la “leva” di creazione delle attività creditizie che è fortemente cresciuta, sulla riduzione delle garanzie richieste per la concessione dei crediti e sul progressivo allentamento delle regolamentazioni e della vigilanza delle imprese operanti nel settore. Si può pensare ad una piramide rovesciata in continua espansione, poggiata su una base relativamente sempre più ristretta e con strutture interne sempre meno adeguate ed affidabili.
- Details
- Hits: 3892
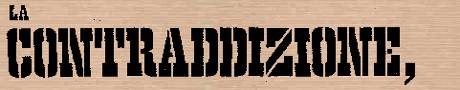
Scene da un patrimonio… che non c’è più: banche e non solo.
di Vladimiro Giacchè
“Quando la musica si fermerà le cose diventeranno complicate. Ma fintantoché la musica dura, devi restare in piedi e danzare. Stiamo ancora danzando”
(Chuck Prince, amministratore delegato di Citigroup, 10 luglio 2007 [Chuck Prince è stato licenziato nel novembre 2007])
“In questi anni eravamo andati troppo oltre. L’ingordigia dei banchieri, soprattutto americani, ha fatto sì che le banche siano state distruttrici di ricchezza” (Luca Cordero di Montezemolo).
Continuiamo a leggere cose del genere. Le spiegazioni psicologico-moralistiche hanno avuto e hanno tuttora largo corso in questa crisi: ancora il 12 novembre scorso sul Financial Times essa era addebitata nientemeno che alla “fragilità umana” (sic!). Una settimana dopo, un articolo pubblicato sullo stesso giornale giustamente attaccava la parzialità di spiegazioni basate unicamente su “regolatori lassisti, agenzie di rating disattente, e istituzioni finanziarie avide”.1 Lassismo, disattenzione, avidità: sono tutte motivazioni psicologiche. Chi può seriamente pensare che un cataclisma che ha già fatto perdere alle sole banche 1.000 miliardi di dollari abbia questa origine? È l’entità stessa della crisi, e la sua drammatica accelerazione, a confutare i tentativi di minimizzarne la portata e di spiegarla facendo ricorso a fattori psicologici o morali.
Ovviamente, l’utilizzo di spiegazioni psicologiche della genesi della crisi è del tutto coerente con l’economia neoclassica, tuttora egemonica. Così come lo è l’impostazione secondo cui gli attuali sviluppi della crisi sarebbero dovuti ad una “perdita massiccia di fiducia da parte degli investitori e dei consumatori”, come ha ripetuto ancora di recente il commissario europeo Günther Verheugen. Sono tutte sciocchezze. Le vittime più illustri di questa impostazione riduttiva, che vede soltanto errori e imprudenze individuali, sono stati il governatore della Federal Reserve Bernanke e il ministro del Tesoro Usa Paulson: di fatto il loro approccio di intervento “caso per caso”, durato sino al fallimento di Lehman Brothers, nasceva proprio dall’ostinato aggrapparsi all’idea di una crisi nata da imprudenze individuali commesse da alcune banche e dai loro manager e dal rifiuto di riconoscere che i problemi erano invece strutturali.2
- Details
- Hits: 2914
Il capitalismo sotto la tenda a ossigeno
di Jean Paul Fitoussi
Il capitalismo sotto la «tenda a ossigeno». L’espressione è di Joseph Schumpeter, e sta a designare l’economia mista, le cui condizioni a suo parere non potevano che essere flebili. Fu contro quest’anomia che la cosiddetta rivoluzione conservatrice diede battaglia, alla svolta degli anni 1970-1980. A un dato momento (1984) c’è stato persino chi ha esclamato: «Viva la crisi!». Era«soltanto» l’insorgenza, in tempi di pace, di una disoccupazione di massa; una pura e semplice crisi occupazionale! Per parte mia, non sono disposto ad associarmi agli entusiasti della crisi finanziaria, precisamente in ragione dei suoi potenziali effetti sull’occupazione. Se ho fatto riferimento a quel periodo è perché il 1984 è stato l’anno della conversione (coincidenza o conseguenza?) della maggior parte dei Paesi europei, Francia in testa, alla deregulation finanziaria (lo smantellamento della tenda a ossigeno). Oggi, dopo più di due decenni, un’esigenza di segno diametralmente opposto è ribadita insistentemente in tutti i discorsi, e tradotta in fatti concreti. Chi avrebbe immaginato allora che la nazionalizzazione, sia pure parziale, si sarebbe rivelata la miglior via d’uscita da uno stato di crisi, persino nei Paesi anglosassoni? Come si è arrivati a questo punto? La storia, a un tempo banale e complessa, è ricca di insegnamenti.
- Details
- Hits: 2822

Il codice della continuità
La crisi tra passato e presente
Ugo Mattei
L'altalena delle borse non coincide con la fine del capitalismo, ma con un suo assestamento per riportare ordine e integrare così le periferie dell'impero. La crisi letta attraverso le tesi di Guy Debord sulle «società dello spettacolo»
Provare ad utilizzare le categorie di Guy Debord per riflettere sulle grandi trasformazioni in corso apre percorsi di ricerca che possono essere solo accennati in un articolo, ma sui quali occorrerà tornare in futuro. È noto come il «dottore in nulla» nella sua Società dello Spettacolo avesse introdotto due modelli contrapposti, lo «spettacolo concentrato» proprio delle società totalitarie e dittatoriali, e lo «spettacolo diffuso» proprio delle democrazie occidentali, dominate dal consumismo. Successivamente nei Commentari, scritti nel bel mezzo del terremoto che fece crollare la più spettacolare epifania dello spettacolo concentrato (l'Urss), Debord tracciò il percorso che avrebbe portato alla nascita di ciò che definì «spetacolo integrato». Il crollo del modello sovietico e l'apparente discioglimento dell'equilibrio del terrore avrebbero necessariamente trasformato le «democrazie occidentali», togliendo loro ogni incentivo alla virtù (o alla «moralità» per dirla con Laura Pennacchi). Il sistema si sarebbe così trasformato in una combinazione fra i due modelli precedenti, uno spettacolo integrato caratterizzato da cinque punti: «Il continuo rinnovamento tecnologico; la fusione economico-statale; il segreto generalizzato; il falso indiscutibile; un eterno presente».
- Details
- Hits: 2994

Perché ancora Marx
di Marcello Musto
Nel corso delle ultime settimane, da quando la crisi finanziaria internazionale si è sviluppata così violentemente da sradicare, con le furie dei propri venti, non solo alcune delle più grandi istituzioni del capitalismo americano, ma lo stesso modello neoliberale spacciato come pensiero unico fino a pochi mesi fa, tutti i principali quotidiani internazionali, non importa se di tendenza riformista o liberale, hanno reso omaggio a Karl Marx e alle sue tesi. Egli è ritornato a essere citato negli editoriali dei maggiori quotidiani finanziari mondiali e a essere ritratto sulle copertine di diffusissimi e autorevoli settimanali di Stati Uniti ed Europa.
Alcuni di questi hanno sostituito il viso della Statua della libertà con un profilo soddisfatto di Marx, mentre l'Economist di due settimane fa raffigurava il presidente francese François Sarkozy, in visita a New York, intento a leggere avidamente una copia de Il capitale mentre, sullo sfondo, i palazzi di Wall Street crollavano inesorabilmente.
In tutte le descrizioni e le immagini in cui ho visto ritratto Marx durante queste settimane, egli appariva sempre sorridente e, nonostante il passar degli anni, mi è sembrato piuttosto in forma, anche quando a fare i conti con le sue analisi erano giornalisti che non possono certo essere definiti suoi seguaci.
È per questo motivo che sono rimasto davvero perplesso quando ho letto, invece, proprio sul quotidiano di Rifondazione Comunista, in un articolo a firma del suo direttore Sansonetti sulla crisi del capitalismo e la manifestazione dell'11 di ottobre (che ha visto sfilare 300.000 partecipanti ed è stata definita da tutti a sinistra come un successo), le seguenti parole: “Non mi pare che ci sia altra via percorribile se non quella di ripartire da zero”; non bisogna “pensare per dogmi”, ma “capire che il marxismo, che è una gigantesca teoria politica, non è più sufficiente”.
- Details
- Hits: 2801
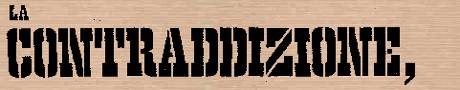
La grande crisi dei mutui spazzatura
di Giorgio Gattei
Nel 2001, quando al collasso della new economy si è aggiunto l'attentato terroristico dell'11 settembre, gli Stati Uniti se la sono vista brutta. Che potesse prendere piede una economia della paura capace di bloccare la crescita futura del PIL? A rimedio la scienza economica consiglia di aumentare i consumi delle famiglie mediante l'aumento dei salari (che vanno però a discapito dei profitti), di favorire gli investimenti delle imprese con l'abbassamento dei tassi di interesse, di aumentare la spesa pubblica anche in deficit spending, ossia senza copertura finanziaria.
E se in quest'ultimo caso i incontrano difficoltà politiche insormontabili, c'è sempre la spesa militare che non ha mai sofferto d'opposizione.
Sulla base di queste opzioni il governo di Bush «il piccolo» ha scelto da subito la via della guerra (prima in Afghanistan e poi in Irak), avendo per obiettivo il rilancio del PIL mediante le commesse belliche e la riduzione del prezzo del petrolio che si sarebbe guadagnata quando, a vittoria conseguita, sarebbero affluite sul mercato le ingenti riserve irakene. Ma pure la Federal Reserve ha fatto la sua parte abbassando il tasso di sconto dal 6,5% del gennaio 2001 all'1% del giugno 2003. Tuttavia qui è stata necessaria una modifica rispetto alla teoria, perché in epoca di globalizzazione non si poteva più fare tanto affidamento sugli investimenti delle imprese che, avendo delocalizzato all'estero dove il costo della manodopera è più basso, col credito concesso avrebbero investito sì, ma all'estero.
- Details
- Hits: 2731
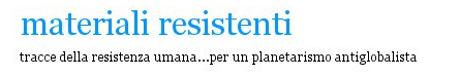
Una storia impossibile: Gli Autonomi I, II e III. Aspettando il IV volume...
di Marcello Tarì
E parlavano di lui, scrivevano di lui / lo facevano più bamba che bambino / e parlavano di lui, scrivevano di lui / sì ma lui rimane sempre clandestino.
Gianfranco Manfredi, Dagli Appennini alle bande
Vi è un trito luogo comune delle scienze storico-antropologiche in cui si sostiene che solo una volta messe a distanza (in senso temporale o spaziale, innanzitutto, ma anche soggettivamente) si è in grado di indagare le vicende umane, ovvero riproducendole in quanto altro da noi. La Storia, indubbiamente, è uno dei più potenti dispositivi di produzione dell'alterità, nella sua capacità di separare ciò che è stato da ciò che è proiettandolo in un altro tempo, in un altro spazio, in un altro mondo. Ma l'alterità è una finzione, un trucco epistemologico tramite il quale lo storico e l'antropologo occidentale hanno provato nella modernità a collocare nello spazio dei saperi dominanti ciò che era ai margini dello sviluppo, ai bordi della norma, fuori dalla governabilità. In realtà non c'è mai nessun altro così come non vi è identità, se non in quanto produzioni di una epistemologia che nel moderno è stata quella del capitale armato. Tutte le lotte e i conflitti che hanno attraversato la modernità sono stati in questo senso altrettanti squarci inferti a quel sistema dei saperi; almeno questo lo si è capito, da una parte e dall'altra. Gli Autonomi e le Autonome hanno rivendicato la possibilità di non essere più l'Altro del/nel potere, l'Altro del/nel capitale, l'Altro della/nella società, bensì una densa, presente, possibilità di vita dislocata nel fuori di ogni dentro. Comunismo ora, qui: adesso o mai più. E se proprio un Altro doveva esserci, ebbene che lo fosse il padrone.
- Details
- Hits: 2768

Scuola politica
Marco Bascetta
«Né di destra, né di sinistra». Di questa definizione, da tempo utilizzata a piene mani dalla destra e dalla sinistra appunto, abbiamo imparato a diffidare. È infatti attraverso questa pretesa di oggettività indiscutibile, divinamente ispirata dall'«interesse generale» che sono stati imposti fino a oggi contenuti di natura restauratrice e repressiva: il controllo pervasivo delle nostre vite, la sicurezza come puro e semplice ordine pubblico, la repressione dei comportamenti giovanili, la discriminazione dei migranti.
Accade ora che questa stessa espressione venga impiegata dall'imponente movimento di studenti, insegnanti e cittadini, che da settimane attraversa tutto il paese, per descrivere se stesso. Ma rovesciandone interamente il senso. È soprattutto questa novità che ha fatto saltare i nervi a Silvio Berlusconi e al suo governo. Che, non a caso, si sono sforzati in ogni modo e contro ogni evidenza di ricondurre questa tumultuosa ripresa dei movimenti all'«estrema sinistra» (che sarà mai?) e al mondo dei centri sociali. Il conflitto «né di destra né di sinistra» che ha invaso scuole, università e piazze di tutta Italia comincia a trasformarsi in un incubo tanto per la maggioranza di governo quanto per le ombre dell'opposizione parlamentare.
- Details
- Hits: 2927
Fine Corsa
di Giulietto Chiesa
Alcune note utili, forse, per affrontare il problema della transizione a un'altra società, che sia compatibile con la sopravvivenza del genere umano. Né più né meno. E non perché, stanti così le cose, come si dirà tra qualche riga, il nostro destino sia quello di essere eliminati dalla faccia del pianeta per manifesta incompatibilità con la natura di cui siamo parte impazzita, in quanto incapace di convivere con la sua entropia.
1) La prima considerazione-constatazione è che l'umanità ha già raggiunto, da oltre 25 anni, la situazione di "insostenibilità". Il termine usato dal Club di Roma, nel suo update del 2002, è "overshooting". Siamo in overshooting da 25 anni. E' una situazione che non si era mai verificata nella vicenda, lunga 5 miliardi di anni, della ecosfera.
Dal 1980 in avanti, circa, i popoli della Terra hanno utilizzato le risorse del pianeta, ogni anno, più di quanto esse siano in condizioni di rigenerarsi.
Cos'è esattamente l'overshooting? E' “andare oltre un limite”, anche senza volerlo. In primo luogo perché non lo si sa. Ciò avviene – dicono gli scienziati del Club di Roma - in condizione di crescita accelerata, oppure quando appare un limite o una barriera, oppure a causa di un errore di valutazione che impedisce di frenare, ovvero quando si vorrebbe frenare ma non ci sono più freni disponibili.
- Details
- Hits: 2648

La ricetta contro il «crack dei crack»? Un new deal europeo, puntato sul sociale
Riccardo Bellofiore, Joseph Halevi
La lezione più profonda del New Deal è un'altra rispetto a quella ripresa dal «keynesimo reale» o dall'attuale salvataggio di emergenza. E' la possibilità di cogliere l'occasione della nazionalizzazione della finanza per promuovere un intervento strutturale diretto dello Stato, mobilitando un «esercito del lavoro». Una sfida che ci piomba addosso, ma non è inattesa. Chi riteneva prematuro porsi i problemi di una più alta e produttiva spesa pubblica è costretto a ricredersi: ci obbliga la devastazione della crisi - sociale, ambientale, energetica. Dalla crisi non si esce se non si trova un nuovo traino di domanda effettiva, e una alternativa di politica economica richiede un diverso Stato, un diverso lavoro, la costruzione di contropoteri. Così fu, per quanto contraddittoriamente, con Roosevelt. Bisogna avere il coraggio di riprendere a pensare in grande: con i piedi per terra, e la testa ben alta, ricollocarsi a quel livello dello scontro, dentro una più netta rottura con la logica capitalistica.
Non potrà essere la svalutazione del dollaro a far ripartire la congiuntura mondiale. Si richiederebbe piuttosto una espansione coordinata della domanda interna nelle varie aree, il cui perno siano una spesa pubblica riqualificata e alti salari: il «ritorno dello Stato» va da un'altra parte. La ricerca parossistica di un «pavimento» alla crisi finanziaria non sta infatti rispondendo alla carenza di domanda. E le misure che eventualmente saranno prese arriveranno fuori tempo massimo per evitare una grave recessione, e il rischio concreto di una successiva prolungata stagnazione.
- Details
- Hits: 3265

Ti ricorda il '29?
di Riccardo Bellofiore e Joseph Halevi
Le risposte di Roosevelt alla crisi, terribilmente simili alle decisioni affannose di queste settimane
Possiamo oggi ripensare il New Deal di Roosevelt? Dipende dalle condizioni soggettive: dalla capacità di radicalizzazione della popolazione salariata, precaria, pensionata e via dicendo. Certamente, deve essere come minimo un'azione a livello europeo.
La crisi «finanziaria» del 1929, che toccò il fondo come crisi «reale» nel 1932-3 (la disoccupazione balzò dal 4,5% al 25%, il resto erano lavori «precari»), nasceva da tre problemi: alta concentrazione nel settore monopolistico, dunque elevati margini di profitto e bassi salari; spostamento della ricchezza verso il casinò di Wall Street; concorrenza sfrenata tra le piccole aziende, che comportò una pletora di capitali. La crisi fu aggravata dal legame del dollaro all'oro; dalla politica monetaria restrittiva della Federal Reserve, indifferente ai crolli bancari; dalla demonizzazione della spesa pubblica da parte di Hoover. Il primo New Deal scaturiva dalla forte spinta a sinistra del partito democratico, grazie anche ai lavoratori immigrati non anglosassoni. Le misure prese immediatamente comprendevano, oltre allo sganciamento dal vincolo aureo, una più elastica provvista di liquidità da parte della Fed e il salvataggio delle banche, soggette ad una più stretta regolazione.
Provvedimenti cruciali furono la Federal Deposit Insurance Corporation, cioè la protezione di conti bancari delle famiglie, che esiste tuttora, e il Glass-Stegall Act, cioè la separazione tra banche commerciali e banche di investimento, annullato da Bill Clinton (oggi le banche di investimento non scompaiono, né sono di nuovo separate dalle banche commerciali, semmai accedono ai depositi raccolti da queste ultime).
- Details
- Hits: 2755
La depressione globale
di Nouriel Roubini
Il sistema finanziario del mondo ricco è diretto verso l' implosione. I mercati finanziari non sono riusciti ad arrestare la loro caduta libera per diversi giorni, il mercato dei titoli a breve termine e quello del credito si sono trovati bloccati di fronte a un balzo dei loro spread sul tasso d' interesse ed è troppo presto per dire se la zattera delle misure adottate dagli Stati Uniti e dall' Europa sarà in grado di rimediare al dissanguamento oltre l' immediato futuro.
Per la prima volta in settant' anni, si è diffuso il timore di un effetto domino generalizzato ed esteso all' intero sistema bancario, mentre quello "ombra" - l' universo costituito da istituti di compravendita, agenzie di mutui non bancari, altri strumenti strutturati d' investimento come gli hedge fund, i fondi di titoli a breve termine e un certo tipo di fondi d' investimento - hanno davanti a sé il rischio di un collasso a partire dalle loro passività a breve termine. Per quanto riguarda l' economia reale, tutte le economie avanzate - che rappresentano il 55 per cento del prodotto interno lordo mondiale - erano già entrate in recessione prima dei devastanti shock finanziari cominciati verso la fine dell' estate. Ora quindi dobbiamo fare i conti con una recessione, con una grave crisi finanziaria e con una grave crisi del sistema bancario. I mercati dei paesi emergenti hanno cominciato a risentire di questa sofferenza soltanto quando gli investitori stranieri hanno iniziato a ritirare le proprie risorse.
- Details
- Hits: 2031
La rivoluzione berlusconiana
di Alessandro Leogrande
In questi mesi il governo Pdl-Lega porterà a termine la propria riforma della giustizia, realizzando uno dei capisaldi della “rivoluzione berlusconiana”, elaborato già nella prima metà del decennio passato quando Berlusconi decise di scendere in campo non solo per sbarrare la strada ai “comunisti”, ma anche, via via, alle toghe rosse, a Mani pulite, alla “casta delle procure” che avevano sovvertito e avrebbero continuato a sovvertire la democrazia italiana. Sanare questo tumore, ricondurlo all’ordine, cioè alla posizione che occupava prima di Tangentopoli, è da sempre uno degli obiettivi del berlusconismo. Chi ha pensato negli anni, e ultimamente fino all’approvazione del lodo Alfano, che Berlusconi si occupasse di giustizia solo per regolare e anestetizzare i processi che lo riguardavano, si è mostrato miope.
C’è sicuramente del “personale” in tutto questo, e il Cavaliere ha sempre gridato alla persecuzione giudiziaria, all’accanimento di alcune toghe nei suoi confronti. Ma c’è anche qualcosa di più, molto di più: ridurre l’autonomia della magistratura, farne un ente alle dipendenze dello strapotere governativo risponde a interessi più vasti che si riconoscono nel berlusconismo e da esso si sentono protetti. Tale mossa è in piena sintonia con le pretese del partito degli avvocati, trasversale a tutto il centrodestra, che in questi anni è diventato una potente lobby parlamentare. Non è solo una mossa difensiva, risponde a un preciso impianto ideologico. E qui la parola “ideologia” è usata nel senso più strettamente filosofico: visione del mondo e delle sue cose, ed elaborazione di una teoria politica che sia sulla stessa lunghezza d’onda.
- Details
- Hits: 3380
Operaismo, non confondiamo tutto
Ferruccio Gambino
"L'assalto al cielo" di Steve Wright, studioso australiano dei movimenti della seconda metà del '900
Dobbiamo a Steve Wright, noto studioso australiano dei movimenti della seconda metà del Novecento, questo volume che disegna la parabola di Classe Operaia (1964-67), Potere Operaio (1969-73) e dell'Autonomia operaia (1973-79): L'assalto al cielo. Per una storia dell'operaismo (postfazione di Riccardo Bellofiore e Massimiliano Tomba, Edizioni Alegre, Roma 2008, pp. 334, euro 20).
Alla prima edizione inglese del 2002 è seguita l'edizione tedesca del 2005 e adesso quella italiana, nella traduzione di Willer Montefusco, grazie al rinnovato interesse per l'operaismo, come osservano Bellofiore e Tomba nella loro postfazione. Steve Wright ricostruisce questa vicenda che troppo a lungo era rimasta affidata alle arringhe di vari magistrati, a parte il notevole contributo di Franco Berardi ( La nefasta utopia di Potere Operaio , Castelvecchi, 2003) e ci offre un'interpretazione documentata e originale del dibattito che ha segnato l'operaismo negli anni '60 e '70.
- Details
- Hits: 2643

Alla radice del «pubblico» perduto
Luigi Cavallaro
La crisi finanziaria esplosa in queste settimane rappresenta il culmine di un processo che ha avuto inizio sul finire degli anni '70 e che, dopo un primo crack nel 1987, ha vissuto un vero e proprio boom negli anni '90 e una sorta di superfetazione negli ultimi dieci anni. Si tratta di un processo nel corso del quale sono stati letteralmente rovesciati gli assunti su cui, nel trentennio precedente, si era costruito il senso comune in materia di politica economica. In quel periodo un po' tutti erano convinti che il buon funzionamento dell'economia necessitava di alcune regole. I settori guida dovevano essere socializzati. Una grossa quota di bisogni privati (trasporti, casa, scuola, sanità, pensioni) doveva essere soddisfatta attraverso consumi collettivi.
La tassazione dei redditi e della ricchezza doveva ridurre le disparità economiche. Ultimo, e non meno importante, i mercati finanziari dovevano essere limitati nella loro capacità di speculare sulle passività delle imprese e dello stato.
Non era una ricetta sbagliata, tant'è che tutte le economie occidentali, sul finire degli anni '60, avevano praticamente raggiunto la piena occupazione: nell'opinione di storici insigni come Hobsbawm, quel periodo viene designato non a caso col nome di «Età dell'oro».
Fu in quel torno di tempo (approssimativamente, tra il 1968 e il 1977) che a sinistra si consumò una cesura rilevante tra coloro che, fino a quel momento, si erano avvalsi del patrimonio di teorie e prassi del movimento operaio novecentesco per interpretare il mondo (e, bisogna aggiungere, anche per trasformarlo non poco) e coloro che, invece, erano cresciuti nel ferro e nel fuoco della critica a quel patrimonio di pratiche sociali e culturali.
- Details
- Hits: 1704

Oltre l'ossessione del berlusconismo
Guido Viale
L'uomo di Arcore è «solo» l'italica personificazione di un degrado mondiale. La versione specifica di una caduta umana, da cui bisogna tentare d'uscire con un «movimento dal basso» che diventi «fatto politico»
A cavallo tra gli anni '50 e '60 del secolo scorso, in Francia, il pensiero radicale di sinistra aveva dato vita a una rivista dal titolo profetico Socialisme ou barbarie. Mai analisi storica è stata più pregnante: il socialismo non si è realizzato - e forse non avrebbe potuto realizzarsi mai - ed è sopravvenuta la barbarie. Quella in cui tuttI noi, insieme all'intero pianeta, siamo ormai immersi.
Come La lettera rubata di Poe, la barbarie è lì davanti ai nostri occhi; ma proprio per questo non la vediamo; e quando qualcosa colpisce la nostra attenzione, come i conflitti di interesse del presidente del Consiglio, la pornografia eletta a sistema di selezione della classe di governo, la truffa mondiale della Parmalat, l'invasione dell'immondizia, le tifoserie scatenate o il razzismo della Lega, tendiamo ad attribuirla a una specificità nostrana, come se il resto del pianeta fosse immune da cose simili o anche peggiori. Invece, fatte le debite proporzioni, i conflitti di interesse che hanno portato in Iraq e in Afghanistan Bush e i suoi accoliti fanno impallidire quelli di Berlusconi (con l'aggravante che negli Stati uniti non c'è nemmeno una magistratura che, nel bene o nel male, li abbia messi sotto accusa); l'improvvisa ascesa di alcune soubrette al governo del nostro paese non sono che una versione sporcacciona dell'ascesa che potrebbe portare un «pitbull con il rossetto» a rovesciare un pronostico elettorale dato ormai per scontato; le truffe perpetrate dal sistema finanziario degli Stati uniti giganteggiano di fronte a quelle di Parmalat, Cirio, Banca di Lodi o Alitalia; la spettacolarizzazione che trasforma in successi gaffe e flop interni e internazionali di Berlusconi fanno scuola nel mondo.
- Details
- Hits: 2961

La grande crisi
Rossana Rossanda
Che deve pensare una cittadina come me, sprovveduta di teoria e pratica economica e perseguitata da vent'anni dal coro «meno stato più mercato», quando legge che la Camera dei rappresentanti e il Senato degli Usa stanno decidendo di stanziare 700 miliardi di dollari pubblici per coprire il gigantesco buco che banche e assicurazioni private hanno fatto? Prima di tutto, che vuol dire? Che con questi 700 miliardi di dollari lo stato federale si fa carico, cioè fa carico ai contribuenti, dell'immenso buco scavato da banchieri e assicuratori senza avere nulla in cambio, soltanto perché le macerie non precipitino su tutti, tipo 1929? Oppure che in cambio mette un guinzaglio su quelle proprietà, stabilendo quel che possono o non possono continuare a fare, alla faccia della libertà di impresa, sacra fino all'altro ieri? O che addirittura le hanno nazionalizzate, nel senso che sono diventati proprietari diretti di banche e assicurazioni?
Idem per l'Europa. Negli Stati uniti il congresso aveva emesso qualche lamento e prima di votare il Senato ha imposto degli emendamenti, mentre nel vecchio continente qualcuno ha deciso in meno di 24 ore di salvare Fortis e Texia e il presidente francese, nonché attualmente della Ue, Sarkozy, doveva annunciare ieri che la Ue istituiva un fondo di 300 miliardi di euro per salvare banche e assicurazioni europee in eventuale emergenza? Senonché Angela Merkel, che di questo non era stata informata, sta lanciando alte strida: «La Germania non ci metterà un soldo», per cui allo stato dei fatti Sarkozy rinunciava ad annunciare, e domani si vedrà.
Page 603 of 611