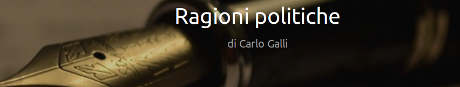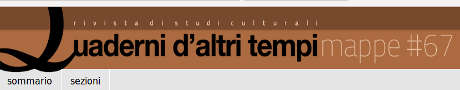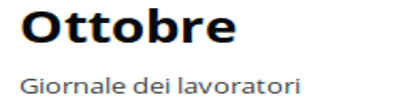Fai una donazione
Questo sito è autofinanziato. L'aumento dei costi ci costringe a chiedere un piccolo aiuto ai lettori. CHI NON HA O NON VUOLE USARE UNA CARTA DI CREDITO può comunque cliccare su "donate" e nella pagina successiva è presente (in alto) l'IBAN per un bonifico diretto________________________________
- Details
- Hits: 3869
La Nuova Era cinese tra declino Usa e debolezze Ue
Martino Avanti intervista Alberto Bradanini
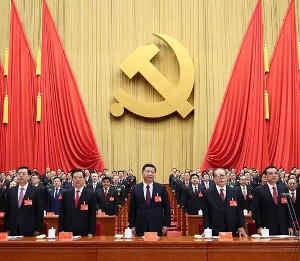 Abbiamo fatto qualche domanda ad Alberto Bradanini, consigliere commerciale all’ambasciata italiana a Pechino tra il 1991 e il 1996 e poi ambasciatore a Pechino nel periodo 2013-2015. Parla del modello cinese, di come dominio della politica sull’economia e piena sovranità siano le condizioni per aspirare allo sviluppo mantenendo come obiettivo finale l’affermarsi del socialismo, per quanto il termine sia oggi mescolato a una forte apertura al capitalismo. «Un insegnamento utile anche all’Italia e l’Unione europea» dice l’ex ambasciatore. Che invita a cogliere l’opportunità di interloquire con la Cina e a un atteggiamento meno subalterno tanto agli Usa quanto al dominio tedesco.
Abbiamo fatto qualche domanda ad Alberto Bradanini, consigliere commerciale all’ambasciata italiana a Pechino tra il 1991 e il 1996 e poi ambasciatore a Pechino nel periodo 2013-2015. Parla del modello cinese, di come dominio della politica sull’economia e piena sovranità siano le condizioni per aspirare allo sviluppo mantenendo come obiettivo finale l’affermarsi del socialismo, per quanto il termine sia oggi mescolato a una forte apertura al capitalismo. «Un insegnamento utile anche all’Italia e l’Unione europea» dice l’ex ambasciatore. Che invita a cogliere l’opportunità di interloquire con la Cina e a un atteggiamento meno subalterno tanto agli Usa quanto al dominio tedesco.
* * * *
Quali prospettive si aprono per l’Italia e per l’Europa con l’ascesa della Cina come protagonista della politica (e dell’economia) internazionale?
L’Europa è un continente politicamente ed economicamente frammentato. Nell’Ue, dove prevalgono le priorità stabilite dal direttorio franco-tedesco, vige la legge della giungla, e non certo quello spirito di solidarietà che pervade le pagine dei Trattati. Sul piano strategico, la Cina avrebbe interesse a dialogare con un’Europa come soggetto politico non solo economico, alla luce della concezione multipolare delle relazioni internazionali che reputa di sua convenienza. Un percorso questo oggi assai improbabile per ragioni endogene, e comunque indipendente dalle scelte cinesi.
Nei limiti menzionati, l’Europa potrà beneficiare dell’interazione con l’economia cinese se riuscirà a essere leader nei settori industriali di punta e nelle tecnologie del futuro. A tal fine però sarebbero necessari massicci investimenti pubblici che sono oggi impediti dalle assurde politiche di austerità di marca tedesca.
L’Italia potrà a sua volta raccogliere qualche beneficio da un’interlocuzione con la Cina se dopo aver recuperato la propria sovranità monetaria saprà avviare una politica economica degna di questo nome, riavviando il tessuto industriale ridottosi del 20% nell’ultimo decennio e investendo massicciamente su innovazione e ricerca.
- Details
- Hits: 2161
Dal Russiagate al Russiaflop e all'arresto di Assange
Era la stampa, bellezza. Si è uccisa
di Fulvio Grimaldi
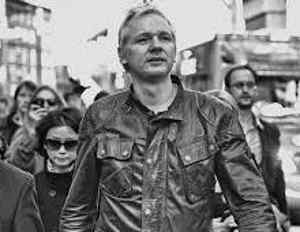
“L’arresto di Julian Assange, il dissidente che ha segnato a livello planetario un’epoca nuova nella tensione fra lo scrutinio democratico delle decisioni dei poteri di governo e la Ragion di Stato, pone un problema drammatico alla coscienza politica di tutto l’Occidente”. (I parlamentari del Movimento 5 Stelle)
Un giornalista. Vero.
Dopo un accusa svedese di molestie sessuali, mossa da due collaboratrici Cia e poi archiviata, sul modello Brizzi e Argento; dopo sette anni di reclusione nell’ambasciata londinese dell’Ecuador, prima da rifugiato, grazie a un presidente ecuadoriano perbene, Correa, e, poi, da ostaggio e prigioniero, per servilismo agli Usa di un presidente fellone, Moreno, Julian Assange, eroe e martire della libertà d’informazione, è stato arrestato da Scotland Yard. Lo aspetta l’estradizione negli Usa e un processo in base ad accuse segrete, formulate da un Gran Giurì segreto, che prospettano la condanna a morte.
Per essersi rifiutata di testimoniare contro Assange davanti al Gran Giurì segreto, Chelsea Manning, che fornì a Wikileaks i documenti attestanti i crimini di guerra e contro l’umanità commessi dagli Usa in Iraq e Afghanistan e si è fatta 7 anni di carcere, è stata di nuovo imprigionata e posta in isolamento. Assange e Manning sono i disvelatori e comunicatori di ciò che il potere fa di nascosto e ai danni dell’umanità. Sono ciò che dovrebbero essere i giornalisti e che nell’era della globalizzazione, cioè della presa di possesso di tutto, non esiste più. Salvo in qualche angolo della rete.
Gli unici, tra giornalisti e politici che hanno avuto la primordiale decenza di marchiare a fuoco la persecuzione di Assange, senza se e senza ma, sono stati i 5 Stelle, con Di Battista, Di Manlio, Morra. I migliori. Grazie e onore a loro.
Come va? Da noi tutto bene.
- Details
- Hits: 2230
Quale pensiero critico per la sinistra?
di Giuseppe Montalbano
Le correnti teoriche, gli autori, le opere più importanti della galassia della sinistra dopo l’89: nel nuovo libro del filosofo Giorgio Cesarale una cartografia ragionata del pensiero critico contemporaneo che struttura il campo dell’alternativa al capitalismo neoliberale
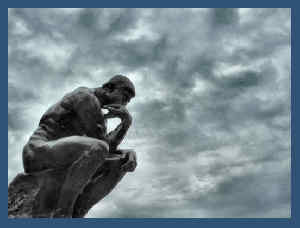 Quali le principali linee di sviluppo del pensiero critico a sinistra cresciuto sulle macerie lasciate dal crollo dell’Unione sovietica e dall’affermazione del modello “neo-liberale” di capitalismo su scala globale? Come (ri)pensare la critica degli assetti di potere dominanti nelle società contemporanee e le possibilità di un’alternativa di sistema nelle parallele crisi delle “sinistre” al livello sociale, politico e culturale? Queste le due impegnative questioni in cui si può riassumere la problematica di fondo dell’ultimo lavoro di Giorgio Cesarale, A Sinistra. Il pensiero critico dopo il 1989 (Laterza, 2019). Un libro tremendamente utile innanzitutto per spianare e rendere più facilmente percorribili – anche a un pubblico non specialistico – quei sentieri del pensiero critico tracciati a partire dalla stagione del lungo ’68 in Europa e negli Stati Uniti, e che non hanno smesso di essere battuti oltre il crollo del muro di Berlino.
Quali le principali linee di sviluppo del pensiero critico a sinistra cresciuto sulle macerie lasciate dal crollo dell’Unione sovietica e dall’affermazione del modello “neo-liberale” di capitalismo su scala globale? Come (ri)pensare la critica degli assetti di potere dominanti nelle società contemporanee e le possibilità di un’alternativa di sistema nelle parallele crisi delle “sinistre” al livello sociale, politico e culturale? Queste le due impegnative questioni in cui si può riassumere la problematica di fondo dell’ultimo lavoro di Giorgio Cesarale, A Sinistra. Il pensiero critico dopo il 1989 (Laterza, 2019). Un libro tremendamente utile innanzitutto per spianare e rendere più facilmente percorribili – anche a un pubblico non specialistico – quei sentieri del pensiero critico tracciati a partire dalla stagione del lungo ’68 in Europa e negli Stati Uniti, e che non hanno smesso di essere battuti oltre il crollo del muro di Berlino.
Se le sinistre in Occidente non hanno ancora fatto del tutto i conti con il “disastro oscuro” che le ha investite negli ultimi 30 anni (dal titolo dell’epitaffio di Badiou per la fine dell’URSS, citato in apertura del testo), le filosofie e teorie critiche emerse da quella oscurità possono ancora accendere potenzialità e prospettive di un’alternativa possibile a una società per nulla pacificata. A patto di gettare luce sulle stesse zone d’ombra e i punti ciechi del pensiero critico contemporaneo. Questo il secondo notevole merito del libro. L’intento di Cesarale non è, infatti, soltanto quello di offrire un’agile guida per orientare il lettore nell’intrico di percorsi e ramificazioni del dibattito teorico contemporaneo a sinistra. La mappatura delle principali correnti del pensiero critico attuale serve a mostrarne, più profondamente, le traiettorie comuni e i territori ancora inesplorati. Per questo vale la pena soffermarsi proprio sui confini tracciati e sulla bussola utilizzata da Cesarale nella cartografia di ciò che ancora si muove a sinistra sul terreno della riflessione filosofica e teorica.
- Details
- Hits: 3012

Crisi globale e capitale fittizio
di Raffaele Sciortino
Excursus dal volume Raffaele Sciortino, I dieci anni che sconvolsero il mondo, Asterios, Trieste 2019, pp. 34-41
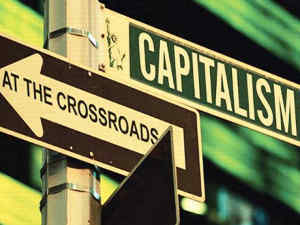 Ma qual è il nesso profondo tra globalizzazione finanziaria e crisi globale? Ovvero, come andare oltre il livello descrittivo? È una domanda, chiaramente, dalle importanti implicazioni politiche oltreché teorico-analitiche. In questa scheda alcune indicazioni sulle principali posizioni e sull’ipotesi guida di questo lavoro.
Ma qual è il nesso profondo tra globalizzazione finanziaria e crisi globale? Ovvero, come andare oltre il livello descrittivo? È una domanda, chiaramente, dalle importanti implicazioni politiche oltreché teorico-analitiche. In questa scheda alcune indicazioni sulle principali posizioni e sull’ipotesi guida di questo lavoro.
All’indomani della crisi sembra ci siano tutte le condizioni per un ritorno in auge delle ricette keynesiane, vista la débacle in corso del cosiddetto neoliberismo. Per i neo-keynesiani l’eziologia della crisi, letta come crisi principalmente se non esclusivamente finanziaria, sta in primo luogo nel greed di Wall Street, nell’eccessiva avidità della finanza speculativa che avrebbe perso il senso del limite anche a causa delle misure di deregolamentazione degli anni Novanta - in primis l’abolizione nel 1999 da parte del Congresso statunitense del Glass-Steagall Act che, varato sotto il New Deal, prevedeva la separazione tra attività bancaria tradizionale e speculativa - da parte di una classe politica disinvolta e ammaliata dai successi del corso neoliberista.1 A questa diagnosi i post-keynesiani, la sinistra del keynesismo, aggiungono gli effetti deleteri per i livelli della domanda complessiva del sottoconsumo delle masse dovuto alla caduta del monte salari complessivo negli ultimi decenni.2 La terapia proposta è la ri-regolazione della finanza per un maggiore controllo sugli eccessi speculativi, nonché un peraltro assai cauto ritorno all’intervento statale, basato per lo più su politiche monetarie lasche opposte a quelle della scuola austriaca - che vede la crisi come un classico caso di deflazione da debito causata da tassi di interesse eccessivamente bassi - al fine di stimolare la domanda aggregata, eventualmente rivista nell’ottica della green economy. Non si arriva dunque a proporre, in genere, un vero e proprio nuovo New Deal con politiche redistributive significative. Del resto, a questo fine i problemi in Occidente sarebbero enormi se non insormontabili.
- Details
- Hits: 2741
Epitaffio per l'Urss: un orologio senza molla
di Christopher J. Arthur✴
Probabilmente si tratta del punto centrale all'origine del crollo dell'URSS e dei paesi socialisti: non vi era un vero e proprio modo di produzione, perché il sistema fabbrica (base materiale) non armonizzava il sistema della gestione per la quale è stato creato (accumulazione). Ma c'è da riflettere sul fatto che se, come è plausibile, il modo di produzione sovietico non era né capitalistico né socialista, ma è definito da Arthur "economia amministrata", una sorta di economia formata da capitali ma senza produzione di plusvalore e senza capitalisti, "un orologio senza molle", allora c'è da chiedersi con il 1989 che cosa sia veramente crollato. Altro punto importante è se sia possibile evitare, e come, il crearsi di una "burocrazia" privilegiata quale forma di nuova borghesia. Anche questo non potrà che riproporsi in futuro. L'ideologia dominante ripete che il socialismo è fallito perché non può funzionare, e purtroppo questa frase è fatta propria dal 99% delle persone, compresi i lavoratori. Ma in realtà che cosa è veramente fallito? Se non c'era il socialismo né il capitalismo, il primo non è crollato ma è ancora tutto da costruire (il collettivo)
 E' importante comprendere il “crollo” dell’Urss perché il dibattito sulla natura dell’Unione Sovietica riguarda ancora la teoria e la pratica socialiste. L’analisi del socialismo non-più-realizzato ha un significato generale dal momento che, chiaramente, la lezione che se ne può trarre non riguarda unicamente la situazione russa ma è rilevante per la teoria e la pratica della transizione in generale. Infatti, essa rende più pressante una domanda: cosa è richiesto per un reale e permanente superamento del capitalismo? Chiunque sia interessato a tale questione deve imparare dalla lezione di questo tentativo fallito, e chiunque si dica marxista deve dare conto di “cosa è andato storto”, in coerenza con la teoria marxista stessa1 . Nella seconda parte di questo scritto, abbozzo alcune considerazioni su questi problemi. Nella terza parte, prendo in considerazione le opinioni di Istvàn Mészàros, contenute nel suo più voluminoso lavoro, Beyond Capital (Oltre il capitale). Ma per prima cosa fissiamo la scena per la nostra analisi della transizione dal capitalismo all’Urss, affrontando la questione della dialettica tra forma e contenuto.
E' importante comprendere il “crollo” dell’Urss perché il dibattito sulla natura dell’Unione Sovietica riguarda ancora la teoria e la pratica socialiste. L’analisi del socialismo non-più-realizzato ha un significato generale dal momento che, chiaramente, la lezione che se ne può trarre non riguarda unicamente la situazione russa ma è rilevante per la teoria e la pratica della transizione in generale. Infatti, essa rende più pressante una domanda: cosa è richiesto per un reale e permanente superamento del capitalismo? Chiunque sia interessato a tale questione deve imparare dalla lezione di questo tentativo fallito, e chiunque si dica marxista deve dare conto di “cosa è andato storto”, in coerenza con la teoria marxista stessa1 . Nella seconda parte di questo scritto, abbozzo alcune considerazioni su questi problemi. Nella terza parte, prendo in considerazione le opinioni di Istvàn Mészàros, contenute nel suo più voluminoso lavoro, Beyond Capital (Oltre il capitale). Ma per prima cosa fissiamo la scena per la nostra analisi della transizione dal capitalismo all’Urss, affrontando la questione della dialettica tra forma e contenuto.
- Details
- Hits: 2622
Potere disciplinante e libertà controllata
Esiti morali della moderna configurazione del potere
di Federico Sollazzo
 La concezione, di derivazione marcusiana, di “sistema”, esprime una ricca e articolata descrizione della nuova forma storica dei meccanismi di dominio (come è ormai evidente, in questo testo si considera il potere “francofortianamente” come dominio, la qual cosa non è da ritenersi in contrasto, bensì in interazione con la concezione foucaultiana del potere come categoria relazionale). Tale sistema affonda le sue origini in una certa razionalità tecnologica che conduce ad una totale subordinazione dell’esistenza ad un paradigma produttivo, di senso più che di beni, efficientista e oggettivante, funzionale all’instaurarsi ed al perpetuarsi di una nuova forma di dominio.
La concezione, di derivazione marcusiana, di “sistema”, esprime una ricca e articolata descrizione della nuova forma storica dei meccanismi di dominio (come è ormai evidente, in questo testo si considera il potere “francofortianamente” come dominio, la qual cosa non è da ritenersi in contrasto, bensì in interazione con la concezione foucaultiana del potere come categoria relazionale). Tale sistema affonda le sue origini in una certa razionalità tecnologica che conduce ad una totale subordinazione dell’esistenza ad un paradigma produttivo, di senso più che di beni, efficientista e oggettivante, funzionale all’instaurarsi ed al perpetuarsi di una nuova forma di dominio.
Nella realtà sociale, nonostante tutti i mutamenti, il dominio dell’uomo sull’uomo rimane il continuum storico che congiunge la Ragione pretecnologica a quella tecnologica. La società che progetta e intraprende la trasformazione tecnologica della natura trasforma tuttavia la base del dominio, sostituendo gradualmente la dipendenza personale (dello schiavo dal padrone, del servo dal signore del feudo, del feudatario dal donatore del feudo) in dipendenza dall’”ordine oggettivo delle cose” (dalle leggi economiche, dal mercato, ecc.) […] Noi viviamo e moriamo in modo razionale e produttivo. Noi sappiamo che la distruzione è il prezzo del progresso, così come la morte è il prezzo della vita; che rinuncia e fatica sono condizioni necessarie del piacere e della gioia; che l’attività economica deve proseguire, e che le alternative sono utopiche. Questa ideologia appartiene all’apparato stabilito della società; è un requisito del suo regolare funzionamento, fa parte della sua razionalità[1]
Ma a tale esito non si è giunti a causa della tecnica, la mera capacità di fare qualcosa, senza un orientamento di tale fare, quindi in sé neutrale in quanto sprovvista di un telos, bensì a causa dello sviluppo di una determinata tecnologia, la forma storica della tecnica, ovvero lo specifico modo, sempre con finalità e con razionalità storicamente determinate, di impiego di tale capacità. E lo sviluppo della moderna tecnologia, dunque questa tecnologia, ha come esito determinante quello dell’inibizione del pensiero critico.
- Details
- Hits: 3656
Per una nuova teoria del valore
di Tommaso Redolfi Riva
Per Riccardo Bellofiore, che ha esposto questa tesi nel suo ultimo "Le avventure della socializzazione. Dalla teoria monetaria del valore alla teoria macro-monetaria della produzione capitalistica" (Mimesis), non è più possibile procedere a una semplice interpretazione dell’opera di Marx. È invece necessario guardare ai punti alti della teoria economica, svilupparli e incorporarli in una critica dell’economia politica che sia al contempo economia politica critica: messa in discussione del rapporto sociale capitalistico e indagine sulla sua forma di movimento
 Nella critica dell’economia politica, la legge dell’accumulazione capitalistica – che ha il suo principio nella valorizzazione del valore – rappresenta la forma di moto specifica che caratterizza il modo di produzione capitalistico. Il rapporto di produzione, che è sempre un modo particolare nel quale si realizza l’unione tra i lavoratori e i mezzi di produzione, una volta che ha assunto la forma capitalistica, una volta cioè che si è costituito come rapporto di capitale, “costringe senza scrupoli l’umanità alla produzione per la produzione”[1]. Non è certo un caso che questa frase di Marx riappaia nella Dialettica negativa là dove Adorno vuole presentare il dominio dello spirito del mondo sulle azioni individuali, della storia sugli individui storici, dell’universale sul particolare: l’autonomizzazione della società, il farsi obiettivo del vincolo sociale, rappresenta un tema centrale della sua riflessione matura[2]. Nel modo di produzione capitalistico, il rapporto sociale che lega gli individui gli uni agli altri, il modo cioè in cui la società produce e riproduce se stessa, si rende indipendente dagli individui, i quali si trovano nella necessità di fungere da semplici momenti di un processo che ha una propria dinamica specifica e che si impone loro come contrainte esteriore. Per Adorno, l’individuo, che la sociologia comprendente vorrebbe sostanziale, decade a semplice luogo di un’azione che si svolge alle sue spalle e di cui diviene semplice portatore. Ma se la sociologia comprendente non coglie la costrizione esteriore che la società esercita sull’individuo, quella funzionalista la assume come dato, eternizzando, di fatto, l’autonomizzazione della società. Compito della teoria critica della società è quindi quello di superare l’unilateralità di entrambi gli approcci e mostrare “come quei rapporti che si sono resi indipendenti e impenetrabili per gli uomini, derivino proprio da rapporti fra gli uomini”[3].
Nella critica dell’economia politica, la legge dell’accumulazione capitalistica – che ha il suo principio nella valorizzazione del valore – rappresenta la forma di moto specifica che caratterizza il modo di produzione capitalistico. Il rapporto di produzione, che è sempre un modo particolare nel quale si realizza l’unione tra i lavoratori e i mezzi di produzione, una volta che ha assunto la forma capitalistica, una volta cioè che si è costituito come rapporto di capitale, “costringe senza scrupoli l’umanità alla produzione per la produzione”[1]. Non è certo un caso che questa frase di Marx riappaia nella Dialettica negativa là dove Adorno vuole presentare il dominio dello spirito del mondo sulle azioni individuali, della storia sugli individui storici, dell’universale sul particolare: l’autonomizzazione della società, il farsi obiettivo del vincolo sociale, rappresenta un tema centrale della sua riflessione matura[2]. Nel modo di produzione capitalistico, il rapporto sociale che lega gli individui gli uni agli altri, il modo cioè in cui la società produce e riproduce se stessa, si rende indipendente dagli individui, i quali si trovano nella necessità di fungere da semplici momenti di un processo che ha una propria dinamica specifica e che si impone loro come contrainte esteriore. Per Adorno, l’individuo, che la sociologia comprendente vorrebbe sostanziale, decade a semplice luogo di un’azione che si svolge alle sue spalle e di cui diviene semplice portatore. Ma se la sociologia comprendente non coglie la costrizione esteriore che la società esercita sull’individuo, quella funzionalista la assume come dato, eternizzando, di fatto, l’autonomizzazione della società. Compito della teoria critica della società è quindi quello di superare l’unilateralità di entrambi gli approcci e mostrare “come quei rapporti che si sono resi indipendenti e impenetrabili per gli uomini, derivino proprio da rapporti fra gli uomini”[3].
La comprensione dell’autonomizzazione della società, della totalità che retrocede gli individui a meri portatori della sua riproduzione, del dominio e della violenza dell’universale sul particolare, risiede per Adorno, nell’analisi del processo di scambio. Esso si presenta da un lato, mediazione totalizzante, dall’altro, astrazione obiettiva capace di ridurre la differenza qualitativa di ogni oggetto alla comparabilità quantitativa del valore.
- Details
- Hits: 2557

Point Break: Crisi globale - sindacato internazionale
di Daniele Canti*
 Dal fallimento della banca d'affari Lehman Brothers avvenuto a settembre 2008 sono trascorsi oltre dieci anni. Sino a pochi mesi or sono, secondo la vulgata, la crisi era ormai alle nostre spalle ed il problema era agganciarsi alla ripresa. Ora qualche dubbio che non ci sia nulla a cui agganciarsi comincia a farsi largo.
Dal fallimento della banca d'affari Lehman Brothers avvenuto a settembre 2008 sono trascorsi oltre dieci anni. Sino a pochi mesi or sono, secondo la vulgata, la crisi era ormai alle nostre spalle ed il problema era agganciarsi alla ripresa. Ora qualche dubbio che non ci sia nulla a cui agganciarsi comincia a farsi largo.
Ma anche quando vengono avanzate riserve sul radioso futuro che ci attenderebbe, lo si fa soltanto sull’onda dell’ultimo rilevamento dato in pasto dai mass media e non in base ad un analisi più approfondita del sistema e delle sue contraddizioni.
Partiamo dal 2008.
L’elemento decisivo per la crescita della bolla immobiliare fu la riduzione continua dei tassi praticata dalla Federal Reserve che favorì l’indebitamento delle famiglie americane.
Tra il 2000 ed il 2003 il tasso della FED passò dal 6,5% all’1%. I lavoratori americani compravano case, i mutui erano vantaggiosi, il prezzo degli immobili saliva. Il valore degli immobili dati in garanzia si gonfiava a dismisura. La FED, resosi conto della bolla immobiliare che si era creata, dal 2004 al 2006 alzo il tasso d’interesse al 5,5%. I lavoratori, in pochissimo tempo, si ritrovarono con rate di mutui molto più alte che non riuscivano a pagare. Gli immobili crollarono di valore. Nel frattempo, grazie alla “tripla A” attribuita dalle blasonate società di rating ai titoli di credito derivati dalla cartolarizzazione dei mutui subprime (sottoscritti prevalentemente da lavoratori precari), i fondi pensione dei lavoratori americani si fecero una scorpacciata di titoli spazzatura. Così in un colpo solo la working class americana perse il lavoro, la casa, la pensione.
Ma perché la Federal Reserve si comportò in modo così apparentemente irrazionale? La ragione è molto semplice. Risiede in un’altra bolla che era scoppiata nel 2001 quella delle dot.com , le aziende informatiche facenti riferimento a Internet. La politica monetaria espansiva messa in atto, era dunque la risposta al collasso economico derivato dalla precedente bolla speculativa.
- Details
- Hits: 3102
Circa Ada Colau, “Agenda Urbana e neomunicipalismo”
di Alessandro Visalli
 L’alcaldesa di Barcellona, Ada Colau, è certamente una star, ed è portatrice di una linea politica di successo nella grande e cosmopolita città metropolitana di Barcellona. Questa linea unisce creativamente assi portanti di lungo periodo nella politica del ayuntamiento catalano, come il conflitto con lo Stato centrale madrilista per l’attrazione -o la rivendicazione- di capitali pubblici, con temi consolidati della sinistra ‘radicale’ internazionale, come il carattere progressivo della modernizzazione e per essa dei centri “avanzati” nel capitalismo immateriale, in transizione verso la logica dei “commons”. Il secondo è un grande tema, con immenso portato di riflessioni, alcune di grande valore, verso il quale non intendo proporre una sommaria liquidazione, ma che appare in qualche modo confutato dagli eventi (la modernizzazione non ha portato avanzamento e le classi creative non hanno preso il comando del capitale, casomai è avvenuto il contrario).
L’alcaldesa di Barcellona, Ada Colau, è certamente una star, ed è portatrice di una linea politica di successo nella grande e cosmopolita città metropolitana di Barcellona. Questa linea unisce creativamente assi portanti di lungo periodo nella politica del ayuntamiento catalano, come il conflitto con lo Stato centrale madrilista per l’attrazione -o la rivendicazione- di capitali pubblici, con temi consolidati della sinistra ‘radicale’ internazionale, come il carattere progressivo della modernizzazione e per essa dei centri “avanzati” nel capitalismo immateriale, in transizione verso la logica dei “commons”. Il secondo è un grande tema, con immenso portato di riflessioni, alcune di grande valore, verso il quale non intendo proporre una sommaria liquidazione, ma che appare in qualche modo confutato dagli eventi (la modernizzazione non ha portato avanzamento e le classi creative non hanno preso il comando del capitale, casomai è avvenuto il contrario).
Il primo è, mi sembra, la sostanza dell’operazione che la “città globale”[1] di Barcellona, in linea, magari in parte inconsapevole, con una tradizione forte, porta avanti nel cercare di ottenere più risorse e più competenze dallo Stato Nazionale. Ma in estensione, e quindi con altre città globali, come vedremo, si tratta di proporre un nuovo e diverso equilibrio di sistema che veda, da una parte, maggiori competenze, ed in misura assai ridotta risorse, al livello sopranazionale europeo e, dall’altra, maggiori competenze e risorse al livello regionale e metropolitano, ovvero ai livelli alti della governance locale. Il tradizionale assetto fondato sullo Stato Nazionale viene ad essere in tal modo eroso in due direzioni: privato di capacità di direzione dell’economia dalla UE e contemporaneamente di capacità di spesa e quindi di capacità di svolgere un’azione equilibrante dalle sottostanti amministrazioni locali. In prospettiva, seguendo questa linea, la quota di risorse fiscali gestite dal centro nazionale potrebbe scendere sotto la metà del totale e con essa la capacità di mettere in campo politiche di riequilibrio rispetto alle tendenze polarizzanti spontanee del modo di produzione in essere.
- Details
- Hits: 3212
Perché ha vinto Trump?
Le Vere Cause della Vittoria di Donald Trump
di John Komlos, Salvatore Perri
La vittoria di Trump non è solo frutto di un voto di protesta, ma è il risultato di trasformazioni politiche e sociali in atto negli USA da più di trent’anni
 La vittoria di Donald Trump nelle elezioni presidenziali del 2016 è stata determinata dal cambiamento della maggioranza di tre stati “contendibili” che sono passati dal votare il Partito Democratico a votare per quello Repubblicano. Tuttavia, ridurre questo risultato ad un voto di protesta oltre ad essere semplicistico risulta essere completamente sbagliato. La presidenza Trump è il risultato di una serie di dinamiche sociali ed economiche che si sono sviluppate attraverso più di tre decadi e che hanno trasformato profondamente la società americana, in modo probabilmente irreversibile.
La vittoria di Donald Trump nelle elezioni presidenziali del 2016 è stata determinata dal cambiamento della maggioranza di tre stati “contendibili” che sono passati dal votare il Partito Democratico a votare per quello Repubblicano. Tuttavia, ridurre questo risultato ad un voto di protesta oltre ad essere semplicistico risulta essere completamente sbagliato. La presidenza Trump è il risultato di una serie di dinamiche sociali ed economiche che si sono sviluppate attraverso più di tre decadi e che hanno trasformato profondamente la società americana, in modo probabilmente irreversibile.
L’onda lunga del Reaganismo
La vittoria di Ronald Reagan e le sue due amministrazioni consecutive hanno rappresentato un punto di svolta nella società americana. Dal punto di vista delle politiche economiche il messaggio era semplice quanto efficace, “meno tasse per tutti”. Appare evidente che una riduzione delle tasse per tutti vuol dire un guadagno in termini relativi per i grandi contribuenti ed un vantaggio modesto per la classe media e nessun vantaggio per i poveri. La logica economica che poteva giustificare una tale politica era la seguente, una riduzione delle tasse per i ceti alti avrebbe provocato un incremento delle somme disponibili per gli investimenti, riattivando gli “spiriti animali” e rimettendo in moto il motore neoclassico della crescita economica. La successiva crescita economica scaturente avrebbe investito a “cascata” anche le altre classi sociali. Più investimenti, più posti di lavoro, più ricchezza in generale. Un modello di sviluppo orientato ad una visione iper-liberista (Ravitch, 2017) dove, dal punto di vista sociale, chi non riesce a cogliere le opportunità “del paese delle opportunità” merita di essere povero in senso dispregiativo. La realtà è stata ben diversa. La concezione del c.d. “stato minimo” non solo ha coinvolto la protezione sociale dei meno abbienti, ma ha riguardato ad esempio, la deregolamentazione di vari settori tra i quali quello finanziario, ponendo sostanzialmente le basi per quelle manovre spericolate che hanno causato le recenti crisi finanziarie.
- Details
- Hits: 2971
Chi ha paura di Khalifa Haftar?
Libia, ultima battaglia
di Fulvio Grimaldi
 Biscazzieri e bari
Biscazzieri e bari
Nel paese del milione e mezzo di tossici da gioco d’azzardo, dei 70mila minori dipendenti, dei 19 miliardi spesi per il gioco, dei107 miliardi raccolti, delle 366.399 slotmachine, delle 55.824 videolottery e delle 529 concessioni tra sportive, online, bingo, lotto e lotterie, volete che non ci siano e trionfino i bari? E’ un’intuizione facile. Basta leggere nel giornale di oggi, prima, i dati allarmanti dei biscazzieri e delle loro vittime e, poi, i resoconti allarmatissimi sulle vicende di una Libia a rischio di essere unificata, diononvoglia, addirittura militarmente. Anatema, dopo che, negli 8 anni dalla frantumazione del più ricco e avanzato paese dell’Africa, tanto si era fatto per tenerlo diviso e spartito tra i vari interessi che, dopo averlo cucinato, si apprestavano a divorarlo.
Bari allora, quando ci trascinavano per i capelli alla guerra raccontandoci che Gheddafi bombardava la sua gente (e io ero proprio nel punto dove sarebbero cadute le bombe e non c’era che un tranquillo mercato), che allestiva fosse comuni e tutti vedemmo un cimitero normale con fosse scavate per morti normali, che rimpinzava di viagra i soldati libici perché stuprassero meglio le donne libiche (Save the Children, Ong ripresa da tutti), mentre io incontravo ragazze del liceo che, con i loro compagni, si addestravano alla resistenza. Bari oggi, quando ci terrorizzano con una Libia nel caos per colpa del “feldmaresciallo” militarista, mentre sul caos dai loro padrini militaristi, provocato dal 2011 in qua, ci hanno costruito traffici di petrolio e migranti.
Perché da quando il colonialismo è colonialismo, l’imperialismo è imperialismo, la Nato è Nato e il PNAC è PNAC (Piano per il Nuovo Secolo Americano dei Neocon), se non riesci a farne un boccone, del soggetto da abbattere, ne fai spezzatino. Approfittando del caos che, in mancanza di vittoria, ti sei lasciato dietro e che andrai potenziando.
- Details
- Hits: 1980
A proposito di scuola e pedagogia
Risposta a un documento dell’UdS
Marino Badiale, Università di Torino
Fausto Di Biase, Università di Chieti-Pescara
Paolo Di Remigio, Liceo Classico di Teramo
Lorella Pistocchi, Scuola Media di Villa Vomano
Riceviamo e volentieri pubblichiamo la seguente lettera firmata dai professori Di Biase, Badiale, Di Remigio, Pistocchi. Si tratta di una replica a questo documento UdS.
Nota bene: la Redazione è ben lieta di ospitare il dibattito, e desidera precisare che in generale le lettere e i documenti pubblicati su Roars sono espressione del pensiero dei loro autori e non necessariamente degli orientamenti della redazione.
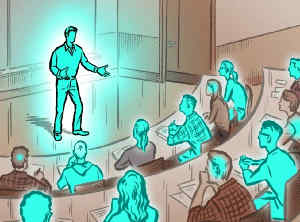 Un paio di anni fa l’Unione degli Studenti ha pubblicato un documento[1] dallo stile rudimentale e contraddittorio nei contenuti, che prima rifiuta la valutazione nella scuola, poi attenua il rifiuto e ne chiede soltanto forme diverse; prima considera la bocciatura crimen exceptum, poi boccia senza istruttoria e senza processo questa società – “Di questa società, noi, (sic) possiamo farne (sic) a meno in quanto (sic) essa serve solo a mantenere lo stato di cose presenti” -; prima esige esattamente il modello di scuola che le riforme dell’ultimo ventennio hanno già attuato, poi lancia contro la scuola attuale, benché esaudisca già ogni sua richiesta, addirittura l’appello alla rivoluzione socialista. A differenza dei rivoluzionari di un tempo che, avendo frequentato la scuola gentiliana, sapevano “esprimersi molto bene oralmente e per iscritto”[2], i loro attuali epigoni, educati da una scuola perfettamente armonizzata con le esigenze sessantottine, si esprimono con difficoltà; in compenso, proprio come è accaduto ai loro precursori, resta loro celato che proprio là dove si credono più rivoluzionari non fanno che obbedire ai più profondi imperativi dell’ideologia neoliberale.
Un paio di anni fa l’Unione degli Studenti ha pubblicato un documento[1] dallo stile rudimentale e contraddittorio nei contenuti, che prima rifiuta la valutazione nella scuola, poi attenua il rifiuto e ne chiede soltanto forme diverse; prima considera la bocciatura crimen exceptum, poi boccia senza istruttoria e senza processo questa società – “Di questa società, noi, (sic) possiamo farne (sic) a meno in quanto (sic) essa serve solo a mantenere lo stato di cose presenti” -; prima esige esattamente il modello di scuola che le riforme dell’ultimo ventennio hanno già attuato, poi lancia contro la scuola attuale, benché esaudisca già ogni sua richiesta, addirittura l’appello alla rivoluzione socialista. A differenza dei rivoluzionari di un tempo che, avendo frequentato la scuola gentiliana, sapevano “esprimersi molto bene oralmente e per iscritto”[2], i loro attuali epigoni, educati da una scuola perfettamente armonizzata con le esigenze sessantottine, si esprimono con difficoltà; in compenso, proprio come è accaduto ai loro precursori, resta loro celato che proprio là dove si credono più rivoluzionari non fanno che obbedire ai più profondi imperativi dell’ideologia neoliberale.
Veniamo innanzitutto al tema della bocciatura, che tanto indigna gli studenti estensori del documento. Se se ne continua a parlare dopo che è stata praticamente abolita in gran parte delle scuole, ciò accade perché in questo tema l’antipedagogia neoliberale ha trovato, più che un suo punto di forza, un punto debole della vecchia pedagogia. La bocciatura come problema perturbante è un’eredità della scuola gentiliana.
- Details
- Hits: 2364
La nuova edizione spagnola di «Genealogia della politica»
Gerardo Muñoz intervista Carlo Galli
Carlo Galli: Genealogía de la política. Carl Schmitt y la crisis del pensamiento político moderno, UNIPE Editorial Universitaria, 2018
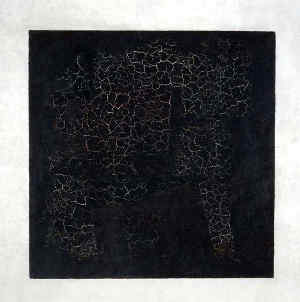 Professor Galli, the Spanish edition Genealogía de la política (Buenos Aires, unipe, 2018), a classic of contemporary political thought, has just been realized in Argentina after twenty years. We should not forget that Argentina has always been a fruitful territory for the reception of Carl Schmitt’s work. Perhaps my first question is commonplace but necessary: how do you expect readers in Spanish to read your classic study?
Professor Galli, the Spanish edition Genealogía de la política (Buenos Aires, unipe, 2018), a classic of contemporary political thought, has just been realized in Argentina after twenty years. We should not forget that Argentina has always been a fruitful territory for the reception of Carl Schmitt’s work. Perhaps my first question is commonplace but necessary: how do you expect readers in Spanish to read your classic study?
Come ci ha dimostrato il compianto Jorge Dotti, la recezione di Schmitt in Argentina è stata imponente e pervasiva, e si è intrecciata con la riflessione filosofica, giuridica e politica sullo Stato e sul suo destino. Ho fiducia che il mio libro, grazie alla traduzione spagnola, possa interessare gli specialisti di Carl Schmitt – giovani e maturi – che sono numerosi e agguerriti, non solo in Argentina ma anche in Europa: dopo tutto, la Spagna stessa ha un lungo e fecondo rapporto intellettuale con Schmitt, che, come ci ha mostrato da ultimo Miguel Saralegui, può anche esser definito «pensatore spagnolo».
This edition comes out in a timely moment, that is, in the wake of the centenary of the Weimar Republic (1919-2019); a moment that Weber already in 1919 referred as a point of entry into a ‘polar night‘. Does Schmitt’s confrontation in the Weimar ‘moment’ still speak to our present?
Schmitt è stato il più grande interprete della Costituzione di Weimar, in un’epoca in cui non mancavano certo i grandissimi costituzionalisti. La sua Dottrina della costituzione è una diagnosi geniale della situazione storica concreta in cui i concetti politici della modernità si trovano a operare. Ed è stato anche il più acuto interprete (nel Custode della Costituzione e in Legalità e legittimità) della rovina di Weimar, causata da uno sfasamento gigantesco fra spirito e strumenti del compromesso democratico weimariano, da una parte, e, dall’altra, la polarizzazione radicalissima in cui la crisi economica aveva gettato il popolo e il sistema politico tedesco. Una democrazia senza baricentro politico funzionante, senza capacità di analizzare le proprie dinamiche e di reagire attivamente, è alla mercé di ogni crisi e di ogni minaccia.
- Details
- Hits: 1890
“Potere digitale” di Gabriele Giacomini
di Diego Ceccobelli
Recensione a: Gabriele Giacomini, Potere Digitale. Come internet sta cambiando la sfera pubblica e la democrazia, Meltemi Editore, Milano 2018, pp. 353, 24 euro (scheda libro)
 L’incontro tra internet e democrazia ha immediatamente stimolato una corposa produzione scientifica volta a carpirne i principali tratti, processi ed effetti concreti, così come le principali tensioni e conflitti. Sono moltissimi gli approcci scientifici, gli ambiti di applicazione e i disegni di ricerca che hanno e stanno tuttora investigando gli esiti di questo incontro. Tra i più recenti, l’ultimo libro di Gabriele Giacomini – Potere Digitale. Come internet sta cambiando la sfera pubblica e la democrazia – merita sicuramente una menzione.
L’incontro tra internet e democrazia ha immediatamente stimolato una corposa produzione scientifica volta a carpirne i principali tratti, processi ed effetti concreti, così come le principali tensioni e conflitti. Sono moltissimi gli approcci scientifici, gli ambiti di applicazione e i disegni di ricerca che hanno e stanno tuttora investigando gli esiti di questo incontro. Tra i più recenti, l’ultimo libro di Gabriele Giacomini – Potere Digitale. Come internet sta cambiando la sfera pubblica e la democrazia – merita sicuramente una menzione.
In questo volume, Giacomini si concentra sul rapporto tra democrazia e tecnologie digitali della comunicazione e lo fa in maniera molto innovativa, scientificamente accurata e compiuta. Il suo non è un libro per nulla banale, né una copia o un semplice riassunto di quanto già presente nella letteratura. Piuttosto, questo suo ultimo sforzo scientifico apporta un importante contributo alla nostra conoscenza del modo in cui internet sta co-rimodellando alle fondamenta i processi democratici, la formazione e costruzione dell’opinione pubblica, passando infine per le potenziali soluzioni proposte dagli studiosi e dagli attori politici per ovviare alle potenziali storture indotte dal rapporto tra tecnologie digitali e configurazioni profonde del potere.
Il principale punto di forza di questo volume è forse nella sua metodologia di ricerca. Il contributo di Giacomini prende infatti le mosse dalla realizzazione e analisi di 11 interviste ad esperti di 3 paesi differenti, i quali si occupano del rapporto tra internet e democrazia all’interno di differenti settori scientifico-disciplinari, come la scienza politica, la filosofia politica e la sociologia dei media. A partire da queste interviste, Giacomini struttura il suo ragionamento seguendo varie direttrici tematiche, spaziando da concetti quali neointermediazione, paradosso del pluralismo, “incastellamento” della sfera pubblica e democrazia dialogica imperfetta (Giacomini 2016).
- Details
- Hits: 1845
Le radici di una disputa: ancora su antropocene e/o capitalocene
di Giuliano Spagnul
 Antropocene o capitalocene è apparentemente una domanda che ricalca vecchie e classiche dispute sull’apoliticità o meno di determinate branche del sapere umano. È la scienza neutrale a qualsivoglia ideologia?[1] Appunto, vecchie dispute. Oggi sappiamo[2] che sapere e potere sono indissolubilmente legati. E allora sostituendo il termine antropocene con capitalocene possiamo, probabilmente, evitare lo spettro di un qualsivoglia risorgente ‘neutralismo’. Ma se capitalocene esprime, senza equivoci di sorta, una ben definita visione politica riguardo le motivazioni che certificano il passaggio da un’era geologica ad un’altra, per contro questa stessa visione ha il difetto di oscurare tutta una serie di punti di vista altrettanto politici ma di differente prospettiva.
Antropocene o capitalocene è apparentemente una domanda che ricalca vecchie e classiche dispute sull’apoliticità o meno di determinate branche del sapere umano. È la scienza neutrale a qualsivoglia ideologia?[1] Appunto, vecchie dispute. Oggi sappiamo[2] che sapere e potere sono indissolubilmente legati. E allora sostituendo il termine antropocene con capitalocene possiamo, probabilmente, evitare lo spettro di un qualsivoglia risorgente ‘neutralismo’. Ma se capitalocene esprime, senza equivoci di sorta, una ben definita visione politica riguardo le motivazioni che certificano il passaggio da un’era geologica ad un’altra, per contro questa stessa visione ha il difetto di oscurare tutta una serie di punti di vista altrettanto politici ma di differente prospettiva.
Ecco così che, in questo contesto, abbiamo Isabelle Stengers come Donna Haraway, per fare qualche esempio, che si sottraggono sia “alla normativa dell’Antropocene che vede in Homo Sapiens (nozione su cui, peraltro, si iscrivono stratificazioni di genere e razziali)[3] la causa e, simultaneamente, il rimedio alla catastrofe ecologica” sia “all’idea sostenuta tra gli altri da Toni Negri, che la crisi climatica è questione subordinata alle politiche industriali, e affrontabile solo sulla base della critica ad esse”[4].
È così che chi si oppone alla logica che vuole l’odierna crisi come l’inevitabile prezzo da pagare per accedere a un superiore stadio dell’evoluzione umana, quell’inevitabile progresso di una natura umana costituitasi al di fuori del dato di natura, si ritrova in due differenti, e forse opposte, prospettive; radicalmente antagoniste entrambe al pensiero globalmente dominante ma da due punti affatto diversi.
L’abbattimento del sistema capitalistico e la costruzione di un nuovo soggetto rivoluzionario da una parte; l’urgenza del chiedersi ora ‘come vivere altrimenti’ e la conseguente produzione di una soggettività differente dall’altra.
- Details
- Hits: 2827
Banca d’Italia e debito pubblico: un matrimonio che non s’ha da fare
di coniarerivolta
 La Banca d’Italia ha recentemente comunicato che trasferirà al Tesoro circa 6 miliardi di euro derivanti dai suoi utili maturati nel 2018. In un periodo caratterizzato da una cronica scarsità di fondi pubblici, con i governi in perenne affanno nel trovare le risorse e far quadrare i conti, è davvero curioso che questa notizia sia passata in sordina: per una volta che i soldi cadono dal cielo – perché non c’è alcun italiano che abbia dovuto sborsarli, quei 6 miliardi, che provengono freschi freschi dal conio della banca centrale – nessuno sembra volersene occupare. Nemmeno un Cottarelli di turno che si prenda la briga di spiegarci bene da dove arrivino queste risorse aggiuntive disponibili per la realizzazione di scuole, ospedali, infrastrutture. Eppure, benché relativamente banale dal punto di vista tecnico, la questione, come vedremo, è carica di conseguenze politiche.
La Banca d’Italia ha recentemente comunicato che trasferirà al Tesoro circa 6 miliardi di euro derivanti dai suoi utili maturati nel 2018. In un periodo caratterizzato da una cronica scarsità di fondi pubblici, con i governi in perenne affanno nel trovare le risorse e far quadrare i conti, è davvero curioso che questa notizia sia passata in sordina: per una volta che i soldi cadono dal cielo – perché non c’è alcun italiano che abbia dovuto sborsarli, quei 6 miliardi, che provengono freschi freschi dal conio della banca centrale – nessuno sembra volersene occupare. Nemmeno un Cottarelli di turno che si prenda la briga di spiegarci bene da dove arrivino queste risorse aggiuntive disponibili per la realizzazione di scuole, ospedali, infrastrutture. Eppure, benché relativamente banale dal punto di vista tecnico, la questione, come vedremo, è carica di conseguenze politiche.
Indebitarsi costa. Lo Stato si indebita emettendo titoli del debito pubblico (principalmente Buoni del Tesoro Poliennali, BTP) che fruttano ai sottoscrittori (ossia i detentori di quei titoli) un certo tasso di interesse: quel tasso è il costo del debito. Se ci indebitiamo per 300 miliardi di euro ad un tasso del 2%, dovremo pagare ai nostri creditori 6 miliardi di euro ogni anno per il servizio del debito. Considerato che l’Italia ha un debito pubblico di circa 2.300 miliardi di euro, possiamo capire subito per quale ragione ogni anno lo Stato è costretto a pagare circa 65 miliardi di euro di interessi su quel debito. Per cogliere appieno l’ordine di grandezza, è sufficiente riflettere sul fatto che provvedimenti quali il Reddito di Cittadinanza e Quota 100 – le due principali misure economiche varate da questo governo che tanto hanno scandalizzato i puristi del pareggio del bilancio – hanno avuto un costo complessivo per il 2019 di circa 15 miliardi di euro, meno di un quarto delle risorse pagate dallo Stato ai suoi creditori.
- Details
- Hits: 3279
Serbia: vittime, carnefici e loro vivandiere
di Fulvio Grimaldi
Parla il ministro degli Esteri di Milosevic in margine a un convegno a Firenze
 Una Serbia che non muore
Una Serbia che non muore
Zivadin Jovanovic ha 80 anni, ne dimostra venti di meno, da viceministro degli Esteri fino al 1998 e poi ministro fino alla caduta del governo nel 2000, è stato protagonista e testimone serbo, accanto a Slobodan Milosevic, dell’intera vicenda jugoslava e balcanica. Oggi è il protagonista della custodia, rivendicazione e propagazione della memoria di quanto fatto alla Serbia dalla Nato. Contro le turbe di occultatori e mentitori, è anche il combattente della verità sui Balcani e sulla Serbia di oggi e sui complotti che l’Occidente insiste a tessere a danno di sovranità, integrità e autodeterminazione della Serbia. Alto, snello, dritto e determinato, come uno di quegli abeti rossi che nel Sud Tirolo svettano verso la luce del sole, ha appena organizzato, nel XX dell’aggressione Nato e nel LXX della fondazione dell’Alleanza Militare Atlantica, l’ennesimo convegno internazionale del Forum di Belgrado per un Mondo di Uguali, da lui presieduto e al quale ho avuto il privilegio di partecipare. Ve ne ho riferito in www.fulviogrimaldicontroblog.info: Convegno internazionale a vent’anni dall’aggressione - “DIMENTICARE? PERDONARE? MAI !” Inviato sotto le bombe, testimone di oggi.
Ci siamo trovati fianco a fianco, in amicizia e causa comune, grazie al modesto contributo che ho potuto dare da responsabile del “Comitato Ramsey Clark per la Jugoslavia” e poi da portavoce, insieme a Enrico Vigna, del “Comitato Milosevic”, che si batteva per la liberazione del Presidente della Federazione Jugoslava e della Repubblica Serba, e per la demistificazione delle menzogne che ne volevano giustificare l’arresto e il processo da parte di un tribunale-farsa.
Le trombe degli eserciti
Jovanovic mi ha concesso l’intervista sull’oggi dei Balcani, sottoposto a nuove minacce da parte degli stessi criminali di ieri e di sempre. La leggerete più avanti. Prima, mi vorrei soffermare brevemente sul contributo che alla tragedia serba hanno fornito quelli che chiamerei “vivandiere”, o “corifei”, dei carnefici.
- Details
- Hits: 2425
Disoccupazione e altri spettri tecnologici
di Valerio Pellegrini
Intelligenza artificiale: La forza-lavoro androide è la protagonista della serie televisiva britannica Humans
 L’umanità è sotto attacco. Nella serie britannica Humans (due stagioni e una terza all’orizzonte), ideata da Sam Vincent e Jonathan Brackley, c’è un gruppo di robot atipici che cerca un’esistenza piena al di fuori degli schemi imposti dai creatori; Humans è stata tratta una precedente serie tv svedese, Real Humans (2012-2014), ideata da Lars Lundström. Il contesto è una società in cui la disponibilità di forza-lavoro androide (i synth) diventa un dato di fatto con notevoli conseguenze. L’attualità della serie deriva dalla vicinanza al mondo dei consumi reali, ai settori trainanti del mercato tecnologico odierno: domotica, assistenti a interfacce vocali, software e servizi basati su algoritmi predittivi, smartphone sempre più smart, sensori ovunque e l’internet delle cose che parlano tra loro senza disturbare gli umani. Ma l’incontro tra robot e umani oggi sembra davvero dietro l’angolo e non è più solo uno scenario narrativo. L’immaginario collettivo influenza il marketing così come il marketing influenza il design degli artefatti industriali. Tecnica e narrazione finiscono con l’associarsi non solo per rappresentare ma anche per creare. Si prenda ad esempio quella clamorosa convergenza tra fantascienza ed elettronica di consumo che è l’automobile a guida autonoma (cfr. Wikipedia): di “automobili fantasma” (cfr. Lafrance, 2016) si comincia a parlare negli anni Venti del secolo scorso; oggi appare evidente come la nostra percezione in materia si stia spostando lentamente ma inesorabilmente dalla finzione alla realtà. Categorie tecnico-economiche che diventano forme dell’immaginario. E viceversa. Allora se, con Erik Davis, possiamo dire che tecnologia e immaginario si riflettono e alimentano reciprocamente (cfr. Davis, 2001) la convivenza conflittuale tra synthe umani è l’ennesima mappa fantascientifica utile a mostrarci i punti in cui il mostro di Frankenstein potrebbe liberarsi generando una nuova umanità con nuovi patti sociali e nuove forme di convivenza civile. Bene patrimoniale da preservare o minaccia per la forza lavoro umana? E, ancora più in profondità sul versante antropologico, cosa implica il fatto di affidare mansioni sempre più importanti alle intelligenze artificiali?
L’umanità è sotto attacco. Nella serie britannica Humans (due stagioni e una terza all’orizzonte), ideata da Sam Vincent e Jonathan Brackley, c’è un gruppo di robot atipici che cerca un’esistenza piena al di fuori degli schemi imposti dai creatori; Humans è stata tratta una precedente serie tv svedese, Real Humans (2012-2014), ideata da Lars Lundström. Il contesto è una società in cui la disponibilità di forza-lavoro androide (i synth) diventa un dato di fatto con notevoli conseguenze. L’attualità della serie deriva dalla vicinanza al mondo dei consumi reali, ai settori trainanti del mercato tecnologico odierno: domotica, assistenti a interfacce vocali, software e servizi basati su algoritmi predittivi, smartphone sempre più smart, sensori ovunque e l’internet delle cose che parlano tra loro senza disturbare gli umani. Ma l’incontro tra robot e umani oggi sembra davvero dietro l’angolo e non è più solo uno scenario narrativo. L’immaginario collettivo influenza il marketing così come il marketing influenza il design degli artefatti industriali. Tecnica e narrazione finiscono con l’associarsi non solo per rappresentare ma anche per creare. Si prenda ad esempio quella clamorosa convergenza tra fantascienza ed elettronica di consumo che è l’automobile a guida autonoma (cfr. Wikipedia): di “automobili fantasma” (cfr. Lafrance, 2016) si comincia a parlare negli anni Venti del secolo scorso; oggi appare evidente come la nostra percezione in materia si stia spostando lentamente ma inesorabilmente dalla finzione alla realtà. Categorie tecnico-economiche che diventano forme dell’immaginario. E viceversa. Allora se, con Erik Davis, possiamo dire che tecnologia e immaginario si riflettono e alimentano reciprocamente (cfr. Davis, 2001) la convivenza conflittuale tra synthe umani è l’ennesima mappa fantascientifica utile a mostrarci i punti in cui il mostro di Frankenstein potrebbe liberarsi generando una nuova umanità con nuovi patti sociali e nuove forme di convivenza civile. Bene patrimoniale da preservare o minaccia per la forza lavoro umana? E, ancora più in profondità sul versante antropologico, cosa implica il fatto di affidare mansioni sempre più importanti alle intelligenze artificiali?
- Details
- Hits: 2513
La crisi economica e le banche centrali
di Eric Toussaint
 Gli elementi di una nuova crisi finanziaria internazionale sono tutti presenti; non si sa quando essa scoppierà ma quando accadrà il suo effetto su tutto il pianeta sarà importante.
Gli elementi di una nuova crisi finanziaria internazionale sono tutti presenti; non si sa quando essa scoppierà ma quando accadrà il suo effetto su tutto il pianeta sarà importante.
I principali fattori di crisi sono da una parte l’aumento ingente dei debiti privati delle imprese, dall’altra la bolla speculativa sui prezzi degli attivi finanziari: borse valori, prezzi dei titoli del debito, e, in certi paesi (Stati Uniti, Cina …), di nuovo il settore immobiliare. I due fattori sono strettamente interconnessi. Anche le imprese che hanno un’enorme liquidità a loro disposizione come Apple si indebitano massicciamente perché approfittano dei bassi tassi di interesse per prestare ad altre il denaro che esse prendono a prestito. Apple e numerose altre imprese prendono a prestito per prestare a loro volta e non per investire nella produzione. Apple prende a prestito anche per riacquistare le proprie azioni in borsa. Ho spiegato questo in un articolo intitolato «» , pubblicato il 9 novembre del 1917.
Banche centrali e bolla in arrivo
Le bolle speculative ora citate sono il risultato delle politiche condotte dalle grandi banche centrali (Federal Rèserve degli Stati Uniti, BCE7, Banca d’Inghilterra, da 10 anni, e dalla Banca del Giappone dallo scoppio della bolla immobiliare negli anni 1990) che hanno iniettato migliaia di miliardi di dollari, euro, sterline, yen nelle banche private per mantenerle a galla. Queste politiche sono state chiamate Quantitative easing o allentamento monetario quantitativo. I mezzi finanziari che le banche centrali hanno distribuito a profusione non sono stati utilizzati dalle banche e dalle grandi imprese capitaliste degli altri settori per l’investimento produttivo. Essi sono serviti a acquistare attivi finanziari: azioni di borsa, obbligazioni di debiti delle imprese, titoli di Stato sovrani, prodotti strutturati e derivati… Questo ha generato una bolla speculativa sul mercato borsistico, sul mercato obbligazionario (vale a dire le obbligazioni dei debiti) e, in alcuni paesi, nel settore immobiliare. Tutte le grandi imprese sono sovra-indebitate.
- Details
- Hits: 8115
La Cina è capitalista?
Intervista a Rémy Herrera
 “La Cina è capitalista?”. Questo il titolo del nuovo di libro di Rémy Herrera (economista marxista francese, ricercatore al CNRS e alla Sorbona, Parigi) e Zhiming Long (economista marxista cinese della Scuola di Marxismo all’Università Tsinghua, Pechino), uscito a Marzo per le Éditions Critiques. Gli autori intendono smentire stereotipi e incomprensioni sulla Repubblica popolare cinese, ripercorrendo la storia dello sviluppo economico del paese dal 1950 a oggi. L’intervista che trascriviamo è stata realizzata da Le Média, un nuovo media alternativo legato alla sinistra francese.
“La Cina è capitalista?”. Questo il titolo del nuovo di libro di Rémy Herrera (economista marxista francese, ricercatore al CNRS e alla Sorbona, Parigi) e Zhiming Long (economista marxista cinese della Scuola di Marxismo all’Università Tsinghua, Pechino), uscito a Marzo per le Éditions Critiques. Gli autori intendono smentire stereotipi e incomprensioni sulla Repubblica popolare cinese, ripercorrendo la storia dello sviluppo economico del paese dal 1950 a oggi. L’intervista che trascriviamo è stata realizzata da Le Média, un nuovo media alternativo legato alla sinistra francese.
* * * *
Il vostro è un libro controcorrente. Presenta un punto di vista piuttosto raro in Francia, che merita di essere segnalato e discusso. Innanzi tutto, come fate notare, quando si parla dell’economia cinese spesso lo si fa attraverso un prisma occidentale, usando dati prodotti da occidentali: secondo voi, ciò falsifica la visione che noi abbiamo del successo cinese.
Esattamente, ed è un punto fondamentale. Tutti infatti hanno un’opinione sulla Cina, ma che rischia di non essere necessariamente ben fondata. Ciò è dovuto, secondo noi, alle difficoltà rappresentate dalla lingua e dalla lontananza geografica. Difficoltà che rendono in qualche modo inaccessibili gran parte dei dibattiti interni alla Cina e che obbligano passare attraverso questo prisma occidentale. Uno sguardo esterno che occupa in pratica la totalità della nostra percezione della Cina. E questo è un problema, esso è dovuto innanzi tutto a una difficoltà di accesso ai dati, ma non certo perché le statistiche cinesi siano nascoste – al contrario esistono, sono molto numerose e diffuse. Tuttavia sono nella maggioranza dei casi in cinese, cosa che le rende di difficile utilizzo. Queste statistiche sono, contrariamente all’opinione comune, abbastanza serie, ben costruite e relativamente affidabili e questo da molto tempo – grazie all’Ufficio nazionale di statistica che esiste dal 1952. Tuttavia possono risultare incomplete, per noi che avevamo bisogno di un certo numero di indicatori che non esistevano oppure, laddove esistevano, non erano esenti da imperfezioni.
- Details
- Hits: 2024
7 aprile
di Girolamo De Michele
Una data che segna l’operazione giudiziaria e politica con cui vengono regolati i conti con pezzi importanti dei movimenti degli anni Settanta. Accusati di “insurrezione armata contro i poteri dello stato”
 Il 7 aprile 1979 decine di militanti (che diventeranno centinaia nel corso dell’inchiesta) dell’area dell’Autonomia furono arrestati, in esecuzione di un duplice mandato di cattura emesso dai giudici Pietro Calogero e Achille Gallucci delle procure di Padova e Roma, con l’accusa di associazione sovversiva, banda armata e partecipazione a diciannove omicidi, fra i quali spiccava quello di Aldo Moro. L’accusa era di aver costituito una organizzazione segreta che dirigeva dietro le quinte ogni possibile formazione armata: come scriverà l’Unità due giorni dopo, «un unico filo, insomma, percorrerebbe tutte le formazioni terroristiche, dalla nebulosa del “terrorismo diffuso” alla perfezione militare delle Br. La mano che questo filo tira e manovra sarebbe quella dell’Autonomia», organizzazione nata dopo lo scioglimento di Potere Operaio e poi cresciuta nel corso degli anni Settanta, ovvero quella di Toni Negri, per il quale il giudice Calogero ricorre, prima volta nella storia dell’Italia repubblicana all’articolo 284 del codice penale «per aver promosso una insurrezione armata contro i poteri dello Stato e commesso fatti diretti a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato».
Il 7 aprile 1979 decine di militanti (che diventeranno centinaia nel corso dell’inchiesta) dell’area dell’Autonomia furono arrestati, in esecuzione di un duplice mandato di cattura emesso dai giudici Pietro Calogero e Achille Gallucci delle procure di Padova e Roma, con l’accusa di associazione sovversiva, banda armata e partecipazione a diciannove omicidi, fra i quali spiccava quello di Aldo Moro. L’accusa era di aver costituito una organizzazione segreta che dirigeva dietro le quinte ogni possibile formazione armata: come scriverà l’Unità due giorni dopo, «un unico filo, insomma, percorrerebbe tutte le formazioni terroristiche, dalla nebulosa del “terrorismo diffuso” alla perfezione militare delle Br. La mano che questo filo tira e manovra sarebbe quella dell’Autonomia», organizzazione nata dopo lo scioglimento di Potere Operaio e poi cresciuta nel corso degli anni Settanta, ovvero quella di Toni Negri, per il quale il giudice Calogero ricorre, prima volta nella storia dell’Italia repubblicana all’articolo 284 del codice penale «per aver promosso una insurrezione armata contro i poteri dello Stato e commesso fatti diretti a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato».
L’operazione 7 aprile svolge un ruolo nevralgico nello scontro sociale che si è consumato negli anni Settanta, un decennio eccezionale dal punto di vista delle lotte sociali e del protagonismo operaio. La sostenne un battage giornalistico impressionante. Nel giro di pochi giorni l’Italia apprendeva l’esistenza di una sorta di Spectre nostrana, la cui esistenza si affermava con certezza essere comprovata da solidi elementi e testimoni inconfutabili: fra questi un uomo del generale Dalla Chiesa e un brigatista pentito padovano. In particolare, era l’Unità a distinguersi nel distillare, giorno per giorno, le rivelazioni provenienti dalla procura di Padova: Negri era ideatore dei primi sequestri di persona effettuati dalle Br, membro della direzione Br sin dalla metà del ’73, il telefonista che comunicava con la famiglia Moro durante il sequestro del leader Dc, ma anche, con estrema versatilità, l’uomo che «insegnava la tecnica di costruzione delle bottiglie molotov».
- Details
- Hits: 3057
Una guerra civile ancora invisibile
di Sandro Moiso
Marco Revelli, La politica senza politica. Perché la crisi ha fatto entrare il populismo nelle nostre vite, Einaudi, Torino 2019, pp. 224, 14,00 euro

Revelli, docente di Scienze della Politica presso l’Università del Piemonte orientale, costituisce una delle poche voci superstiti e menti ancora lucide dell’esperienza torinese di Lotta Continua e la parte migliore di quell’ormai lontana stagione politica si riflette nell’attenzione con cui l’attuale insorgenza di movimenti anomali e potenzialmente fascisti viene esaminata non a partire da principi assoluti e universali, ma dalle reali cause economiche e sociali che li hanno determinati. Così come, ad esempio, quel gruppo politico, scomparso a Rimini nel 1976, aveva cercato già di fare nei confronti del malessere del Meridione d’Italia a cavallo tra anni Sessanta e Settanta, da quello indirettamente manifestato dal sottoproletariato napoletano fino ai fatti di Reggio Calabria e ai boia chi molla che ne avevano preso in mano le redini.
- Details
- Hits: 2228

Le asimmetrie della zona euro
di Sergio Farris
Relazione presentata al convegno UE: riforma o uscita, tenuto ad Udine 30 marzo 2019 su invito del gruppo locale di Senso comune
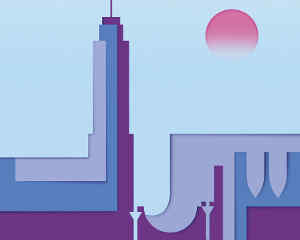 1. Ci vuole più Europa e meno Europa?
1. Ci vuole più Europa e meno Europa?
Serve meno Europa.
Il processo di aggregazione dei paesi europei è il portato dell'ideologia del libero mercato, condotta ai suoi estremi. L'unificazione monetaria rappresenta l'apice di tale processo.
La storia che ha condotto all'euro è una storia tutta incentrata su tentativi di ricostituire un accordo di cambio valutario dopo la cessazione del sistema di Bretton Woods, avvenuta nel 1971. Risiede alla sua base il postulato che - innanzitutto - l'integrazione dei mercati incentivi gli scambi internazionali e rechi vantaggi generalizzati; oltreciò, tale risultato si otterrebbe tramite l'abolizione di fattori di impedimento o di incertezza per gli scambi commerciali e la circolazione finanziaria.
L'euro, in particolare, è il risultato di diverse esigenze, condensate in un compromesso: da un lato la Germania - da sempre titubante per via della propria concentrazione sul pericolo dell'inflazione -, la quale ha acconsentito all'istituzione della moneta unica dopo varie proposte avanzate nei decenni, da parte francese. Pare che, alla fine, la Germania abbia acconsentito all'istituzione della moneta unica con l'occhio rivolto alla possibilità di difendersi dalle svalutazioni competitive dei vicini e, si dice, anche per ottenere il via libera alla riunificazione. Dall'altro lato la Francia, con le sue mire rivolte a contenere il potere del marco e altri paesi - come l'Italia - preoccupati dell'inflazione, dovuta anche alle svalutazioni e alle fluttuazioni dei tassi di cambio (oltre che mossa dalla richiesta padronale di frenare la dinamica salariale).
Ne è emerso un modello fondato sull'esasperazione della concorrenza e sull'ossessione per l'inflazione (i sistemi di cambio valutario fisso hanno infatti - quale costante giustificazione, il timore per l'inflazione e per i presunti danni che l'incertezza derivante dalle oscillazioni del cambio arrecherebbe alle relazioni di mercato).
- Details
- Hits: 1793
Critica, occasione e disciplina
Appunti sparsi sull’oggi
di Marco Gatto
Con un sentito ringraziamento all’autore, pubblichiamo di seguito un estratto del libro di Marco Gatto, Resistenze dialettiche. Saggi di teoria della critica e della cultura, Roma, manifestolibri, 2018
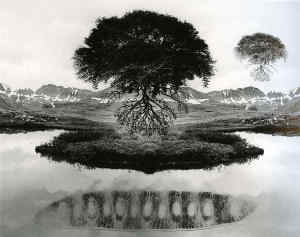 1.
1.
Introducendo Minima moralia (1951), Renato Solmi così si esprimeva sul carattere solo apparentemente frammentistico della raccolta di Adorno: «i trapassi bruschi, e a prima vista sconcertanti, dall’infinitamente grande all’infinitamente piccolo, e viceversa», non sono la manifestazione di «un linguaggio metaforico e suggestivo», non hanno nulla di «arbitrario e di fantastico», bensì rappresentano «le scorciatoie della dialettica». La rinuncia al sistema o all’esibita unitarietà, «mentre corrisponde alla dispersione apparente dell’oggetto, serve, nello stesso tempo, a un’intenzione precisa»: «l’analisi disimpegnata», nel momento in cui «confuta la pretesa del particolare a valere come essenza, si ritorce contro il cattivo universale; mentre l’esposizione sistematica finirebbe per dare ragione al sistema». Il meccanismo hegeliano della critica all’assolutizzazione assumeva, nelle mani del filosofo più influente della Scuola di Francoforte, un’ulteriore funzione demistificatoria: mostrava il carattere falso della realtà o, per dirla in termini schiettamente adorniani, della “vita vera”, cautelando il discorso intellettuale nei riguardi di qualsivoglia diretta presa di posizione. Di fronte allo strapotere dell’americanizzazione, capace di affossare i tradizionali modelli interpretativi di origine borghese e di disinnescare la persistenza dei grandi orientamenti di senso, la critica ha pertanto l’obbligo di una permanente autoverifica, in larga parte consistente nel sorvegliare la propria tendenza a porsi come falsa universalità o come opposizione passibile di integrazione in un sistema che ha dimostrato d’essere, nella sua coerenza sistematica, più ampio e agguerrito. «In questo senso – insiste Solmi –, nel sistema del dominio, l’apparenza è la sede della verità. Ma non appena si ritiene tale, si capovolge nel suo contrario», generando quell’ambivalenza che è costitutiva del pensiero di Adorno, moralista e pessimista intransigente, ma «pronto ad aprirsi alla speranza», seppure irrisolto nel saper convertire «la critica dell’interiorità» in una «critica della prassi», senza che la prima diventi un alibi per il disimpegno e la disillusione.1
- Details
- Hits: 2594
Post-democrazia e fabbrica tecno-capitalista
di Lelio Demichelis
La crisi della democrazia è legata all’egemonia della tecnica nel capitalismo moderno. Solo ri-democratizzando l’impresa e la tecnica sarà possibile uscire dalla crisi politica dei nostri giorni
 La democrazia politica è in crisi. Scriverlo è scrivere niente di nuovo. Ma la relazione di causa-effetto tra capitalismo e crisi della politica e della democrazia nasce non solo dal 2008 o dagli anni ‘70, ma dall’egemonia della tecnica come apparato/sistema tecnico integrato al capitalismo; dall’immaginario collettivo che questo tecno-capitalismo sa produrre; ma soprattutto dal fatto che la forma/norma tecnica (Anders[i]), è in sé e per sé a-democratica/antidemocratica ma tende a divenire forma/norma sociale e oggi anche politica.
La democrazia politica è in crisi. Scriverlo è scrivere niente di nuovo. Ma la relazione di causa-effetto tra capitalismo e crisi della politica e della democrazia nasce non solo dal 2008 o dagli anni ‘70, ma dall’egemonia della tecnica come apparato/sistema tecnico integrato al capitalismo; dall’immaginario collettivo che questo tecno-capitalismo sa produrre; ma soprattutto dal fatto che la forma/norma tecnica (Anders[i]), è in sé e per sé a-democratica/antidemocratica ma tende a divenire forma/norma sociale e oggi anche politica.
Ovvero, il tecno-capitalismo confligge in premessa con la democrazia[ii]. E produce antidemocrazia.
Il populismo e la disruption tecno-capitalista della democrazia
Perché i populismi, fomentando la rabbia popolare contro caste ed élite (ma non contro le vere nuove caste/élite globali, quelle della Silicon Valley[iii]) in realtà sono il proseguimento dell’egemonia tecno-capitalista con altri mezzi, perché tutti i populismi al potere oggi sono neoliberali e insieme tecnici, nel sostenere questo modello di crescita. Perché se non deve esistere la società – obiettivo del neoliberalismo, ormai pienamente raggiunto – può essere invece utile al sistema creare il popolo: molto più attivabile e plasmabile, molto più bisognoso di un pastore o di un Capitano, molto meno riflessivo/responsabile, ma soprattutto funzionale a sostenere l’incessante disruption (il populismo incarnando esso stesso la disruption del demos) richiesta dal sistema.
Uno degli elementi del populismo, uno dei suoi usi politici infatti, è anche quello di ottenere la modernizzazione e di proseguire nella rivoluzione industriale mediante il ricorso alle figure della tradizione e dell’identità[iv], cioè a meccanismi/dispositivi di compensazione emotiva/identitaria utili a ristabilire (in apparenza) un certo equilibrio psichico individuale e sociale.
Page 281 of 612
Gli articoli più letti degli ultimi tre mesi
Carlo Di Mascio: Diritto penale, carcere e marxismo. Ventuno tesi provvisorie
Carlo Lucchesi: Avete capito dove ci stanno portando?
Carlo Rovelli: Una rapina chiamata libertà
Agata Iacono: Cosa spaventa veramente del rapporto di Francesca Albanese
Barbara Spinelli: La “diplomafia” di Trump: i dazi
Domenico Moro: La prospettiva di default del debito USA e l'imperialismo valutario
Sergio Fontegher Bologna: L’assedio alle scuole, ai nostri cervelli
Giorgio Lonardi: Il Mainstream e l’omeopatia dell’orrore
Il Pungolo Rosso: Una notevole dichiarazione delle Brigate Al-Qassam
comidad: Sono gli israeliani a spiegarci come manipolano Trump
Alessandro Volpi: Cosa non torna nella narrazione sulla forza dell’economia statunitense
Leo Essen: Provaci ancora, Stalin!
Alessio Mannino: Contro la “comunità gentile” di Serra: not war, but social war
Sonia Savioli: Cos’è rimasto di umano?
L'eterno "Drang nach Osten" europeo
Gianni Giovannelli: La NATO in guerra
BankTrack - PAX - Profundo: Obbligazioni di guerra a sostegno di Israele
Alessandro Volpi: Come i dazi di Trump mettono a rischio l’Unione europea
Marco Savelli: Padroni del mondo e servitù volontaria
Fulvio Grimaldi: Siria, gli avvoltoi si scannano sui bocconi
Mario Colonna: Il popolo ucraino batte un colpo. Migliaia in piazza contro Zelensky
Enrico Tomaselli: Sulla situazione in Medio Oriente
Gianandrea Gaiani: Il Piano Marshall si fa a guerra finita
Medea Benjamin: Fermiamo il distopico piano “migliorato” di Israele per i campi di concentramento
Gioacchino Toni: Dell’intelligenza artificiale generativa e del mondo in cui si vuole vivere
Fulvio Grimaldi: Ebrei, sionismo, Israele, antisemitismo… Caro Travaglio
Elena Basile: Maschere e simulacri: la politica al suo grado zero
Emiliano Brancaccio: Il neo imperialismo dell’Unione creditrice
Gli articoli più letti dell'ultimo anno
Carlo Di Mascio: Hegel con Pashukanis. Una lettura marxista-leninista
Giovanna Melia: Stalin e le quattro leggi generali della dialettica
Emmanuel Todd: «Non sono filorusso, ma se l’Ucraina perde la guerra a vincere è l’Europa»
Andrea Del Monaco: Landini contro le due destre descritte da Revelli
Riccardo Paccosi: La sconfitta dell'Occidente di Emmanuel Todd
Andrea Zhok: La violenza nella società contemporanea
Carlo Di Mascio: Il soggetto moderno tra Kant e Sacher-Masoch
Jeffrey D. Sachs: Come Stati Uniti e Israele hanno distrutto la Siria (e lo hanno chiamato "pace")
Jeffrey D. Sachs: La geopolitica della pace. Discorso al Parlamento europeo il 19 febbraio 2025
Salvatore Bravo: "Sul compagno Stalin"
Andrea Zhok: "Amiamo la Guerra"
Alessio Mannino: Il Manifesto di Ventotene è una ca***a pazzesca
Eric Gobetti: La storia calpestata, dalle Foibe in poi
S.C.: Adulti nella stanza. Il vero volto dell’Europa
Yanis Varofakis: Il piano economico generale di Donald Trump
Andrea Zhok: "Io non so come fate a dormire..."
Fabrizio Marchi: Gaza. L’oscena ipocrisia del PD
Massimiliano Ay: Smascherare i sionisti che iniziano a sventolare le bandiere palestinesi!
Guido Salerno Aletta: Italia a marcia indietro
Elena Basile: Nuova lettera a Liliana Segre
Alessandro Mariani: Quorum referendario: e se….?
Michelangelo Severgnini: Le nozze tra Meloni ed Erdogan che non piacciono a (quasi) nessuno
Michelangelo Severgnini: La Libia e le narrazioni fiabesche della stampa italiana
E.Bertinato - F. Mazzoli: Aquiloni nella tempesta
Autori Vari: Sul compagno Stalin

Qui è possibile scaricare l'intero volume in formato PDF
A cura di Aldo Zanchetta: Speranza
Tutti i colori del rosso
Michele Castaldo: Occhi di ghiaccio

Qui la premessa e l'indice del volume
A cura di Daniela Danna: Il nuovo volto del patriarcato

Qui il volume in formato PDF
Luca Busca: La scienza negata

Alessandro Barile: Una disciplinata guerra di posizione
Salvatore Bravo: La contraddizione come problema e la filosofia in Mao Tse-tung

Daniela Danna: Covidismo
Alessandra Ciattini: Sul filo rosso del tempo
Davide Miccione: Quando abbiamo smesso di pensare

Franco Romanò, Paolo Di Marco: La dissoluzione dell'economia politica

Qui una anteprima del libro
Giorgio Monestarolo:Ucraina, Europa, mond
Moreno Biagioni: Se vuoi la pace prepara la pace
Andrea Cozzo: La logica della guerra nella Grecia antica

Qui una recensione di Giovanni Di Benedetto