Il pianeta Marx illustrato all’ingrosso: il “fatto” del capitalismo
Cronache marXZiane n. 18
di Giorgio Gattei
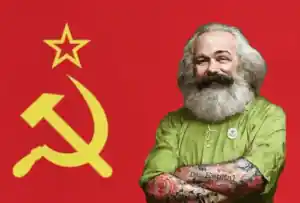 "I fatti hanno la testa dura"
"I fatti hanno la testa dura"
(attribuito a V. I. Lenin)
1. Capitalismo. Riassumo il risultato conseguito nella Cronaca precedente: dato che le ideologie storiche (nella loro varia tipologia religiosa, per cui “ci ha creato Dio”, politica con “lo Stato che ci protegge” e filosofica dove “è l’Idea che ci illumina”) non sono altro che il riflesso nella mente, più o meno adeguato, di un determinato “stato concreto delle cose” (all’inverso di Hegel, per Marx «l’elemento ideale non è altro che l’elemento materiale trasferito e tradotto nel cervello degli uomini» (Il capitale, I, p. 45), è impossibile che quelle ideologie se ne vadano per opera di una critica pur feroce ma soltanto verbale, che sarebbe anch’essa mentale, di quel medesimo “stato delle cose”. Occorre infatti che cambi quest’ultimo nella realtà, così che tutti quei riflessi ideali precedenti si dimostrino inadeguati, al punto da dover essere sostituti da un altro “concreto di pensiero”, ovvero da una diversa ideologia che sia espressione nella mente dei “tempi nuovi”. Qui vale la lezione marxiana (indigeribile agli ideologi) per cui soltanto «cambiando la base economica viene a essere sovvertita più o meno rapidamente tutta l’enorme sovrastruttura… delle forme giuridiche, politiche, religiose, artistiche e filosofiche, in breve ideologiche, in cui gli uomini si rendono coscienti dei loro conflitti e si battono per risolverli» (Prefazione a Per la critica della economia politica, 1859).
Ora un mutamento epocale decisivo dello “stato materiale delle cose” fortunatamente c’è stato nella storia a seguito della scoperta accidentale del continente americano da parte di Cristoforo Colombo nel 1492, che fu un evento fortuito quanti altri mai perché che cosa sarebbe successo se non ci fosse stata quella “terra di mezzo” tra l’Europa e quell’Asia che Colombo, con la sua navigazione atlantica, intendeva raggiungere? Che avrebbe fatto la fine di quei poveri fratelli Vivaldi che, usciti dallo stretto di Gibilterra nel 1291 (ma con delle galee, non con le caravelle!), scomparvero in mare lasciando dietro di sé appena l’allusione poetica di Dante Alighieri nella Divina Commedia al «folle volo» di Ulisse, la cui nave affondò nell’oceano quando «dalla nova terra un turbo nacque che tre volte fé girar con tutte l’acque / a la quarta levar la poppa in suso / e la prora ire in giù…/ infin che ‘l mare fu sopra noi richiuso» (Inferno, canto xxvi).
Siccome però quel Nuovo Mondo nel frammezzo ci stava e Colombo ci era sbattuto contro, da quella scoperta conseguirono tali e tanti effetti economici e sociali (repertoriati da Marx nel capitolo del Capitale sulla cosiddetta “accumulazione originaria” che «non è il risultato bensì il punto di partenza del modo di produzione capitalistico») che avrebbero condotto alla introduzione di una nuova maniera del produrre “a lavoro libero salariato” acquistabile su di un apposito mercato come se fosse una merce qualsiasi, in sostituzione dei precedenti modi di produzione schiavile e servile. Ma dove stava la novità? Certamente non per lo scambio mercantile, che era una pratica economica antichissima che Erodoto nella sua Storia aveva immaginato essere nata da quell’improbabile “commercio silenzioso” in cui gli scambisti nemmeno si incontravano personalmente (cfr. R. Secci, Erodoto (IV, 196): Cartagine e l’oro africano: alcune riflessioni, 2011, in rete), ma mai si era visto che sul mercato, dove pur comparivamo anche «cose delicatissime come femmes folles de leur corps» (Il capitale, p. 117), vi affluissero in massa anche individui pronti a “lavorare per altri” in cambio di una remunerazione purchessia, così che se quelle donne hanno poi potuto essere chiamate da Filippo Turati nel 1919 le “salariate dell’amore”, quegli uomini si potrebbero chiamare per analogia i “salariati senza amore” perché non amati da nessuno (nemmeno da loro stessi), sebbene assolutamente strategici per la produzione e riproduzione dell’umana esistenza nelle condizioni economiche della nostra modernità – e questo è il capitalismo, bellezza, essendo «ciò che dà il carattere all’epoca capitalistica il fatto che la forza lavoro assume anche per lo stesso lavoratore la forma di una merce che gli appartiene, mentre il suo lavoro assume la forma di lavoro salariato» (Il capitale, p. 203).
Eccezionale è stato quindi l’avvento di questa «opera d’arte della storia moderna» (come Marx la denomina) che affida l’energia del produrre non più alla coercizione sull’altro, come nei casi del servo e dello schiavo, bensì alla libera iniziativa di una forza-lavoro motivata dalla sola remunerazione che riceve dal suo “datore di lavoro” (una definizione che comunque a Friedrich Engels non piaceva affatto, dato che a lui mai sarebbe mai «venuto in mente quello strano pasticcio linguistico in cui colui che si fa dare del lavoro da altri contro pagamento in contanti si chiama il datore di lavoro» (Prefazione al Capitale, 1883) invece di “prenditore di lavoro”. Ma tant’è: come nel linguaggio comune esistono parolacce che non sta bene pronunciare, così in economia si dovrebbe evitare di dire “capitalismo” che potrebbe richiamare l’oscenità del “lavoratore salariato”, ma siccome per me vale l’avvertimento di Pietro Aretino nei Ragionamenti (1534, p. 39) che «io te lo ho voluto dire, ed emmesi scordato: parla a la libera, e di’ cu, ca, po e fo, che altrimenti non sarai intesa se non dalla sapienza capranica» (allusione all‘”Almo Collegio dei dotti” fondato a Roma dal cardinale Domenico Capranica nel 1457), allora dirò “capitalismo” e “lavoro salariato” senza alcuna vergogna.
2. Antropocene. Ma se di capitalismo si volesse pur parlare aggirando il lavoro salariato, che cosa mai lo caratterizzerebbe? Gli storici pigri se la cavano rinviando alla presenza del denaro, come se la moneta non ci fosse dall’antichità senza che a nessuno fosse venuto in mente di parlare di “capitalismo”. I più furbi si rifanno invece alla irruzione nel processo di produzione delle “macchine” in sostituzione della fatica dell’uomo (e dell’animale) e ne ripercorrono la storia dalla “macchina a vapore” di fine Settecento («tutto cambiò con il vapore»: C.M. Cipolla, Uomini, tecniche, economie, 1962, p. 46) al “motore elettrico” del Novecento, di cui peraltro non abbiamo ancora esaurito tutte le possibilità. In questo modo la “Rivoluzione Industriale” verrebbe a fare il paio con quella “Rivoluzione agricola” del Neolitico che vide le donne (che erano stanziali perché dovevano allattare i neonati, mentre gli uomini erano mobili e se ne andavano a caccia) accorgersi che a seminare per terra un chicco di grano se ne poteva ottenere una spiga con più chicchi moltiplicando così il grano a disposizione e togliendo dai chicchi prodotti il chicco seminato aprirono la via alla introduzione di quel concetto di Prodotto netto o Sovrappiù, detto in economistese Surplus, che oggi è l’argomento di maggiore interesse (per capirci: per la dinamica di una popolazione vale il numero dei nuovi nati piuttosto che quello dei viventi)). Ma siamo proprio sicuri che tra quelle due Rivoluzioni non ci sia stato niente di significativo? Non c’è forse stata quella invenzione del “libero lavoratore salariato” così decisiva da lasciare una traccia indelebile nelle statistiche della variazione del tasso di crescita medio annuo del PIL pro capite (il Prodotto Lordo diviso per l’ammontare della Popolazione) passata dallo 0,0% dall’anno zero al 1700 d.C. (dato che se mai c’erano dei progressi, essi erano annullati da successive carestie ed epidemie devastanti) allo 0,8% annuo dal 1700 al 2012, il che può sembrare un incremento modesto, ma che risulta «senza pari rispetto alla crescita zero osservata nel corso dei secoli precedenti» (T. Piketty, Il capitale nel XXI secolo, 2014, p. 120)?
Ma siccome di capitalismo non si deve parlare, nell’anno 2000 Paul Crutzen e Eugene Stoermer se ne sono usciti con la proposta di non considerare più il presente come appartenente all’era geologica dell’Olocene perché ormai «siamo entrati nell’Antropocene» che costituisce un «nuovo capitolo della vita e nella storia dell’umanità» (P. Crutzen e E.F. Stoermer, The Anthropocene, 2000) in cui la specie umana, da “ente biologico” sottoposto alle leggi di natura come la flora e la fauna, si è trasformata in “forza geologica” capace di modificare “a propria immagine e somiglianza” l’ambiente circostante. Il “marcatore” più significativo (il “chiodo d’oro” come lo chiamano i geologi) è stato ritrovato nel contenuto di anidride carbonica nell’atmosfera che è cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi 300 anni a seguito di una attività umana sempre più consapevole. L’hanno dimostrato M. Maslin e S. Lewis (Il pianeta umano. Come abbiamo creato l’antropocene, 2018) esaminando il contenuto di CO2 nelle “carote” di ghiaccio estratte in Antartide che attorno all’anno 1610 aveva toccato il minimo a seguito dello sterminio di oltre 50 milioni di indigeni nelle Americhe per le violenze e le malattie portate dai “conquistadores”, con la conseguenza di una «riforestazione dei terreni agricoli in aree talmente estese che la quantità di CO2 nell’atmosfera assorbita dagli alberi raffreddò significativamente l’atmosfera del pianeta». Ma dopo quel il minimo non c’è stato altro che un “riscaldamento climatico” per l’iniziativa di un Vecchio Mondo progressivamente in trasformazione economica e sociale a seguito della venuta dell’oro e dell’argento da quelle Americhe appena scoperte. Infatti, mentre a sinistra dell’Atlantico si sterminavano i nativi, a destra, ovvero in Europa, si subivano gli effetti di una Rivoluzione dei prezzi (l’unica inflazione prodotta nella storia da moneta metallica e non cartacea) con un particolare aumento del prezzo della lana che indusse in Gran Bretagna alle recinzioni agricole (enclosures) per guadagnare con l’allevamento delle pecore espellendo dalle campagne i contadini in esubero che, affluiti in massa nelle città per «viverci pitoccando», provocarono una «legislazione sanguinaria» che li costrinse a cercarsi una occupazione a qualsiasi prezzo (dato che al terzo arresto potevano essere giustiziati) su di un nascente “libero” (ma un po’ coatto no?) mercato del lavoro. Così sarebbe stato questo processo storico ad introdurci nella cosiddetta “era geologica” dell’Antropocene (le macchine sono arrivate poi) e il cui svolgimento che «solo in Inghilterra possiede forme classiche,… ha sfumature diverse nei vari paesi e percorre fasi diverse in successioni diverse e in epoche storiche diverse», dovendo comunque generalizzarsi progressivamente a tutto il mondo. Sarebbe stata quindi la diffusione del “mercato del lavoro libero salariato” a scatenare quella straordinaria crescita esponenziale delle “forze produttive” responsabili del riscaldamento climatico e che Curzio Malaparte vorrebbe attribuire in primis alla genialità degli italiani (ma non riservata soltanto a loro) dato che «l’italiano non ha paura/ della legge di natura/ e talvolta egli corregge/ la natura della legge» (C. Malaparte, Benedetti italiani, 1961 postumo).
3. Mercenariato. Ma come agisce quel “libero lavoratore salariato”? Posto che ci sia qualcuno che è disposto a pagargli un salario, la prima equivalenza di scambio è sicuramente data da:
D (denaro) = W (salario),
ma che cosa viene ceduto al cosiddetto “datore di lavoro”, una denominazione che non piaceva affatto a Friedrich Engels al quale mai sarebbe venuto in mente di chiamare “datore di lavoro” «chi si fa dare del lavoro da altri contro pagamento in contanti» (Prefazione 1883 a Il capitale)? L’impressione immediata è che si sia ceduto direttamente il lavoro, così che l’equivalenza successiva potrebbe risultare:
W (salario) = L (lavoro),
ma questo sarebbe un equivoco madornale perché (come Marx ha spiegato nel Capitale), se mai fosse «venduto sul mercato come merce il lavoro, dovrebbe comunque esistere prima di essere venduto», ma questo non si può dare perché il lavoro si manifesta solo successivamente alla stipula del contratto. E allora? Se il compenso dell’operaio è il prezzo del lavoro che poi svolgerà, «sul mercato delle merci si presenta direttamente al possessore di denaro non il lavoro, ma il lavoratore stesso e ciò che egli vende è allora la sua propria forza-lavoro» (un termine geniale introdotto da Marx e ormai passato nell’uso comune), ossia la sua capacità, attitudine, disposizione a lavorare per altri, così che lo scambio risulterà:
W (salario) = FL (forza-lavoro)
dove la forza-lavoro è «l’insieme delle attitudini fisiche e intellettuali che esistono nella corporeità, ossia nella personalità vivente di un uomo, e che egli mette in movimento ogni volta che produce valori d’uso di qualsiasi genere», non importa che siano beni o servizi, legali o illegali, utili o dannosi. Così il lavoro non è altro che “forza-lavoro in azione”, il cui risultato (quale che sia) sarà di spettanza del datore di lavoro che ha pagato il salario perché si concretizzasse. Certamente servono alcune condizioni istituzionali di contorno affinché quello scambio capitalistico si perfezioni, e cioè che il lavoratore sia libero proprietario della forza-lavoro che vende (niente coercizione, dunque), che le parti contraenti siano giuridicamente equivalenti, ma soprattutto che il venditore ceda la forza-lavoro, «ossia gliela lasci per il consumo, sempre e soltanto transitoriamente per un periodo determinato di tempo e che dunque, mediante l’alienazione di essa, egli non rinunci alla sua proprietà su di essa». Questa precisazione è decisiva e ha il suo più nobile natale nella Filosofia del diritto (1821) di G.W.F. Hegel che Marx doverosamente cita in nota: «delle mie particolari abilità fisiche e intellettuali e delle mie particolari possibilità di attività io posso… alienare ad un altro un uso limitato nel tempo» perché altrimenti «con l’alienazione di tutto il mio tempo concreto in virtù del lavoro e della totalità della mia produzione, io renderei proprietà di un altro ciò che c’è di sostanziale in essi, la mia attività e realtà universali, la mia personalità», perché allora mi ridurrei ad essere uno schiavo, sia pure volontario, cosa che invece il “libero lavoratore salariato” non è.
Ma proprio quella limitazione temporale della cessione della forza-lavoro che deve avvenire «pezzo a pezzo» (K. Marx, Lavoro salariato e capitale, 1849) consente di guardar meglio dentro quello scambio, visto che, quando sarà eseguito, il lavoro dovrà essere svolto alle dipendenze del “datore di lavoro” quando, dove e come sarà da lui deciso. Ma allora in quello scambio iniziale di salario contro forza-lavoro che cosa cede in realtà il lavoratore? L’ha ben spiegato Ernesto Screpanti in un libro malauguratamente passato trascurato (Il capitalismo. Forme e trasformazioni, 2006): «la ricerca mi ha portato a concludere che l’istituzione fondamentale del capitalismo è… il contratto che istituisce l’obbligo all’obbedienza del lavoratore e quindi il potere di comando del capitalista nel processo produttivo», così che al momento della firma «non si scambia un bene, ma si assume un obbligo all’obbedienza (per cui) il lavoratore rinuncia alla propria autonomia decisionale per un certo numero di ore al giorno e il datore di lavoro acquisisce un potere di comando sul lavoro. L’attività lavorativa, dopo la stipulazione del contratto, non si presenta come una azione del lavoratore, bensì come un’azione del datore di lavoro e il prodotto che si ottiene tramite essa appartiene al datore di lavoro, cosicché non c’è ragione per collegare la remunerazione del lavoratore a un suo contributo produttivo. Ovviamente esiste il contributo produttivo dell’attività lavorativa, ma esso non è, legalmente, un contributo del lavoratore». Insomma, se (come si dice alla moderna) «l’impresa capitalistica è un “nesso di contratti di lavoro”, lo è proprio all’opposto di ciò a cui pensano i teorici del “nesso di contratti”… Essa non nasce in effetti da nessuna imperfezione del processo di scambio mercantile: né i costi di transazione, né l’incertezza, né le asimmetrie informative, né alcun altro tipo di fallimento del mercato generano le condizioni d’esistenza della impresa capitalistica», ma soltanto per quell’obbligo di obbedienza del lavoratore salariato alla volontà altrui che Adam Smith nel 1776, con giusta ragione, aveva chiamato “lavoro comandato” (labour commanded), ma che si potrebbe anche dire “lavoro obbligato”.
Volendo andare sul giuridico, qui può soccorrere il caso, previsto nel diritto romano, del “mercenario” che oppone alla cessione della locatio operis da parte di chi che s’impegna “a fare” qualcosa di specifico per conto altrui (come l’idraulico che mi ripara il lavandino), la vendita di una locatio operarum, ossia “a dare” fin da ora la propria attività lavorativa a venire quando e come gli sarà richiesta da chi lo ha assunto, che è poi tutta la differenza tra il soldato richiamato d’autorità sotto le armi per una guerra in corso ed il “mercenario” che si mette da subito ««a disposizione per le guerre a venire, così che Marco Tullio Cicerone nei Doveri (44 a. C.) poteva giudicare «ignobili e vili i guadagni dei salariati, dei quali si paga il lavoro e non l’arte, essendo il salario il prezzo della loro servitù» (cfr. R. Martini, Mercennarius. Contributo allo studio dei rapporti di lavoro in diritto romano, 1958). Si potrebbe anche dire che il contratto di “lavoro salariato” istituisce un contratto di mercenariato con il quale «si vende la libertà. Il lavoratore salariato è di fatto uno schiavo a tempo definito, legalmente però è un uomo libero, e anche questa è una caratteristica fondamentale del capitalismo: il lavoratore deve essere dotato di libertà contrattuale, altrimenti non potrebbe cedere la potestas sottoscrivendo un contratto», e pure la sua coscienza glielo conferma dato che ha accettato quel contratto di lavoro volontariamente, e «per non sentirsi servo di un altro, sia pure solo pro tempore, si convince di avere venduto alla controparte non un certo numero di ore della propria libertà, ma soltanto una merce», ossia quella capacità di lavoro che naturalmente possiede ed «è sui prodotti di questa falsa coscienza che lavoreranno poi gli economisti», con la bella conseguenza che il lavoratore, che «crede di instaurare un rapporto da pari a pari con il datore di lavoro, almeno giuridicamente, proprio in quanto crede di vendergli solo una merce, in tal modo giunge a percepire la relazione sociale che così genera come una relazione tra cose, tra merci, invece che come un rapporto tra uomini».
E infatti che cosa gli succederà nel lavoro che poi dovrà svolgere? Che non vi si realizzerà affatto e vi si sentirà “alienato”, che è stato il grande tema del giovane Marx che tanto è piaciuto ai professori di filosofia (meno agli economisti), perché il prodotto non sarà suo, il lavoro gli sarà estraneo e perfino la sua “essenza umana” di homo faber gli sarà negata dovendo lavorare alle dipendenze altrui, così che «l’operaio solo fuori del lavoro si sentirà presso di sé e si sentirà fuori di sé nel lavoro: è a casa propria se non lavora, mentre se lavora non è a casa propria» (K. Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844). Ma perché allora si sottomette, e volontariamente, a un siffatto contratto di lavoro che lo stravolge fino alla sua intima natura? Perché deve comunque campare e la vendita della propria forza-lavoro, che è la sola merce che possiede (insieme alla possibilità di far figli e infatti “proletario” sarà pure un sinonimo di salariato) è l’unica possibilità che si ritrova per guadagnare quel denaro (salario) che gli serve per acquistare le merci necessarie alla propria sopravvivenza. Siccome la vita incomincia per lui dal momento in cui cessa il lavoro, e quindi a tavola, al banco dell’osteria, nel letto, il significato delle ore di lavoro non starà per lui nel tessere, filare, trapanare, ecc., ma soltanto nel guadagnare ciò che gli permette di andare a tavola, al banco dell’osteria, a letto. Se il baco da seta dovesse tessere per campare la sua esistenza come bruco, sarebbe un perfetto salariato» (Lavoro salariato e capitale). E questo basti per la conoscenza di colui che produce dentro il “fatto” del capitalismo. Ma il risultato di quel lavoro? Alla prossima Cronaca MarXZiana!




 Like
Like 


































era solo per dire, lo so che sono ignorante