
Dall' università dei baroni all'università dei padroni
Andrea Martocchia
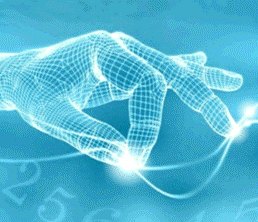 L'attacco al sapere
L'attacco al sapere
Lo stravolgimento del sistema della formazione e della ricerca in Italia ha segnato un suo momento topico nel passaggio in Senato della riforma Gelmini. Ad attestare l'importanza del frangente è tra l'altro l’impressionante dimensione e determinazione delle iniziative del movimento di protesta, che ha catalizzato insieme molti diversi settori: non solo studenti ma anche ricercatori, precari e non, dell’università, degli enti di ricerca, pezzi del mondo della scuola di ogni ordine e grado, della cultura e dello spettacolo, rappresentanti del precariato diffuso, giovani disoccupati e sotto-occupati. Il movimento, per la sua stessa composizione, è stato una dimostrazione vivente del fatto che il colpo sferrato contro l'università con la riforma Gelmini è parte di una ristrutturazione ampia e strategica, che in altra sede abbiamo definito un generalizzato attacco al sapere rivolto contro più di una generazione di “giovani”, che attraverso il sapere per l’appunto avevano creduto di poter costruire un futuro per se stessi e per la società tutta.
In questa sede cercheremo di spiegare che l'attacco al sapere non è un fatto contingente, bensì strutturale; esso non è legato ad una specifica gestione politica di centrodestra, ma è bipartisan; non accade solamente in Italia per ragioni legate alla nostra storia o fase specifica, ma è riconoscibile in tutti i Paesi a capitalismo avanzato. La prospettiva nella quale tale attacco va inquadrato è una prospettiva globale ed epocale, poiché il suo carattere è sistemico e perciò non può essere compreso, tantomeno efficacemente contrastato, se non se ne considerano le cause macro economiche.
Baroni e padroni
Se è oramai lampante l'importanza strategica della riforma dell’università, forse non è ancora altrettanto chiaro quale ne sia la filosofia ispiratrice. Come suggerisce Forges Davanzati, perciò, sarà bene «sgombrare il campo da un equivoco: il suo reale obiettivo non è introdurre criteri di valutazione che premino il merito, bensì operare un depotenziamento del sistema formativo pubblico che non ha precedenti nella storia recente del Paese». Uno degli aspetti di questo depotenziamento è evidentemente il trasferimento massiccio di risorse dal pubblico al privato e il contestuale svilimento della funzione sociale e democratica delle università. Se ad esempio il DDL Gelmini mette ad esaurimento i posti da ricercatore, concorrendo così (con i tagli di Tremonti) a svuotare di personale docente le università statali, le dieci università private, pur ricevendo fondi pubblici, possono continuare ad assumere. Secondo Davide Ascoli, «si promuove così un ritorno all’università di élite o una differenziazione qualitativa e classista degli atenei nella vendita competitiva di conoscenza mercificata, con l’inevitabile corollario della perdita del valore legale dei titoli di studio, atta a scassinare i meccanismi dei contratti nazionali di lavoro».
In sostanza, le riforme universitarie degli ultimi venti anni ci parlano di una lunga e travagliata transizione di fase. In effetti assistiamo all'avvicendamento tra due modelli di università, come in un passaggio della staffetta. Dal modello feudale dell'accademia organizzata in scuole rappresentate ciascuna da un barone attorniato dai suoi vassalli, valvassori e valvassini, ad un modello pienamente capitalistico, governato direttamente dalle esigenze mercantili dell'impresa e basato sulla selezione per censo. I due modelli - quello arcaico e feudale da una parte e quello liberista e capitalista dall'altra - non sono necessariamente in contraddizione tra loro. Entrambi sono modelli che configurano un’università per élites. Come il barone (che pure, nella sua versione virtuosa, può essere un dotto e un vero capofila delle conoscenze nel suo campo) è preoccupato in primo luogo della riproduzione del suo paradigma o scuola di pensiero, così il nuovo tecnocrate indirizza la trasmissione delle conoscenze secondo interessi economici e sociali di tipo corporativo, di cordata anch'essi, imbrigliando eventuali linee di ricerca difformi.
Con l'introduzione dell'Agenzia per la Valutazione ANVUR e dei Consigli di Amministrazione aperti a soggetti esterni, quali gli imprenditori, e dotati di poteri assoluti, gli interessi baronali e padronali si compongono e si rafforza la lottizzazione politica, economica ed accademica degli atenei. In particolare rischia di essere questo il senso della cosiddetta valutazione della ricerca. Carlo Galli (che pure non è contrario alla riforma Gelmini, né all' istituzione dell’ANVUR) ha lucidamente previsto una «quasi inevitabile tendenza dei revisori a promuovere alcune linee di pensiero o di ricerca - certo, le più autorevoli e consolidate (il cosiddetto mainstream) - e a scoraggiarne altre. Ed ecco che proprio dall'interno della scienza rispuntano possibili censure, o almeno pressioni e orientamenti che fanno si che la ricerca e il sapere siano esposti, come minimo, al potere che da essi stessi promana». La valutazione insomma «potrà essere il veicolo di un controllo capillare sulla ricerca, che ne determina stili e obiettivi in sintonia con le richieste dei poteri politici e sociali».
Il modello feudale di università è talmente radicato nella storia culturale italiana al punto da poter sopravvivere anche alla transizione in atto, visto che - come abbiamo già detto - non la contraddice affatto. Ciononostante, sempre secondo Forges Davanzati, si registra una «delegittimazione mediatica del sistema universitario pubblico che regge sulla duplice retorica dei professori ‘baroni’ e ‘fannulloni’»; questa operazione mediatica è sotto gli occhi di tutti, ma non intaccherà in alcun modo il mondo universitario tradizionale. Come nota infatti ancora lo stesso autore, le nuove disposizioni normative attribuiscono ai professori di prima fascia la gran parte del potere di decisione sulla governance degli atenei e sul reclutamento, rendendo così l’università italiana più gerarchizzata e, dunque, potenzialmente più “baronale”. Il mondo accademico sconta casomai una sua endemica litigiosità interna, anch'essa espressione di una certa arretratezza feudale, fatta di gruppi e consorterie, gelosie e campanilismi, tratti che spesso connotano il profilo degli intellettuali nostrani. Nella disgregazione competitiva e fratricida che ormai domina nelle nostre università è perciò gioco facile contrapporre (come nel caso del reclutamento dei docenti) i diritti acquisiti a quelli da conquistare e viceversa.
I limiti del dibattito nazionale sull’università
Nella struttura feudale dell'università italiana riconosciamo il suo carattere più propriamente nazionale, così come nell'avanzante modello di università privatizzata intravediamo una tendenza in atto a livello internazionale e globale. Il modello che viene completamente bypassato in questa transizione dal feudalesimo universitario al capitalismo liberista è quello dell'università democratica e di massa, che pure ha cercato di affermarsi - benché tra seri limiti e contraddizioni - nell'Italia repubblicana soprattutto grazie ai cambiamenti degli anni Sessanta e Settanta.
Il libro di Francesco Sylos Labini e Stefano Zapperi, I ricercatori non crescono sugli alberi (Laterza 2010), scandaglia soprattutto i limiti prettamente italiani del nostro sistema, stigmatizzandolo come gerontocratico. Benché Sylos Labini e Zapperi si dichiarino anche contrari alla privatizzazione dell'università e della ricerca, essi si soffermano soprattutto a considerare le innumerevoli questioni tecnico-procedurali riguardanti la valutazione, allo scopo di trovare la o le soluzioniformali che consentano di romperne il «regime feudale». La discussione meramente tecnica che Sylos Labini e Zapperi impostano a proposito della valutazione della ricerca (impact factor, fattore di Hirsch, eccetera) non consente tuttavia di cogliere la camicia di forza strutturale che oggi affligge i lavoratori del comparto della conoscenza non solo in Italia.
In maniera in un certo senso analoga, Margherita Hack in Libera scienza in libero Stato (Rizzoli 2010) riconosce e critica aspramente alcuni aspetti specificamente nazionali della crisi della nostra ricerca. Nel suo caso, l'arretratezza culturale italiana viene spiegata come conseguenza di dinamiche storiche tutte interne al nostro Paese, come il peso della Chiesa cattolica e la sua avversione allo sviluppo scientifico. Si tratta di questioni certamente importanti e di temi complementari a quelli posti da altri autori; tuttavia, in questo modo la critica della Hack rimane anch'essa su di un piano sovra-strutturale. I mille problemi della ricerca sono presentati dalla studiosa quasi come una grandinata di errori casuali, dovuti al più all’impreparazione dei politici.
In realtà, l'indagine sui problemi di università e ricerca non ha sbocchi se non passa dal piano “interno” a quello generale socio-economico e se la visuale non si allarga dalla prospettiva italiana a quella internazionale. Approfondire la discussione in questo senso consente di superare la dimensione moralistica della critica all’impreparazione o all’ignoranza dei politici nostrani e all’arroganza o corruzione dei baroni universitari. Il punto difatti è che la crisi è sistemica e globale e non solo incidentale o interna allo sviluppo italiano. Neppure le rituali analisi sul carattere arretrato del capitalismo italiano danno conto della dimensione internazionale dell'attacco al sapere: il disinvestimento in atto in Italia è l'applicazione nel nostro contesto di ricette dettate a livello transnazionale in Europa, USA e Giappone.
Le forze economiche
Il fatto è che la vera essenza del sistema economico capitalistico non risiede nell'innovazione e nella competizione scientifico-tecnologica. Tale descrizione, edulcorata e propagandistica, attiene semmai solo alle fasi di sviluppo virtuoso del capitalismo. In tali fasi i capitalisti competono tra di loro attraverso l'introduzione di nuove tecnologie per aumentare la produttività e, al limite, rimpiazzare il lavoro con i mezzi di produzione. La fase che invece oggi attraversiamo è esattamente opposta: dall’attuale crisi di sovrapproduzione il capitalismo esce distruggendo le sue stesse forze produttive e tornando a sfruttare il lavoro vivo, cioè i lavoratori. Ecco perché la produzione e riproduzione del sapere scientifico nei paesi a capitalismo avanzato è adesso per molti versi bloccata: la crisi delle università e degli enti di ricerca, assieme agli attacchi al mondo della scuola e della cultura sono sintomi di un’incipiente desertificazione dei luoghi della formazione delle forze produttive più avanzate.
Siamo insomma nel fuoco della più classica tra le contraddizioni individuate da Marx: quella tra lo sviluppo delle forze produttive (riconoscibile nell'allargamento del bacino della manodopera altamente qualificata, reale e potenziale) da un lato, e l’inadeguatezza dei rapporti di produzione esistenti dall'altro. È inoltre in atto un violento tentativo da parte delle classi dominanti di garantirsi la proprietà privata - e addiritturamonopolistica - delle produzioni ad alto livello di know-how, imponendo un generalizzato disinvestimento da tutti i luoghi in cui la conoscenza tende ad estendersi socialmente. Perciò non devono sorprendere le parole del ministro Sacconi che, nell'ambito di un contraddittorio intervento ai microfoni di Radio Uno, si è lasciato sfuggire che è necessario rivalutare il lavoro manuale. Sacconi definisce «distratti e cattivi maestri» quelli che spingono i giovani ad acquisire competenze che non sono richieste dal mercato del lavoro. Tra questi «cattivi maestri» Sacconi annovera più di una generazione di genitori: quegli “ex-giovani” che, al pari dei giovani che oggi protestano, avevano inteso l'istruzione come uno strumento di riscatto sociale.
Intellettuariato
Fino ad un paio di anni fa, pur degradandosi, i luoghi della formazione si moltiplicavano. Sembrava di assistere ad una ristrutturazione, sì tecnocratica, degenerativa e contestabile dell'intero sistema, ma non certo ad un suo precipitoso restringimento. Era tutto un coro demagogico sulla società della conoscenza, l'innovazione e la formazione continua. Lo vediamo oggi a che cosa sia servito. La rilevanza sociale del fenomeno è palese: solo per quanto riguarda l'università sono in ballo i destini di 50.000 ricercatori precari che vi lavorano, centinaia di migliaia di studenti e qualche milione di giovani laureati disoccupati o sottoccupati che vorrebbero trovare un futuro impiego stabile nel settore della conoscenza. A tutti costoro vanno aggiunti i milioni di non-più-giovani laureati, sottoccupati o disoccupati, di cui una rilevante fetta sono rimasti ad orbitare nell’ambito della ricerca, dell'istruzione e della cultura, frustrati e malpagati.
Si tratta di una vera e propria massa (si pensi ai 150.000 precari della scuola) che è prevalentemente composta da appartenenti al ceto medio in declino: talvolta sono pezzi di borghesia intellettuale e dei servizi che adesso precipitano socialmente, ma più spesso sono i figli di quel proletariato che durante il boom economico si era trasferito nelle città trovando un “buon lavoro” e, per i figli, la possibilità di un discreto livello di istruzione. Questa massa di giovani e non-più-giovani istruiti vive una vita precaria spesso affidata al sostegno dei genitori. Come definire questa massa di persone se non intellettuariato? Una classe sociale di transizione, cioè, destinata ad eclissarsi al primo tornante generazionale. L’intellettuariato odierno, infatti, avrà discendenti privi di diritti e di motivazioni per accedere ai livelli di istruzione dei padri; il suo destino di classe è di estinguersi culturalmente se non addirittura (a causa delle contraddizioni materiali che deve scontare) biologicamente.
Ha dunque ragione Forges Davanzati a notare che «siamo ben lontani dall’essere una società post-industriale, fondata sul sapere, nella quale come tanta letteratura degli anni della new economy ha inteso far credere il principale input è la conoscenza». Se il problema adesso è globale, in Italia non ci troviamo certo di fronte a qualcosa di nuovo, visto che già Arturo Labriola agli inizi del Novecento osservava che ai nostri imprenditori «ciò che interessa è avere non tanto buoni operai, quanto operai buoni».
____________________________________________________________________








































Add comment