L’Ucraina e noi: l’europeismo contro se stesso
di Andrea Guazzarotti
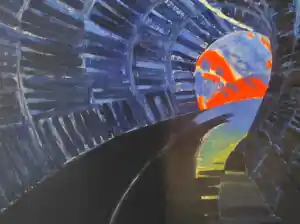 L’occultamento del conflitto intra-europeo prima dell’esplosione di quello russo-ucraino
L’occultamento del conflitto intra-europeo prima dell’esplosione di quello russo-ucraino
Le élite europee, nel loro nichilismo (E. Todd), hanno sposato la linea del confronto armato a oltranza contro la Federazione russa di Putin. Serviva a ricostituire un nuovo simulacro di unità tra gli Stati membri che due crisi e un’architettura istituzionale (sempre più) disfunzionale stavano (e stanno) minando. Per farlo, quelle élite hanno cinicamente sacrificato l’Ucraina, anche se sarebbe più corretto dire: hanno ceduto alla pressione degli USA affinché l’Ucraina venisse usata come proxy nella guerra contro la Russia di Putin.
Il cedimento è stato, innanzitutto, interno: con una vittoria del fronte della “nuova Europa” sulla vecchia (Minolfi 2023, pp. 76ss.). La battaglia cruciale si è svolta a porte chiuse, al Consiglio NATO di Bucarest del 2008, quando gli USA hanno provato a forzare il corso degli eventi spingendo per l’attivazione immediata delle procedure di ammissione di Georgia e Ucraina nella NATO, scontrandosi con il veto di Francia e Germania, cui replicarono duramente i rappresentanti dei nuovi Stati dell’Europa centro-orientale (Polonia in testa). L’esito fu quello di annunciare comunque come prossima l’attivazione delle procedure di adesione, allarmando Mosca senza offrire alcuna garanzia immediata ai due Paesi in questione (ibidem). Un confronto politico acceso del quale le opinioni pubbliche sono state praticamente tenute all’oscuro, secondo un processo di infantilizzazione dei cittadini europei (Minolfi 2025) perseguito nell’alveo di una strategia delle classi dirigenti europee di disconnessione e immunizzazione dai propri elettorati.
Parallelamente deflagrava in quegli anni la crisi dell’euro, impacchettata come crisi del debito pubblico degli Stati debitori dalle élite europee (leggi: i Governi degli Stati creditori in combutta con i vertici di BCE e Commissione europea). Dinanzi all’impennarsi dell’antieuropeismo degli elettorati (specie di quelli sottoposti all’austerity) quelle élite intravedevano già nelle vicende interne all’Ucraina (le proteste di Euromaidan) lo spiraglio per programmare una nuova, pericolosa, strategia di riattivazione dell’ideologia europeista.
Il presidente della Commissione Manuel Barroso prefigurava, tanto cinicamente quanto spregiudicatamente, una “nuova narrazione” per l’UE: «Il mio appello (…) è di non cedere a questo disfattismo»; dinanzi alle sfide del nazionalismo estremista, della xenofobia, del razzismo, è importante «avere il coraggio di uscire e combattere» per i valori che rappresenta l’Europa. «E se qualcuno di noi in Europa nutre dubbi sull’importanza di questi valori, gli basterà guardare all’Ucraina. Questi giovani [che nelle strade gelate dell’Ucraina stanno combattendo per la bandiera europea], stanno scrivendo la nuova narrazione per l’Europa» (Barroso). In quei mesi, infatti, erano in corso i movimenti di piazza in Ucraina (con la partecipazione più che attiva di alcuni esponenti del partito repubblicano e del governo USA) per forzare il presidente Janukovyč a siglare l’accordo di adesione all’UE, negoziato ignorando apertamente le riserve avanzate dalla Russia, preoccupata dal fatto che quell’adesione avrebbe automaticamente revocato le prospettive di coinvolgimento dell’Ucraina nell’area economica di alcuni Paesi dell’ex Unione sovietica (ciò che poi sarebbe diventata l’Unione economica euroasiatica: Minolfi, cit., p. 115s.). Seguirono, nel febbraio 2014, le ormai note vicende delle violenze di piazza di Euromaidan a Kyiv (Sachs). Il ministro degli esteri estone Urmas Paet – recatosi a Kyiv dopo l’eccidio di Maidan – telefonò all’alto rappresentante dell’Unione, Catherine Ashton, per comunicarle che da una prima indagine risultava che sia i manifestanti che i membri della polizia caduti durante le manifestazioni erano stati colpiti dalle stesse armi. Telefonata “oscurata” dalla stessa Ashton ma diffusa dai social. L’alto rappresentante veniva pertanto accusato da una interrogazione al Parlamento europeo di non aver informato dell’accaduto lo stesso Parlamento europeo prima che quest’ultimo discutesse e approvasse una risoluzione sull’Ucraina a sostegno del colpo di stato. L’alto rappresentante si limitò a invocare assai blandamente un’inchiesta internazionale, sotto la consulenza (non dell’UE bensì) del Consiglio d’Europa, senza alcuna conseguenza pratica (Minolfi, cit. p. 139s.).
Seguirono l’occupazione della Crimea e gli Accordi di Minsk, a posteriori cinicamente delegittimati da due ex capi di governo europei (Merkel e Hollande), che confermarono le dichiarazioni dell’ex presidente ucraino Poroshenko sulla funzione di un mero diversivo di quegli accordi per consentire all’Ucraina di riarmarsi in previsione di un conflitto con la Russia (Minolfi, cit., pp. 164s.).
L’interpretazione massimalista occidentale del conflitto segna il destino dell’Ucraina?
Veniamo alla guerra di invasione perpetrata dalla Russia contro l’Ucraina: l’iniziale fase del conflitto (l’invio della colonna di militari e mezzi in marcia verso la capitale ucraina, con un contingente chiaramente inadeguato all’occupazione dell’Ucraina, cui reagì un’efficacissima reazione delle forze armate ucraine addestrate e supportate dall’occidente) fu interpretata dalle élite statunitensi e britanniche, cui si accodarono quelle europee, come un chiaro segno della debolezza – materiale e strategica – russa. Di qui la conclusione (come minimo affrettata) di poter infliggere una sconfitta decisiva alla Federazione russa. Una lettura che, a posteriori, ben possiamo definire inquinata dalla propaganda ideologica occidentale antirussa. Già nell’estate del 2022 un ufficiale dei Marines aveva avanzato l’interpretazione che si fosse trattato di una manovra diversiva dell’esercito russo, il cui vero interesse era rafforzare il proprio posizionamento nel Donbass (Buffagni 2022).
La cinica e probabilmente strumentale sottovalutazione dell’avversario preludeva alla strategia successiva dell’occidente verso il conflitto russo-ucraino. Un conflitto tra due soggetti nettamente sproporzionati, ove il debole avrebbe avuto qualche chance di successo contro il forte solo se la posta in gioco fosse stata di tipo meramente territoriale (la soluzione della questione dei territori russofoni e russofili delle regioni al confine orientale ucraino) e non “esistenziale” (Buffagni 2023). Di fatti, durante le prime fasi del conflitto (tra il 24 febbraio e il 7 aprile 2022) si tennero diversi incontri diplomatici tra Ucraina e Russia: al possibilismo di Zelensky per la neutralità del suo Paese fece seguito il ripiegamento delle truppe russe da Kyiv alla Bielorussia. Ma il 9 aprile, a sorpresa, il primo ministro britannico Boris Johnson incontra il presidente Zelensky a Kyiv, esaltando le gesta militari ucraine: dopo quell’incontro cessano di fatto i tentativi di dialogo diplomatico tra Ucraina e Russia (Buffagni 2022). A quel punto scatta l’autoinganno dell’occidente a guida Stati Uniti-Regno Unito circa la possibilità di una sconfitta definitivamente inabilitante della Russia, chiudendo ogni spazio alla diplomazia. Il conflitto fu trasfigurato dalle élite occidentali in una lotta esistenziale che puntava alla vittoria finale, ossia, alla disfatta della Russia, con tanto di regime change e – addirittura – di smembramento della Federazione in tanti piccoli staterelli, come candidamente ammesso dall’ineffabile Kaja Kallas. Un ribaltamento di obiettivi, da parziali e circoscritti a esistenziali e totalizzanti, che probabilmente è stato fatale per l’Ucraina.
Se, come accennato, il debole ha speranze di vincere in uno scontro con il forte, ciò accade quando il rapporto costi/benefici della vittoria diventa sfavorevole per quest’ultimo, come accaduto per il Vietnam con gli USA o l’Afghanistan con l’URSS. Ma un simile esito si verifica a condizione che la sconfitta non rappresenti un rischio esistenziale per il forte: né il Vietnam lo era per gli USA, né l’Afghanistan per l’URSS. Mentre così è stato rappresentato dagli occidentali sostenitori dell’Ucraina nei confronti della Russia, la quale non avrebbe esitato a quel punto a mettere in gioco tutte le proprie risorse strategiche per vincere (Buffagni 2023). Con il che gli occidentali avrebbero segnato il destino dell’Ucraina (Buffagni 2025).
Dall’economia di guerra all’equivalente funzionale del neomercantilismo e ritorno
L’integrazione europea è stata per molti anni una palestra di educazione alla repressione soft del conflitto politico: l’“integrazione di soppiatto” (Majone) serviva a costruire istituzioni comuni – in primis il mercato unico – al riparo dalle reazioni popolari di coloro che più erano esposti ai costi a tale integrazione. L’iper-liberalizzazione dei capitali avutasi alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso e cristallizzata con Maastricht ha condotto all’integrazione economica esterna a fronte della disintegrazione sociale interna (Cantaro; F. Losurdo). L’integrazione monetaria ha aggiunto un tassello assai problematico a questo modo di procedere delle classi dirigenti europee al di sopra delle teste dei cittadini: con una politica monetaria unica si è compiuto l’azzardo di affidare alla BCE il ruolo di camera compensazione “neutrale” dei divergenti interessi economici nazionali per surrogare i poteri di istituzioni scopertamente politiche (un parlamento e un governo federali), con il vantaggio apparente di poter operare dietro lo scudo della “tecnicità” delle decisioni e della segretezza del metodo di lavoro della stessa BCE (Guazzarotti; Dani). L’Italia è stata un apripista del governo epistocratico dei migliori e dell’immunizzazione dal conflitto sociale che ciò comporta (Preterossi): quando nell’aprile 1993, dopo la caduta del governo Amato, l’allora presidente Scalfaro incaricò Carlo Azeglio Ciampi a formare un nuovo Esecutivo (per la prima volta dal 1947 un tecnico), pare che qualcuno abbia chiosato: «Dopo un Governatore della Banca d’Italia, non resterebbe che nominare un Generale dell’Arma dei Carabinieri» (Martinazzoli? Cossiga? Agnelli?). Oggi, logoratesi le leve della governance economica ed economicistica dei popoli europei, sembra sia giunto anche nell’UE il momento dei generali. O almeno, dell’integrazione funzionalista attraverso la riconversione bellica delle soggettività neoliberali dei cittadini europei (Guazzarotti). Le classi dirigenti europee sembrano aver trovato finalmente un “Nemico” capace di dar forma al simulacro di un’unione politica: «l’Unione europea è un vero e proprio soggetto politico, se conta il fatto che essa è ormai considerata una forza ostile e persino nemica dallo Stato più grande del mondo» (Chiaruzzi).
Ma puntare sul conflitto esterno per tacitare quello interno (entro le società nazionali ed entro la c.d. “società europea”) è un passo assai rischioso. L’economista polacco Michal Kalecki, riflettendo nel 1943 sulla vicenda dell’economia di guerra nazista, segnalava come le politiche di pieno impiego keynesiane non avrebbero mai trovato il durevole sostegno dei capitalisti, posto che ciò avrebbe minato il potere disciplinare di questi ultimi sui lavoratori. L’economia di guerra, al contrario, aveva il pregio di coniugare pieno impiego e disciplinamento del lavoro, a favore del capitale monopolista. Una ricetta fallimentare per la Germania hitleriana, ma vincente per gli Usa di Roosevelt (Baran, Sweezy). Il neomercantilismo tedesco è stato un discreto equivalente funzionale dell’economia di guerra, grazie alla sua capacità di disciplinare il lavoro sotto l’imperativo identitario della competitività nazionale (“Wir sind Exportnation!”: Polyak). Quel modello è stato imposto alle altre economie dell’UE sfruttando la gestione tecnocratica della crisi dell’euro (Scharpf). Cosa che ha condotto l’UE allo squilibrio commerciale con il resto del mondo e con gli USA, in particolare, i quali, con il dieselgate del 2015, prima, e con il sabotaggio dell’import di gas russo, poi, hanno posto bruscamente fine a quel modello distopico di economia politica.
Il conflitto permanente tra UE e Russia sembra servire tanto gli interessi statunitensi (rottura del cordone ombelicale tra economia tedesca e russa) che quelli delle élite europee (comando verticistico sulle proprie società, assoggettate a stati d’eccezione più o meno formalizzati). Dopo il crollo impietoso dell’equivalente funzionale svolto dal neomercantilismo euro-tedesco, si è finalmente tornati al modello originario dell’economia di guerra, stavolta pienamente legittimata dall’UE e dagli stessi USA. Ma, lo si ripete, si tratta di un passo assai rischioso. Come già scriveva il sociologo americano Lewis Coser nel 1956, una società che per troppo tempo ha soffocato il conflitto sociale e politico al suo interno, rischia di trovare nell’espediente strategico dell’attivazione del conflitto bellico con un nemico esterno non la palingenesi dei propri legami interni, bensì il detonatore della propria implosione. Tutto dipende dal grado di coesione raggiunto fino a quel momento: la seconda guerra mondiale rafforzò la coesione sociale nel Regno Unito (tanto che, alla fine del conflitto, fu concepito il Rapporto Beveridge e il Welfare State), ma frantumò i legami interni alla Francia di Vichy (ibidem).
Il collasso esistenziale dell’europeismo
L’UE, anziché prepararsi a convivere con la Russia secondo l’unico modulo plausibile di una “soluzione coreana”, ha deciso invece di prepararsi alla guerra, varando un libro bianco sulla difesa dal minaccioso titolo “RearmEU/Readiness 2030”. Ivi leggiamo, tra l’altro, affermazioni agghiaccianti, del tipo: l’integrazione dell’industria bellica dell’Ucraina in quella europea della difesa consentirà di «fornire materiale bellico efficiente in termini di costo al mercato globale» (p. 11); a tal fine, «l’UE intende lanciare un progetto pilota per instaurare progressivamente un Meccanismo europeo di vendite militari» (p. 13). Si tratta di un progetto che sembra il gemello malvagio della Dichiarazione Schuman (dal 1950 bibbia dell’europeismo pacifista), in cui l’unificazione e denazionalizzazione della produzione di carbone e acciaio franco-tedesca veniva magnificato come ciò che avrebbe cambiato «il destino di queste regioni che per lungo tempo si sono dedicate alla fabbricazione di strumenti bellici di cui più costantemente sono state le vittime», con la promessa di offrire questa produzione comune di carbone e acciaio «al mondo intero senza distinzione né esclusione per contribuire al rialzo del livello di vita e al progresso delle opere di pace». A settantacinque anni dalla Dichiarazione Schuman l’UE sembra voler offrire al mondo a prezzi competitivi un altro tipo di produzione industriale, in modo da soddisfare l’inesausta domanda di armamenti proveniente da regimi autoritari e Paesi in stato di conflitto, contribuendo attivamente alla corsa al riarmo globale e fingendo di ignorare le conseguenze socio-economiche e migratorie di tale scenario geopolitico (Sédou).
Ai tempi dell’autolesionistico sforzo dell’Italia per entrare nell’euro, un immarcescibile esponente di spicco dell’intellighenzia italiana sprezzantemente affermava: «chi non ha virtù può solo sperare di obbligarsi a marciare al passo dei paesi virtuosi» (Cassese, p. 8). Dobbiamo continuare a marciare a quel modo anche oggi che quel “passo” sta pericolosamente somigliando al passo dell’oca?
Un segnale inquietante annuncia l’ondata di conformismo bellicista che si sta pianificando a livello europeo: in una risoluzione del Parlamento europeo dell’aprile 2025 si auspica «un allineamento delle percezioni delle minacce in tutta Europa», invitandosi alla messa a punto di «programmi educativi e di sensibilizzazione, in particolare per i giovani». La formula ricorda sinistramente l’espressione nazista della Gleichschaltung…
È ancora compatibile tutto ciò con il sempre più scivoloso appiglio testuale all’integrazione europea della «pace e giustizia tra le nazioni» iscritto nell’art. 11 della Costituzione italiana?
Il costituzionalismo democratico e repubblicano varato nel 1948, anche dopo lo svuotamento della sua dimensione economico-sociale per mano del Trattato di Maastricht (Irti), ha continuato a irradiare per molti una luce, al pari di ciò che continuano a fare le stelle morte, il cui riflesso seguita a irradiare il cosmo per il numero di anni luce necessari a raggiungere lo sguardo di chi le osserva senza sapere che già sono morte. L’europeismo ha svolto per anni la stessa funzione. Oggi, dopo le candide confessioni dei vertici europei nel RearmEU, possiamo dire a quell’europeismo targato UE: «benvenuto nel club delle stelle morte che non illuminano più».







































Add comment