“Non c’è nessuna bolla”: la reazione senza senso di mercati e media agli ultimi dati di NVIDIA
di OttoParlante - La newsletter di Ottolina
I profitti di NVIDIA salgono alle stelle, titola il Wall Street Journal, e placano il nervosismo degli investitori per il boom dell’intelligenza artificiale. La reazione di mercati e media ai nuovi dati di NVIDIA è paradossale; da mesi, chi parla di bolla, parla di eccessivi investimenti a debito per comprare chip senza avere modelli di business che garantiscano i ritorni necessari: che NVIDIA faccia il pieno di ordini (e di utili) non dovrebbe rassicurare proprio niente. Misteri della fede nel turbocapitalismo finanziarizzato…
Intanto, si scaldano i motori per la prossima bolla: il Quantum Computing, che, sottolinea il Financial Times, ovviamente, ha bisogno di una sua vera e propria rivoluzione industriale:
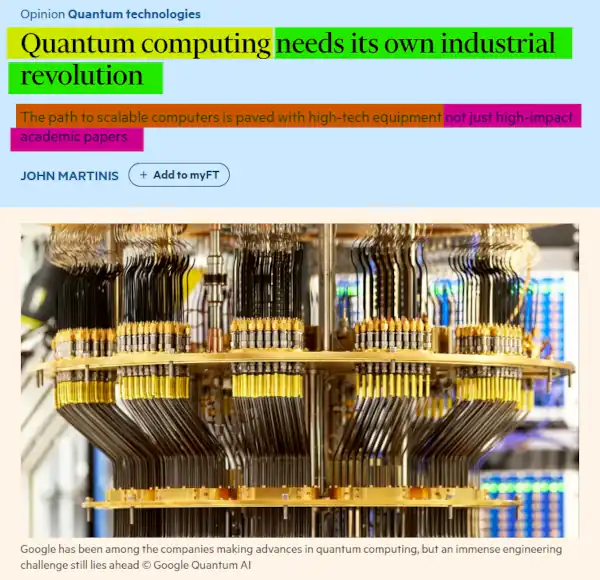
L’articolo ricorda come “Per arrivare a un computer quantistico di uso generale sono necessari più di 1 milione di qubit fisici”, ma “tra il 2019 e il 2025, i chip quantistici di Google sono passati da 53 a 105 qubit, un aumento di un fattore due in sei anni”. Insomma: come per l’AGI (l’intelligenza artificiale generale), siamo nel campo delle fantasie, una specie di orizzonte mitologico – proprio quello che serve per costruire un altro colossale schema Ponzi. Anche in questo caso – come per l’AI, ovviamente – il problema non è la tecnologia, che è una delle tante meraviglie partorite dall’uomo, ma la perversione intrinseca del turbocapitalismo finanziario.
Sull’esuberanza irrazionale che circonda la bolla AI torna, su Project Syndicate, Carlo Benedikt Frey dell’Oxford Internet Institute: “Secondo alcune stime , la crescita del PIL statunitense nella prima metà di quest’anno è derivata quasi interamente dai data center, scatenando una valanga di commenti su quando la bolla scoppierà e cosa potrebbe lasciare. Mentre la festa delle dot-com di fine anni ’90 si è conclusa con una sbornia per Wall Street, Main Street ha mantenuto ciò che contava: l’infrastruttura. La produttività è aumentata e la fibra ottica posata durante gli anni del boom funziona ancora oggi. La promessa del presidente degli Stati Uniti Bill Clinton di costruire un ponte verso il XXI secolo è stata una di quelle rare promesse elettorali effettivamente mantenute”; “Gli investimenti odierni nell’intelligenza artificiale potrebbero dare i loro frutti, proprio come ha fatto Internet. Per ora, però, i guadagni sembrano più contenuti e gli svantaggi macroeconomici più ampi rispetto alla bolla delle dot-com”. “Come le ferrovie nel XIX secolo, l’era delle dot-com ha investito denaro in asset durevoli – in particolare cavi in fibra ottica e reti dorsali – che potevano essere illuminati e riattivati con il progresso dell’elettronica. Gran parte di quel vetro trasporta traffico ancora oggi”; “Al contrario, l’intelligenza artificiale non sta tracciando binari; sta facendo funzionare un tapis roulant. Chip e memoria si degradano o diventano obsoleti nel giro di anni, non di decenni. Ogni rack di server utilizzato per addestrare un LLM ora richiede 120 kilowatt di potenza, rispetto ai circa 5-10 kW di dieci anni fa. E sebbene ogni nuova generazione di GPU (unità di elaborazione grafica) riduca il costo per watt, ciò significa che gli hyperscaler consumano flotte più velocemente man mano che le apparecchiature più vecchie diventano economicamente obsolete. Mentre la fibra ottica resiste mentre si cambiano gli endpoint, lo stack tecnologico dell’intelligenza artificiale si deprezza rapidamente, richiedendo continui reinvestimenti”. Ad aggravare la situazione, il quadro macroeconomico, con “i persistenti deficit del governo statunitense prossimi al 6% del PIL (circa 1,8 trilioni di dollari) e i pagamenti netti di interessi prossimi a 1 trilione di dollari”, che “hanno ridotto il margine di bilancio”: “Se i frutti dell’IA dovessero arrivare, ma solo lentamente, i calcoli saranno ancora più difficili”. A rendere la situazione peggiore rispetto alla bolla delle dot-com, poi, c’è il fatto che “La crisi dei primi anni 2000 è stata principalmente una questione azionaria: i prezzi delle azioni sono crollati e gli investitori di venture capital che miravano a rendimenti a lungo termine hanno subito un duro colpo”: “Poiché la crisi delle dot-com è stata in gran parte una rivalutazione azionaria (telecomunicazioni a parte), non una crisi bancaria, non si è verificato alcun fallimento sistemico nonostante le ingenti perdite degli investitori”; “Questa volta, i finanziamenti si stanno spostando dalle azioni alle obbligazioni, ai veicoli speciali e ai leasing, e al credito privato: tutte forme di prestito che in ultima analisi sono collegate a banche e assicurazioni”, “quindi è più probabile che lo stress si diffonda attraverso istituti di credito e veicoli strutturati”. Il Council on Foreign relation ha recentemente pubblicato un rapporto dove suggerisce la soluzione: togliere soldi al welfare, per metterli nella bolla; per gli autori, è una questione di “sicurezza nazionale”, ma, come sottolinea Responsible Statecraft, “Una rapida occhiata all’elenco dei membri della task force rivela che non si tratta di esperti o analisti indipendenti, bensì di individui fortemente investiti in queste tecnologie emergenti e negli appalti governativi”.
Il Soddu
Nexperia: l’Olanda cala le braghe. La vicenda Nexperia è un perfetto micro-laboratorio della nuova guerra fredda dei chip: l’Olanda, nel giro di poche settimane, è passata dal commissariare di fatto l’azienda, in nome della sicurezza nazionale e del controllo su una fabbrica cruciale per l’auto europea, al restituirne il controllo al proprietario cinese Wingtech. L’Aja prova a dire due cose insieme: “Siamo affidabili per gli alleati occidentali”, ma anche “Non vogliamo far esplodere la supply chain dei semiconduttori a casa nostra”. La scelta di ridare le chiavi a Nexperia arriva dopo settimane di tensione, blocchi all’export di chip e allarmi dell’industria automobilistica, ma non è un lieto fine: resta sul tavolo tutta l’ambiguità di un’Europa che invoca derisking dalla Cina, mentre continua a dipendere da capitali, tecnologie e mercati asiatici. Nexperia mostra il paradosso: per difendere la sovranità tecnologica, l’Europa deve colpire un’azienda su cui, però, si regge la produzione industriale europea; così confusi da colpirsi da soli. Un governo europeo che brandisce il bastone della sicurezza nazionale e, appena l’industria inizia a soffocare, è costretto a tornare al tavolo con Pechino è l’immagine plastica del fatto che, oggi, le armi economiche dell’Occidente sono molto meno unilaterali di quanto la retorica lasci intendere. Ne parlano ANSA, Bloomberg e due articoli del Global Times (qui e qui).
Washington spara a zero sulle “minacce cinesi”. Negli Stati Uniti, la macchina politica continua a produrre report e allarmi sulla minaccia sistemica dalla Cina; la commissione del Congresso che si occupa della competizione strategica con Pechino chiede azioni concrete su tutti i fronti: sicurezza delle catene di fornitura, tecnologia avanzata, infrastrutture critiche, capacità militare e spazio. È la codifica ufficiale di qualcosa che nella pratica è già in corso: la trasformazione di ogni dossier economico in dossier di sicurezza nazionale. Questo linguaggio ha almeno tre effetti. Primo: sposta il baricentro del dibattito interno; per prima cosa, oggi qualsiasi misura restrittiva diventa giustificabile, anche ferirsi temporaneamente pur di ferire con retaliate. Secondo: manda un messaggio agli alleati, Europa in testa, che vengono implicitamente invitati a scegliere un campo, riducendo gli spazi per ambiguità tattiche come quelle olandesi su Nexperia. Terzo: irrigidisce la posizione cinese, che interpreta questi report come copertura ideologica per una strategia di contenimento a lungo termine. Da un lato il Congresso, che descrive la Cina come minaccia globale; dall’altro, un’economia americana che continua a drenare capitali e infrastrutture finanziate proprio da Pechino. Una parte dell’establishment americano sta tentando di riscrivere la realtà economica in codice securitario, per giustificare la guerra di lungo periodo all’ascesa cinese (qui l’approfondimento del Washington Post).
I 200 miliardi cinesi nei progetti tech e infrastrutturali USA. Il dato dei 200 miliardi di dollari prestati dalla Cina a progetti tecnologici e infrastrutturali negli Stati Uniti è una bomba narrativa, perché ribalta il frame classico della Belt and Road come trappola del debito per i Paesi poveri: qui, il principale debitore è la superpotenza che, da anni, mette in guardia il resto del mondo dal credito cinese. Il rapporto mostra una Cina che, in silenzio, entra nel cuore fisico dell’economia USA: aeroporti, gasdotti, data center, infrastrutture energetiche e pezzi di filiera high-tech. Washington si impegna a costruire una retorica anti-cinese basata sull’idea che i finanziamenti di Pechino siano tossici, opachi, geopoliticamente ricattatori; ma una parte non irrilevante del capitalismo americano ha accettato per anni quegli stessi soldi, spesso attraverso veicoli societari e giurisdizioni offshore, cioè nel livello massimo di opacità: in mezzo, c’è la frattura tra Stato profondo securitario e grande business globale, che ha continuato a fare affari finché è stato possibile. L’America che si è agganciata ai capitali cinesi per alimentare la propria macchina infrastrutturale e tecnologica: dietro la guerra di narrativa, c’è ancora un gigantesco intreccio di interessi materiali (qui l’approfondimento del Washington Post).
Jonathan Powell e i think tank legati all’intelligence cinese. Il caso Jonathan Powell è un’altra faccia della stessa storia: non solo soldi e chip, ma anche reti di influenza e produzione di narrativa nell’era di un Occidente sempre più ossessionato e assertivo: il consigliere per la sicurezza nazionale del Regno Unito si ritrova sotto i riflettori per aver co-ospitato eventi con un think tank cinese collegato all’intelligence. In teoria, nulla di sorprendente: la diplomazia contemporanea passa sempre di più attraverso fondazioni, centri studi, dialoghi informali; in pratica, però, quando la Cina viene ormai letta solo come minaccia, ogni relazione diventa sospetta. Qui il tema non è tanto la colpa individuale di Powell, quanto lo spauracchio dei governi occidentali – in particolare quello britannico – su tutto ciò che si può anche vagamente connettere alla Cina. Per anni, i think tank di Pechino sono stati considerati spazi di soft power accettabile, luoghi di confronto tecnico sul commercio, la sicurezza, la globalizzazione; ora quella fase è finita: gli stessi canali che servivano per integrare la Cina nel sistema occidentale vengono riletti come potenziali corridoi di influenza ostile. Questo episodio permette di mostrare come la competizione sistemica stia riscrivendo anche la grammatica delle relazioni personali e intellettuali; il funzionario che, fino a ieri, era l’uomo del dialogo, oggi rischia di diventare uno sporco sovversivo e, di riflesso, come in Europa e nel mondo anglosassone stia passando l’idea che con la Cina non ci siano più zone neutrali: o sei parte della macchina di contenimento, o sarai accusato di esserne il cavallo di Troia (qui l’approfondimento del Financial Times).
L’Europa in mezzo al Pacifico: dialogo con i Paesi feriti dalla rivalità USA-Cina. E sempre l’Europa dall’asse trans-Pacifico alla periferia dell’Indo-Pacifico, dove la rivalità tra Washington e Pechino non è teoria da think tank, ma materia grezza di politica quotidiana. L’articolo del SCMP sul tentativo europeo di trovare un terreno comune con i Paesi della regione racconta esattamente questo: l’Ue sta cercando di posizionarsi come terzo attore, alternativo al duopolio USA-Cina, parlando con Stati che si sentono schiacciati da sanzioni, guerre commerciali e militarizzazione delle rotte marittime. Qui emergono due tensioni. La prima è interna all’Europa: da un lato Bruxelles parla il linguaggio del derisking e dell’allineamento con gli Stati Uniti; dall’altro, prova a presentarsi nell’Indo-Pacifico come attore più dialogante, meno aggressivo e più interessato a commercio e sviluppo che a basi militari. La seconda è nei Paesi della regione: molti non vogliono scegliere un campo, ma sono costretti a farlo quando le catene di fornitura, gli investimenti e la sicurezza marittima vengono sequestrati dalla logica della guerra fredda 2.0. (qui l’approfondimento del South China Morning Post).









































Add comment