
Una critica alla teoria delle Aree Valutarie Ottimali come spiegazione della crisi dell'euro
di Guido Iodice e Daniela Palma
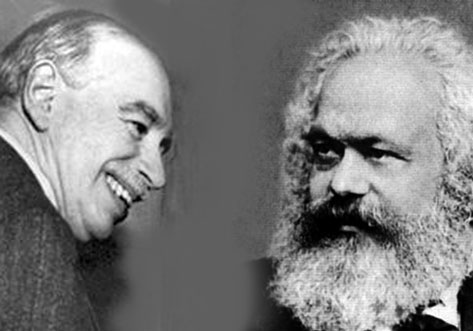 Il peccato “originale” dell'euro non pare trovare adeguata spiegazione in una delle teorie che oggi sembra andare molto di moda a seguito della crisi della moneta unica. Una disamina critica della teoria delle “aree valutarie ottimali” porta a concludere che i “criteri” da essa enunciati sono contraddittori ai fini di illustrare le criticità dell'euro, mentre le sue conclusioni di politica economica sono controproducenti economicamente e socialmente insostenibili. Ciò che rende stabile un'area valutaria è, in ultima analisi, lo Stato.
Il peccato “originale” dell'euro non pare trovare adeguata spiegazione in una delle teorie che oggi sembra andare molto di moda a seguito della crisi della moneta unica. Una disamina critica della teoria delle “aree valutarie ottimali” porta a concludere che i “criteri” da essa enunciati sono contraddittori ai fini di illustrare le criticità dell'euro, mentre le sue conclusioni di politica economica sono controproducenti economicamente e socialmente insostenibili. Ciò che rende stabile un'area valutaria è, in ultima analisi, lo Stato.
La teoria delle Aree Valutarie Ottimali (AVO, in inglese “Optimum Currency Area”) sta vivendo una notorietà particolarmente elevata dallo scoppio della crisi dell'euro. Economisti di diverse estrazioni, e numerosi studi dei maggiori organismi internazionali, hanno individuato nell'eurozona un'“area valutaria pessima” e spiegato in questo modo la tendenza al collasso della moneta unica europea. Eppure, a ben vedere, la teoria delle AVO non sembra convincente circa le difficoltà dell'euro. Inoltre appare difficile, applicando i suoi criteri, rintracciare un'area valutaria ottimale, a partire dagli Stati Uniti.
Nell’articolo che proponiamo partiamo mostrando che la teoria si basa sui presupposti del paradigma teorico neoclassico: le preferenze del consumatore, la dotazione dei fattori produttivi, l’esistenza di un tasso “naturale” di interesse che equilibra investimenti e risparmi, la teoria quantitativa della moneta.
Non sorprende quindi che le politiche che ne discendono siano in larga parte basate su una modifica delle condizioni dell’offerta: mobilità del fattore lavoro (cioè l’emigrazione dei disoccupati da una regione depressa) e del capitale, flessibilità salariale, maggiore concorrenza per indurre l’abbassamento dei costi.
Esaminando i “criteri” in base ai quali un’area valutaria può considerarsi ottimale, mostriamo che essi non sembrano dare una spiegazione convincente della crisi dell’euro. Rifacendoci alla letteratura, mainstream ed eterodossa, evidenziamo la contraddittorietà di tali criteri sia rispetto a quanto avvenuto nell’eurozona, sia in una situazione teorica. In particolare ci concentriamo sulla mobilità delle merci e dei capitali, che può produrre maggiori divergenze tra le regioni di un’area valutaria, e sulla mobilità del fattore lavoro, ritenuta dalla teoria AVO un elemento riequilibrante. Al contrario, mostriamo che il “rimedio” dell’emigrazione dei disoccupati da una regione in crisi verso le regioni più forti, non determina necessariamente un riequilibrio ma al contrario può esacerbare le divergenze pregresse.
La conclusione della nostra argomentazione è che l’unico “criterio” determinante per la stabilità di un’area valutaria è la presenza di uno Stato con un largo bilancio pubblico e una banca centrale prestatrice di ultima istanza e “garante” del debito pubblico (esattamente ciò che manca all’eurozona). Questo “criterio” determinante è stato diluito in un insieme di altri presupposti, in larga parte irrilevanti o persino contraddittori. Ne risulta che la teoria delle AVO, che si consideri la sua formulazione originaria o la sua evoluzione “endogena”, non appare in grado né di spiegare la crisi dell’euro né di indicarne la soluzione.
1. I criteri per un'area valutaria ottimale
La storia della teoria delle AVO si fa risalire al lavoro seminale di Robert Mundell (1961), per il quale l'economista canadese ottenne il Nobel per l'Economia.
Prima del paper di Mundell, Milton Friedman (1953), criticando i sistemi di cambio fisso (allora vigeva il Gold Standard), sostenne che in caso di “shock asimmetrici”, ovvero eventi che colpiscono una regione dell'area valutaria in modo differente rispetto ad un'altra, si sarebbero dovuti “aggiustare” i prezzi e i salari così da mantenere l'equilibrio precedente. Poiché – era la tesi di Friedman – è molto più semplice modificare il tasso di cambio piuttosto che migliaia di prezzi, i sistemi di cambi flessibili sono sempre preferibili a quelli di cambi fissi. Mundell intese quindi indagare a quali condizioni un'area valutaria può sostenere uno shock asimmetrico. Nel suo paper elencò quindi alcuni criteri che, se soddisfatti, potevano permettere ad una regione di condividere un sistema di cambi fissi.
Definire oggi cosa sia di preciso la teoria delle aree valutarie ottimali è piuttosto complesso. La letteratura sull'argomento è immensa. Lo stesso Mundell, inizialmente scettico sulla praticabilità di un'area valutaria tra paesi con caratteristiche divergenti, giunse nel tempo a modificare i suoi orientamenti fino a patrocinare la nascita dell'euro e finanche a proporre l'unificazione del dollaro e dell'euro. Alcuni autori hanno ritenuto che un'area valutaria dovesse rispettare i criteri della teoria prima di nascere (aree valutarie ottimali “esogene”), mentre altri hanno ipotizzato – in particolare nel caso dell'euro – che un'area valutaria possa essere creata comunque, perché la moneta unica livellerebbe le differenze e farebbe convergere i “fondamentali” dei paesi membri (aree valutarie ottimali “endogene”).
Noi qui quindi ci riferiremo all'elenco di criteri più comunemente associato alla teoria. Un'area valutaria è “ottimale” se rispetta in massimo grado i seguenti criteri (tra parentesi autore e anno dell'articolo più rilevante, vedasi bibliografia alla fine dell'articolo):
1) mobilità dei fattori produttivi, cioè capitale e lavoro: non devono esservi ostacoli alla mobilità dei capitali fisici e finanziari, ad esempio un'azienda deve poter delocalizzare in un'altra regione dell'area valutaria e i lavoratori devono essere disposti a trasferirsi; allo stesso modo i capitali finanziari devono essere liberi di circolare all'interno dell'area (Mundell, 1961);
2) flessibilità di prezzi e salari, in modo che un calo della domanda produca rapidamente un calo dei prezzi e dei salari (Friedman, 1953);
3) integrazione dei mercati finanziari, in modo che il tasso di interesse tenda ad uniformarsi (Ingram, 1962);
4) alto grado di apertura delle economie, ovvero nessun ostacolo alle merci, in modo che i cambiamenti dei prezzi in una regione possano influire rapidamente sui prezzi delle altre (McKinnon, 1963);
5) elevata diversificazione di consumi e produzioni all'interno dei singoli paesi costituenti l'area, in modo da ridurre gli shock settoriali: come vedremo, nel modello di Mundell, i paesi producono beni totalmente differenti e questo contribuisce a peggiorare gli effetti dello shock (Kenen, 1969);
6) tassi di inflazione simili, poiché gli squilibri nelle bilance commerciali derivano dal persistere di tassi di inflazione differenti che rendono i prezzi tra le varie regioni sempre più divergenti (Fleming, 1971);
7) integrazione fiscale (ed eventualmente politica): in caso di shock, un bilancio pubblico e un sistema di tassazione comuni permettono un più facile riassorbimento attraverso i cosiddetti “riequilibratori automatici”: ad esempio, se in una regione sale la disoccupazione, meno persone pagheranno le tasse e tuttavia percepiranno i sussidi, permettendo così alla domanda di non precipitare (Kenen, 1969).
Mundell in particolare attribuiva grande rilevanza al criterio della mobilità dei fattori produttivi, e segnatamente del lavoro. Secondo l'economista, un caso tipico di shock è il mutamento delle preferenze dei consumatori. Supponendo di avere un'area valutaria costituita da due paesi, diciamo Germania e Spagna, ognuno dei quali produce per semplicità un singolo bene, una modifica delle preferenze degli spagnoli a favore del prodotto tedesco diminuirebbe la domanda del prodotto spagnolo, deprimendo quindi la produzione domestica e l'occupazione. In Germania, al contrario, assisteremmo ad un aumento della domanda (a quella domestica si sommerebbe quella degli spagnoli) e quindi ad un aumento dell'output, dell'occupazione e dell'inflazione.
Questa descrizione dei fatti, comunque, è abbastanza differente da quanto accaduto realmente in Europa, dove la deflazione salariale tedesca è stata l'origine dei differenziali di competitività. Ad ogni modo, secondo Mundell, per ristabilire l'equilibrio, tre sono i rimedi possibili:
1) l'abbassamento dei prezzi e dei salari in Spagna;
2) la migrazione di parte della forza lavoro spagnola in Germania;
3) il riequilibrio tramite la politica fiscale.
2. Critica ad una teoria neoclassica
A prima vista, la teoria delle AVO sembra quindi ragionevole e in accordo con l'esperienza di molti paesi (si pensi alle migrazioni interne in Italia, o alla migrazione degli italiani all'estero). Lo stesso “rimedio” 1) esposto in precedenza è in effetti parte della politica economica imposta dalla “Troika” UE-FMI-BCE nei paesi in crisi.
L'austerità è stato il modo più semplice per diminuire la domanda di beni, tra cui quelli importati, nel mentre le “riforme strutturali”, vale a dire la riduzione dei diritti dei lavoratori, riducono i salari e quindi tentano di ristabilire l'equilibrio. L'austerità sta in effetti riequilibrando le bilance commerciali [ link], ma al costo di mandare in depressione le economie dei paesi periferici, generando elevata disoccupazione. D'altro lato, tale riduzione della domanda dai paesi periferici sta minando anche l'economia dei paesi centrali dell'eurozona [ link].
Non è questo tuttavia un rimedio che discende direttamente dalla teoria delle AVO, per lo meno nelle intenzioni iniziali di Mundell. Piuttosto la teoria AVO suggerisce la flessibilità dei salari (ottenuta generalmente attraverso la maggiore flessibilità del mercato del lavoro). Le “riforme strutturali”, sostengono i più, nel medio-lungo periodo porteranno al riequilibrio e alla crescita dell'occupazione.
Vi sono ottime ragioni per ritenere, invece, che questo non si verificherà. E, in effetti, mentre i salari reali si stanno riducendo nei paesi periferici [ link], così come il costo del lavoro per unità di prodotto [ link], ciò non si traduce in un miglioramento della produzione e dell'occupazione. Analizzando la questione della flessibilità salariale dal punto di vista (post)keynesiano, infatti, si arriva alla conclusione che l'abbassamento dei redditi da lavoro deprime ulteriormente la domanda interna, aggravando la disoccupazione piuttosto che ridurla.
Ricerche empiriche, in effetti, confermano che una riduzione salariale, in particolare ove conduca ad una riduzione della quota salari sul PIL, può avere effetti avversi sulla crescita poiché deprime la domanda aggregata, mentre non è scontato un effetto positivo sull'occupazione (Hein e Vogel 2008; Stockhammer et al. 2009). Anche in ambito mainstream, del resto, ci si pone il problema della disuguaglianza e delle sue conseguenze depressive sull'attività economica (cfr. Fitoussi-Stiglitz 2009; IMF-ILO 2010; Fitoussi e Saraceno 2010; Stiglitz 2012).
Anche in presenza di una riduzione delle differenze tra i prezzi relativi dei vari paesi, e quindi di un riaggiustamento del “tasso di cambio effettivo”, il meglio che si possa sperare attuando una politica di riduzione salariale dopo lo shock è che le maggiori esportazioni dei paesi periferici compensino il calo della propria domanda interna, lasciando la disoccupazione a livelli elevati. Si può obiettare che la riduzione dei prezzi interni avvantaggerebbe anche la domanda interna. Ciò però è improbabile, poiché in una crisi la domanda diviene tendenzialmente insensibile ai prezzi, come stilizzato nei modelli di derivazione classico-keynesiana [ link] (Brancaccio, 2012a). Non solo: nel caso di una “deflazione da debiti” la domanda può calare proprio perché si riducono i prezzi (Fisher 1933, cfr. anche Brancaccio, 2012a). Una riduzione dei prezzi è infatti una situazione avversa ai debitori, in quanto aumenta l'onere reale del debito.
Infine, come già accennato, la riduzione dei redditi nei paesi in deficit, se da un lato contribuisce a riequilibrare le bilance commerciali, dall'altro però tende a danneggiare nel medio periodo anche i paesi in surplus e può portare quindi ad un aumento della disoccupazione non solo nei paesi in deficit, ma nell'area valutaria nel suo complesso.
Nell'ambito della teoria, comunque, rimane il “rimedio” della migrazione, analizzato in un successivo paragrafo. E' qui interessante notare che Kenen (1969) arguiva che un'elevata diversificazione produttiva all'interno delle singole regioni costituenti l'area valutaria avrebbe potuto compensare la scarsa mobilità del lavoro. Bini Smaghi e Vori (1992) hanno confrontato la diversificazione produttiva interna dei 12 paesi candidati all'ingresso nella UEM con quella dei 12 distretti della Federal Reserve negli USA. I risultati suggeriscono che da questo punto di vista i primi erano più adatti dei secondi a costituire un'area valutaria. Quanto avvenuto successivamente non sembra confermare l'ipotesi.
Più in generale, la teoria delle AVO si basa su presupposti chiaramente neoclassici: le preferenze del consumatore, la dotazione dei fattori produttivi, l'esistenza di un tasso “naturale” di interesse che equilibra investimenti e risparmi, la teoria quantitativa della moneta. Per questo le politiche che ne discendono sono in larga parte basate su una modifica delle condizioni dell'offerta: mobilità del fattore lavoro e del capitale, flessibilità salariale, maggiore concorrenza per indurre l'abbassamento dei costi.
Per questo motivo la previsione di politiche fiscali quale fattore riequilibratore ha perso centralità negli sviluppi della teoria delle AVO. Ove i paesi componenti l'area valutaria siano “simili” o almeno “convergenti”, si è sostenuto, l'esigenza di politiche fiscali sarà residuale. Ciò ha condotto al limite di concepire l'euro come moneta senza Stato, senza bilancio pubblico e senza deficit. Dopo che la crisi dell'euro è scoppiata, si è tentato di ricondurre la sua spiegazione alla teoria delle AVO, ma con risultati al più poco convincenti, come vedremo in seguito, sebbene oggi prevalenti nel dibattito economico.
3. I “criteri” della teoria delle AVO e l'esperienza dell'area euro
Certamente i paesi che hanno dato vita all'eurozona arrivavano da condizioni di partenza differenti, che non si sono mosse nel senso della “convergenza”, smentendo l'esistenza di aree valutarie ottimali “endogene” (Frankel&Rose, 1998) . Tuttavia anche facendo cadere l'ipotesi di aree valutarie ottimali “endogene”, è difficile ricondurre il fallimento dell'esperienza dell'euro ai “criteri” della teoria.
Secondo questa, infatti, la mobilità dei fattori produttivi e delle merci dovrebbe svolgere un ruolo riequilibratore. Invero, Fleming (1971) metteva in guardia circa i pretesi effetti stabilizzanti del movimento dei capitali, sia pure con argomenti puramente neoclassici. Poco o nulla di tali critiche comunque è stato ripreso nelle analisi successive.
Tuttavia nell'esperienza concreta dell'area euro, la mobilità del capitale ha piuttosto svolto un ruolo destabilizzante, prima con l'afflusso dei capitali verso i paesi periferici, poi con il loro arresto improvviso (“sudden stop”) e infine con il loro ritorno nel Paese di provenienza, che ha causato l'innalzamento dello spread sui titoli pubblici e in generale il deprezzamento di tutti i titoli.
Per quanto si è detto, anche la liberalizzazione dei commerci si è presentata come un fattore di squilibrio. Paul Krugman (1991), che pure sostiene la validità della teoria delle AVO, riconosce che l'integrazione commerciale può portare spontaneamente a fenomeni, con caratteristiche cumulative, di concentrazione e specializzazione produttiva che aggravano gli effetti degli shock. Sempre secondo Krugman, in determinate condizioni la mobilità del fattore lavoro può avere persino effetti avversi sulla convergenza tra le regioni facenti parte di un'area valutaria. Vedremo in effetti nel paragrafo successivo che la mobilità del fattore produttivo lavoro è ben lungi dall'assicurare equilibrio e stabilità all'area valutaria.
Paradossalmente, tariffe sull'importazione di beni e servizi, insieme al controllo sui movimenti di capitale e a politiche neo-protezioniste di sostituzione delle importazioni (che però richiederebbero di abbandonare i divieti riguardanti gli aiuti di stato) avrebbero potuto, se opportunamente disegnate, ostacolare i deficit della bilancia dei pagamenti all'origine della crisi dell'area euro. Ipotizzare meccanismi del genere in un'area valutaria o addirittura in una unione monetaria come è l'euro, sembrerebbe a prima vista assurdo, eppure il controllo dei capitali è esattamente quanto è stato messo in atto durante la crisi di Cipro. A tale proposito vale la pena ricordare che il sistema di Bretton Woods, basato su cambi fissi (sia pure con possibili aggiustamenti), permetteva la presenza di dazi e il controllo dei movimenti di capitali. Queste misure hanno contribuito ad una stabilità finanziaria mai conosciuta, prima e dopo, dal mondo occidentale [ link].
Non è però necessario arrivare a pensare di mettere in pratica il paradosso di un'unione monetaria senza un mercato unico. Quello che qui si intende sottolineare è che l'esperienza dell'area euro mostra piuttosto l'esigenza di meccanismi di riequilibrio che il libero mercato non è in grado di assicurare. Se, ad esempio, tra i criteri di Maastricht fossero stati inseriti meccanismi “automatici” di punizione di surplus prolungati della bilancia dei pagamenti (simili a quelli disegnati per il “bancor” keynesiano) o misure di riequilibrio (si veda, ad esempio, la proposta di uno standard salariale, Brancaccio 2012b), e tali meccanismi fossero stati efficacemente messi in atto, gli squilibri all'interno dell'area euro sarebbero stati con tutta probabilità molto minori di quelli attuali.
La lezione che se ne trae è quindi opposta a quella contenuta nei “criteri” enunciati dalla teoria. In sintesi, quelli che per la teoria delle AVO appaiono come requisiti per la stabilità dell'area, almeno in parte si sono in effetti dimostrati fattori destabilizzanti. Una lezione più generale è che l'idea per la quale il libero commercio sia un gioco in cui guadagnano tutti, alla prova dei fatti ha mostrato di non corrispondere alla realtà.
Tra i criteri della teoria delle AVO, se applicati all'eurozona, sembra comunque corrispondere all'esperienza quello dei differenziali di inflazione avanzato da Fleming (1971). Egli individua nella differenza dei tassi di inflazione, o più precisamente nella curva di Phillips dei diversi paesi aderenti, la causa di differenze di competitività tra i vari paesi, che renderebbero insostenibile l'area stessa nel lungo periodo a seguito degli squilibri nella bilancia dei pagamenti (sulla crisi dell'euro come crisi di bilancia dei pagamenti si veda Brancaccio, 2008; De Grauwe 2012; Cesaratto 2012; Alessandrini et al, 2012).
Si tratta in effetti di un'analisi più problematica. Per risolvere gli squilibri, secondo Fleming sarebbe necessario unificare le politiche monetarie, fiscali, dei redditi, della gestione della domanda e finanche le istituzioni politiche. Ovvero creare un super-stato. In effetti l'eurozona è un'unione monetaria con una banca centrale che gestisce centralmente le politiche monetarie e gli obiettivi di inflazione. Al contrario delle previsioni più ottimistiche, questo non è bastato a ridurre gli squilibri. Rimane quindi tutta in piedi l'esigenza di un (largo) bilancio comune, che è il punto che affronteremo per ultimo.
A proposito di differenziali di inflazione, come anche di produttività, va tuttavia rilevato che divergenze significative possono riscontrarsi anche in territori ristretti, per cui appare complesso definire operativamente un'area valutaria ottimale come un insieme di regioni nel quale l'inflazione è approssimativamente uniforme. A titolo di esempio, nel periodo 2000-2008 (dati Istat) [ link] la differenza media di inflazione tra Sud e Nord-Ovest dell'Italia è stata 2,5 volte quella registrata tra Piemonte e Campania, due regioni rappresentative delle rispettive aree.
Vale la pena infine di ricordare che l'evoluzione della teoria delle AVO ha seguito pari passo quella della teoria neoclassica. Con l'introduzione delle aspettative razionali e della nuova curva di Phillips modificata dal NAIRU (Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment), la stessa teoria può condurre a risultati differenti, tra i quali l'ipotesi di aree valutarie “endogene” che è stata portata a giustificazione della creazione dell'euro. Se da un lato la versione “endogena” della teoria delle AVO è stata screditata dall'esperienza, appare comunque piuttosto debole, sul piano scientifico, una critica all'euro costruita su una versione della teoria delle AVO basata su ipotesi ormai superate nello stesso ambito del paradigma teorico di provenienza della teoria in questione.
4. La mobilità del lavoro in un'area valutaria
Di fronte a queste critiche i sostenitori della teoria delle AVO potrebbero sollevare l'obiezione che l'Europa non costituisce un'area valutaria ottimale poiché in essa è bassa la mobilità del lavoro.
Che la mobilità del lavoro sia scarsa nell'area euro relativamente ad altre aree valutarie come gli USA è un fatto, rilevato da numerose statistiche (tra le più recenti, Gáková & Dijkstra 2008). Ma quali sarebbero gli effetti di una migrazione di lavoratori da, ad esempio, la Spagna, verso, ad esempio, la Germania? Sarebbe questo movimento stabilizzante o destabilizzante? Guardando all'esperienza degli Stati Uniti si può rilevare che lo spopolamento più che decennale dell'area di Detroit a causa della crisi industriale non ha prodotto vantaggi per l'area e lo Stato del Michigan. Al contrario, città e Stato si sono trovate di fronte ad una grave mancanza di entrate fiscali [ link].
Difficilmente una migrazione dalla Spagna alla Germania contribuirebbe quindi a risolvere i problemi della Spagna, mentre l'età media della sua popolazione salirebbe improvvisamente, mettendo in prospettiva a rischio l'intero sistema di welfare nazionale e più in generale il bilancio pubblico (sia pure considerando il temporaneo sollievo costituito da minori spese per i disoccupati) e privando il paese di forza lavoro ed esperienze accumulate.
Più in generale, affermare che la migrazione sia una “soluzione” equivale in ultima analisi a sostenere che il peso delle varie parti appartenenti ad un'area valutaria ottimale può “restringersi” ed “espandersi” (in termini relativi) come risposta agli shock. L'area valutaria diviene così simile ad una “pelle di leopardo”, le cui chiazze tendono a concentrarsi spontaneamente in alcuni punti, generalmente coincidenti con le zone a più alta concentrazione di
6 manifatturiero (Krugman, 1991), grazie a possibili effetti cumulativi del processo migratorio che la Storia conosce, i quali hanno portato al progressivo spopolamento di alcune regioni. Più che condurre al riequilibrio, la migrazione tende a rendere quelle regioni permanentemente dipendenti dai trasferimenti fiscali da parte delle regioni più ricche.
Secondo la teoria delle AVO, invece, il trasferimento di lavoratori dalla Spagna alla Germania favorirebbe il ripristino della situazione di equilibrio, poiché ridurrebbe le importazioni del prodotto tedesco in Spagna. E' tuttavia realistico ipotizzare che l'arrivo di masse di disoccupati spagnoli, alla ricerca di lavoro, avrà l'effetto di abbassare i salari in Germania (o almeno evitarne la crescita), migliorando le condizioni dell'offerta, con conseguente riduzione dei prezzi e quindi aumento della competitività delle merci tedesche. A questo punto invece di un riequilibrio, si avrebbe il permanere della divergenza.
E' interessante a proposito notare che, stando a Mundell (1961), la Germania avrebbe dovuto soffrire una maggiore inflazione a causa dell'accresciuta domanda da parte degli spagnoli: la deflazione successiva sarebbe perciò parte dell'aggiustamento. Ma, come abbiamo già accennato, il meccanismo che ha prodotto gli squilibri è legato proprio alla deflazione tedesca relativamente alla periferia dell'eurozona. I meccanismi di aggiustamento indicati dalla teoria, basata su ipotesi di equilibrio generale, non sembrano quindi capaci di offrire una soluzione.
La mobilità del fattore lavoro non rende per quanto detto l'unione valutaria più stabile e in ultima analisi meno dipendente dalla presenza di un largo bilancio pubblico “federale”. Al contrario, si renderebbe ancor più necessario centralizzare la spesa pubblica, o prevedere importanti trasferimenti per evitare il fallimento delle finanze locali.
Riguardo le cause della scarsa mobilità del lavoro nell'eurozona, ci si può chiedere legittimamente se essa sia dovuta al permanere, nonostante tutto, di sistemi di welfare e alla scarsa disponibilità all'estero di lavori ben retribuiti, tali da indurre ad abbandonare il proprio paese (ricordiamo tra parentesi che circa un quarto dei lavori in Germania attualmente sono sottopagati). Poco convincenti d'altra parte appaiono spiegazioni “idealistiche”, come le barriere culturali e linguistiche. Difatti, mentre i lavoratori Europei sono restii a muoversi, l'eurozona ha accolto milioni di extracomunitari, con religioni, lingua e abitudini molto differenti da quelle Europee, per quanto in diversi casi non si presenti lo svantaggio della lingua (p.e. immigrati dalle ex-colonie francesi).
5. Cosa rende stabile un'area valutaria?
Se queste critiche sono fondate, allora non rimane che concludere che un'area valutaria può sopravvivere a shock asimmetrici nella misura in cui essa corrisponda ad uno stato sovrano con un bilancio pubblico abbastanza largo (sebbene la Storia mostri che motivi di varia natura possano determinare la rottura dell'area anche in questo caso). A tale conclusione sono giunti pur da approcci diversi Godley (1992) e Goodhart (1998).
E' in definitiva la presenza di un bilancio pubblico “federale” il motivo per cui un'area valutaria può mantenersi stabile. Goodhart, seguendo l'ipotesi “cartalista”, sottolinea che, essendo lo Stato all'origine della valuta stessa, è difficilmente immaginabile un'area valutaria che non corrisponda ad uno stato sovrano. Con un approccio più classicamente keynesiano, Godley spiega che in caso di caduta della domanda in un paese membro, il bilancio pubblico federale automaticamente porta risorse ove necessario, attraverso sussidi di disoccupazione e altri strumenti di welfare, mentre i cittadini di quell'area pagheranno meno tasse poiché il reddito complessivo sarà diminuito e mentre i dipendenti dello stato federale continueranno a consumare perché i loro redditi non verranno intaccati dalla crisi locale.
A queste, si può aggiungere l'ulteriore necessità che il bilancio pubblico “federale” realizzi ampi deficit spending, ove necessario finanziati dall'emissione monetaria della banca centrale, condizione questa costituzionalmente negata dai trattati che regolano l'Unione Europea e l'euro; l'autorità monetaria dovrebbe essere investita del dovere assicurare in ogni caso la solvibilità del sistema finanziario (in primo luogo come “prestatore di ultima istanza”) e garantire i titoli del debito pubblico.
Il ruolo centrale dello Stato per la stabilità di un'area valutaria, progressivamente messo in ombra nello sviluppo della teoria delle AVO, sembra quindi l'elemento effettivamente rilevante, mentre i “criteri” rimanenti non appaiono suffragati dall'analisi della crisi dell'euro né da altre evidenze o, nella migliore delle ipotesi, possono essere ritenuti al più complementari. A tal proposito è interessante notare che, a rigore, nessun paese potrebbe essere un'area valutaria ottimale. Differenze di inflazione e produttività, anche notevoli, sono infatti riscontrabili all'interno di qualunque stato e persino all'interno di aree geografiche ristrette. In molti casi (l'Italia, ad esempio) anche il tasso di interesse presenta notevole variabilità, mentre la flessibilità “perfetta” di salari e prezzi non si riscontra mai nella realtà, neppure in paesi con un alto grado di deregolamentazione del mercato del lavoro. Come esempio basterà qui notare che gli stessi Stati Uniti non sono un'area valutaria ottimale nel loro complesso (Kouparitsas 2001), come del resto lo stesso Mundell ipotizzava.
6. Conclusioni
Il peccato “originale” dell'euro, la mancanza di uno stato federale con un largo bilancio pubblico e riequilibratori automatici, non ha nella teoria delle AVO quel ruolo centrale che invece l'esperienza della crisi dell'euro sembra chiaramente indicare. Un'analisi critica porta a concludere che i “criteri” da essa enunciati sono in larga parte superflui, quando non addirittura in contrasto con le evidenze che la crisi dell'eurozona presenta. D'altra parte, i “criteri” non descrivono neppure le aree valutarie realmente esistenti, magari da lungo tempo, come gli Stati Uniti.
La Teoria delle Aree Valutarie Ottimali ha cioè diluito progressivamente il fatto realmente rilevante (la presenza di uno Stato e di un bilancio pubblico associati alla valuta) all'interno di un insieme di criteri variegato e persino contraddittorio. Essa non solo non sembra capace di spiegare la crisi dell'euro, ma può essere utilizzata come giustificazione del suo attuale assetto.
Largamente basata su fondamenta neoclassiche sin dalle origini, la teoria delle AVO sembra quindi avere un obiettivo più prescrittivo che descrittivo, mentre le sue conclusioni di politica economica possono facilmente rivelarsi controproducenti oltre che socialmente insostenibili.






































Add comment